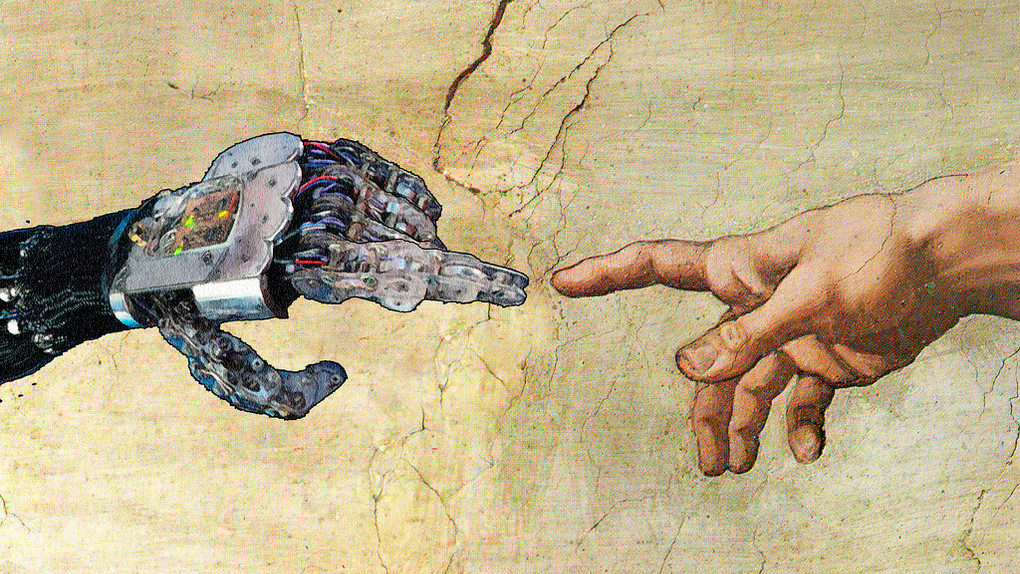Giovanni Meli poeta arcadico? Molto di più: intellettuale intelligente e acuto che non esitò a schierarsi a favore della libertà di espressione
In vita fu il più popolare dei poeti. Il contemporaneo Domenico Scinà poteva scrivere che, ancora prima d’essere stampate, “le sue canzonette correvano per le bocche di tutti, si cantavano nelle compagnie e nelle vie pubbliche”.
Poi fu autore da antologia, sempre più fuori moda. Infine venne del tutto dimenticato. Il bicentenario della morte di Giovanni Meli, il prossimo 20 dicembre, è quindi l’occasione per riscoprire un poeta dalla vena facile e musicale, maestro nei bozzetti agresti, che scrive in un siciliano mai volgare trasformandolo in lingua letteraria. Sembrerebbe un poeta inoffensivo, come mai è un vero poeta. E infatti basta avvicinarsi solo un po’ per osservare un uomo calato nel suo tempo, che ne vive tutte le passioni, moderno in maniera sorprendente.
Tutta la vita di Meli trascorre a Palermo e nelle sue immediate vicinanze. Nasce nel 1740 da una famiglia del ceto medio: il padre è orefice, può permettersi di farlo studiare nel collegio dei gesuiti ma il ragazzo si interessa alla natura e alla poesia piuttosto che alla metafisica. Diventa dottore in medicina senza mai scordare i poeti prediletti, soprattutto Ariosto: pare che addirittura sognasse di comporre ottave, e l’indomani correva a scriverle. Diventa medico condotto di Cinisi – terra dei padri benedettini di San Martino delle Scale – e vi trascorre cinque anni, dividendo la giornata fra i doveri e la passione per la letteratura.
Non ha ricevuto gli ordini sacerdotali ma veste di scuro con un collarino bianco, per tutti diventa “l’abate Meli”: compone versi su argomenti astrusi come i rapporti tra fede e ragione, non disdegna però le poesiole alla moda e diventa il beniamino della buona società. Il principe di Campofranco lo accoglie nel suo palazzo, dove si riunisce l’Accademia della galante conversazione, che già nel nome richiama gli scandalosi libertini europei. Come dire che adesso il giovane poeta Giovanni Meli ha tutti gli occhi puntati addosso, ed entra in scena nella maniera più eclatante. A Palermo è in corso una sfida tra i gesuiti, che rappresentano il fronte degli antichi, e altri Ordini più inclini alla filosofia moderna. Nel 1756 il massone Tommaso Natale ha pubblicato un libretto che tenta di tradurre in versi la complessa filosofia di Leibniz, e i gesuiti ne ottengono la condanna dall’Inquisizione: le copie stampate vengono distrutte, è guerra aperta. Giovanni Meli si schiera senza esitazioni. Scrive una sorta di manifesto in versi, una sfida irridente che mette in ridicolo gli avversari: il poemetto intitolato La fata galanti illustra la vittoria dei galanti sui pedanti, viene letto nelle sedute della “galante conversazione” e ha gran successo.
Sono anni in cui la cultura siciliana è tutta raccolta in chiostri e seminari, la lotta per la diffusione dei nuovi orientamenti filosofici di marca illuminista è senza esclusione di colpi. Benedettini, francescani e domenicani sono schierati contro i gesuiti che a Monreale, ribattezzata “cittadella della metafisica”, hanno la loro roccaforte e nel filosofo Vincenzo Miceli hanno trovato il loro campione. Miceli esalta l’ortodossia cattolica, ha l’impegnativo compito di opporre dighe ideologiche all’invasione della modernità e tenta la creazione di un nuovo sistema filosofico. Che è puntualmente messo in ridicolo da Meli: fra il 1768 e il ’70 il poeta scrive il “romanzo filosofico” L’origini di lu munnu, giudicato da Francesco De Sanctis un capolavoro satirico pieno di brio, dove l’insofferenza per i nebbiosi misteri della metafisica diventa critica feroce.
Ma Giovanni Meli non è solo un poeta dalla vena facile. Studia da autodidatta la filosofia francese, segue Jean Jacques Rousseau e il suo ritorno alla natura; poi fonde assieme gli influssi d’oltralpe, vi aggiunge i temi dominanti della poesia popolare siciliana che sempre parlano d’amore e ne ottiene un’originale poetica, che porta al più alto grado il siciliano letterario. Ha però un gran senso del ridicolo, ed è capace di sorridere anche delle nuove idee che diventano moda. Nel 1770 scrive Villeggiatura, sulle smanie di chi fra i bagagli mette anche gli autori proibiti: “c’è Voltier! C’è Russò! … la signurina li capisci sti libbra ch’aju dittu?”
La produzione di Giovanni Meli è vasta, riflette il multiforme spirito dell’epoca. Nel 1787 il poeta ottiene la cattedra di chimica nella palermitana Accademia degli studi, nello stesso anno pubblica la sua opera in cinque volumi: la Buccolica è il componimento più conosciuto, che interpreta la nuova sensibilità europea già romantica con pastori e contadini in armonia con la natura amica. Accanto alla Buccolica troviamo due opere non meno importanti: il Ditirammu, dove il protagonista Sarudda brinda alla statua di Palermo, nella piazza della Fieravecchia, in ricordo del glorioso passato; e il Don Chisciotti e Sanciu Panza, di cui Foscolo tradusse in italiano il monologo lirico. Nel Don Chisciotti Meli riserva a se stesso la parte di Sancio e il poema si trasforma nell’apologia del nuovo pensiero sociale: compaiono pastori e villani realistici, di cui il poeta scrive “Siti li basi di città e casteddi / Siti lu tuttu, ma ‘un n’aviti làusu / l’ingrata società scorcia e maltratta / Lu pettu unni si nutri e unni addatta”.
I versi del Don Chisciotti anticipano le Riflessioni sullo stato presente del Regno di Sicilia, risalenti al 1801 ma pubblicate postume nel 1896 da Giuseppe Navanteri. È una sorta d’inchiesta su una terra dove è sparita ogni armonia: “il primo aspetto della maggior parte de’ paesi e dei casali annunzia la fame, e la miseria: non si trova da comprare né carne né caci, né pane… il dippiù de’ villani e de’ bifolchi si nutrono d’erbe e di legumi… non s’incontrano che facce pallide sopra corpi macilenti”. È la Sicilia delle carestie prodotte dalle speculazioni sul prezzo del grano, un Regno senza industrie né marina dove gran parte degli abitanti sono improduttivi. E Giovanni Meli, il più moderno dei siciliani, scrive “intendo parlare di tutto quell’immenso numero di parassiti, di cui abbondano le città del Regno e specialmente la capitale, che si nutrono del sangue e de’ sudori degli uomini onesti e industriosi”.
Altro che innocuo poeta arcadico.