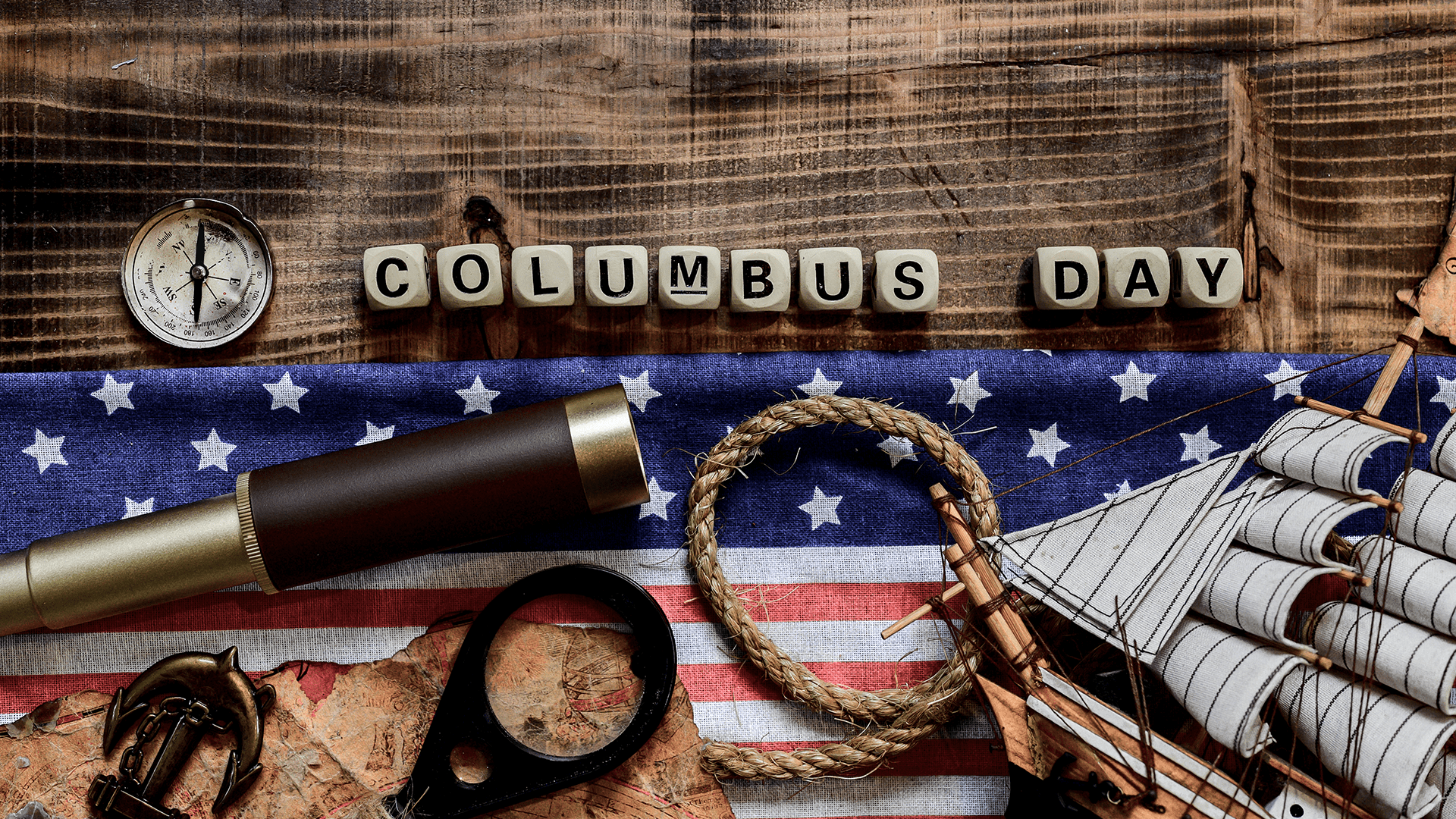Nord e Sud nell’unificazione nazionale
Dati e falsi miti di uno dei periodi più dibattuti dagli storici
Gode di largo credito la tesi per cui si sarebbe creata nel 1861 una subordinazione economica del Sud, ridotto a “mercato coloniale” per le industrie del Nord, in conseguenza di una minorità politica sancita dal centralismo amministrativo italiano.
La tesi non convince. Nel Sud preunitario come in quello postunitario, toccò al mercato internazionale (esportazione di prodotti agro-alimentari, per la Sicilia di zolfo) il ruolo di grande o unico incubatore di sviluppo; quanto al centralismo amministrativo, si accompagnò all’idea del governo illuminato in periodo in periodo borbonico come in periodo unitario-liberale.
Non emergono gravi squilibri regionali di reddito dai risultati recentemente conseguiti dal gruppo di studio coordinato da Vecchi, dai lavori di Felice, e di vari altri: il vantaggio del Nord era modesto intorno al 1870, e sarebbe cresciuto di poco verso la fine del secolo XIX. Il meccanismo della differenziazione dualista accelerò soltanto dopo, a notevole distanza di tempo dall’unificazione: dunque non fu quest’ultima a metterlo in moto. Piuttosto è vero che nel tempo medio cominciarono a pesare maggiormente a svantaggio del Sud fattori preesistenti al 1861: la minore disponibilità di terreni pianeggianti, risorse idriche, vie di comunicazione; la lontananza fisica dai mercati europei; la bassa produttività media dell’agricoltura; il bassissimo livello di alfabetizzazione.
La grande discontinuità del 1861 fu politico-istituzionale o, se vogliamo usare il termine crociano e gramsciano, etico-politica. Molti dei contemporanei pensavano che una rivoluzione politica dovesse avere un corollario economico e sociale. Fu questo il terreno, negli anni 1870, della prima discussione sulla questione sociale: che vide emergere le grandi figure di Pasquale Villari, di Sonnino, di Franchetti. Questa non può essere ridotta alle polemiche dei primi anni ’60 sulla “piemontesizzazione”, dovuta da un lato al collasso dello Stato meridionale e dall’altro alla messa fuori gioco dei democratici ex-garibaldini, tra cui erano gli elementi più vivaci del Mezzogiorno, o che guardavano con simpatia al Mezzogiorno. Non può perché l’adozione di un sistema rappresentativo consentì in breve tempo alle élite delle varie periferie, al nord, al centro e al sud del Paese, di concorrere alla formazione della volontà politica come non era avvenuto in nessuno degli Stati pre-unitari – e meno che mai nel Regno delle due Sicilie.
Va piuttosto segnalato un paradosso. Come detto, lo sviluppo economico regionale fu equilibrato nell’età della Destra (1861-1875), il gap prese a manifestarsi in quella della Sinistra e si definì chiaramente al passaggio del secolo. Eppure i governi della Destra furono a chiara egemonia centro-settentrionale, mentre quelli della Sinistra videro crescere nettamente la componente meridionale.
In particolare toccò per lungo tempo al napoletano Magliani la guida sotto Depretis della politica economica. Seguì, a partire dal 1887, il periodo che vide il siciliano Crispi indiscusso numero uno della politica italiana, essendo il suo maggior competitore l’altro siciliano Rudinì. Io ne trarrei una conseguenza: la mutevole influenza politica delle élite regionali non rappresentò una variabile apprezzabile per lo sviluppo economico regionale. Nessun modello coloniale.
Del termine rivoluzione, gli attori della nostra storia fecero largo uso: in accezione positiva i democratici, in accezione negativa i legittimisti e i conservatori. Più sfumata la posizione dei liberali moderati, che della rivoluzione si proponevano di trarre vantaggio ma di cui (in Italia come dappertutto) avevano paura, e in generale temevano la politicizzazione popolare. Alla fine, come si sa, furono questi ultimi a vincere: e dopo la loro vittoria il termine rivoluzione cadde in disuso a favore del termine Risorgimento, idea di un moto politico e ideale concorde che di per sé implica gravi rimozioni degli aspetti più conflittuali del processo storico-politico reale. Oggi, poi, il concetto di rivoluzione non è molto in auge tra gli storici. La sua crisi chiama in causa l’espressione guerra civile, presente anch’essa nel linguaggio dei protagonisti ma sempre in accezione negativa, come a esprimere un rischio catastrofico. Per i patrioti sia moderati che democratici, l’elaborazione di quest’ultimo concetto risultò quasi impossibile, e la storiografia ha potuto cominciare a fare con esso i conti solo di recente.
Andrebbe meglio applicato nella pratica storiografica un concetto che sembrerebbe in teoria ormai acquisito: il patriottismo ama rappresentarsi come il tutto, ma in realtà rappresenta una parte. L’arcinemico è nel nostro caso l’austriaco oppressore, lo straniero che però ha sempre sostenitori o complici locali, detti austriacanti, da odiarsi quanto e più di lui. Peraltro il patriottismo risorgimentista, ostile all’assolutismo in entrambe le sue versioni (moderata e democratica), finì dopo il 1848 con l’andare a una rottura di lunga durata anche con la Chiesa romana, donde l’esclusione dei clericali. Esclusi furono poi le varie dinastie italiane, gli antichi stati e i loro fautori, man mano che i patrioti elevavano al rango di dinastia nazionale i Savoia e puntavano alla costruzione di un unico Stato-nazione.
Il cuore della nostra storia si colloca all’incrocio tra patria e libertà, la soluzione vincente fu quella in grado di garantire una patria e insieme (una forma di) libertà. Dico questo perché al 1820, al 1830 o al 1848, e persino nel 1860-61, quella pan-italiana non era l’unica idea di patria possibile. Lasciando pure da parte (ma solo per brevità di discorso!) le idee municipali di patria, così espressive della lunga durata della nostra storia, possiamo dire che oltre a quello pan-italiano erano in campo, nell’Italia del Sud, due possibili patriottismi: quello napoletano, che si identificava col borbonico Regno delle due Sicilie, e quello siciliano, che lo contestava alla radice sin dal 1815. Il gioco si fece più serrato nel 1860, quando il patriottismo italiano sbarcò materialmente nel Sud insieme a Garibaldi, innanzitutto per sostenere l’ennesima insurrezione siciliana.
Il regime borbonico ne fu travolto, e con esso la patria napoletana. Però almeno sino al 1863 e magari al 1865 rimasero in armi gli elementi filo-borbonici che diedero vita alle “insorgenze” e al cosiddetto “grande brigantaggio”. Si trattò di una guerra da definirsi in ogni caso civile: perché a rivolgere le armi gli uni contro gli altri furono non solo meridionali e “piemontesi”, ma anche meridionali e meridionali, arrivando a molti degli eccessi che si consumano in casi di questo genere. Il libro recente di Pinto dice molto bene di questa vicenda.

Salvatore Lupo
A un secolo e mezzo dagli eventi, non possiamo sentirci patriotticamente impegnati, come i nostri bisnonni, a ignorare l’esistenza di conflitti di questa natura nella stagione dell’unificazione. Nemmeno, però, possiamo indulgere a revisionistiche indignazioni perché del sangue fu versato: come fanno oggi neo-borbonici o neo-legittimisti ansiosi di contrapporsi a una storia “ufficiale” che – a loro dire – tutto questo avrebbe censurato. In realtà costoro ripropongono inconsapevolmente, con un secolo e mezzo di ritardo, lo scandalo della cultura patriottica ottocentesca che guardava alla guerra civile come a un peccato imperdonabile quanto il fratricidio.
Ovvero addebitano in esclusiva le durezze della repressione allo straniero piemontese, alle sue logiche semi-coloniali. Invece fu anche una larga parte delle classi dirigenti del Mezzogiorno continentale a chiedere al nuovo governo una pronta e dura repressione del brigantaggio, una restaurazione dell’ordine sociale, nonché il consolidamento di un nuovo ordine politico.
Ce n’era bisogno dopo un cinquantennio in cui la dinastia borbonica non era riuscita a conseguire alcuna duratura stabilizzazione, reagendo al ripetersi dei tentativi insurrezionali con un’alternanza di opportunistiche concessioni e dure repressioni. L’incapacità o l’impossibilità di portare ai suoi termini la transizione politica era andata a complicare i nodi sociali di un’incerta transizione post-feudale, essendo da questi aggravata. Ne derivò un’area grigia nella quale la politica confinava con la criminalità, e in cui si collocò in una certa misura la mobilitazione dei soggetti popolari, sia sul fronte rivoluzionario che su quello reazionario.
Così quel cinquantennio di scontri lasciò in eredità al nuovo regime ideali generosi, importanti esperienze di partecipazione collettiva, spinte verso il progresso, ma anche un problema di ordine: che era strutturale, e non solo politico.
L’Italia mostrò dunque nel Sud immediatamente post-unitario un volto pesantemente repressivo; il che non vuol dire che lo abbia anche dopo mantenuto, come da taluni si vorrebbe. Le leggi eccezionali vennero abrogate, le procedure normalizzate, le armi riposte, l’esercito rientrò nelle caserme, i guerriglieri legittimisti tornarono a casa o andarono in prigione, i garibaldini divennero monarchici o tornarono repubblicani, aderirono alla Sinistra storica o all’Internazionale.
Molti studiosi e osservatori credono di poter arguire un fallimento di lunga durata dell’idea stessa di Stato nazionale dal tasso di renitenza alla leva, che fu in effetti molto alto nel momento della prima leva meridionale, nel 1863: ma va detto (e spesso non si dice) che da quell’11% si scese al 5,8 già l’anno successivo, e ci si attestò al di sotto del 4% dopo il 1870. Rimase ben più a lungo, in certe aree geografiche e sociali, il gap di statualità che chiamiamo mafia: pensiamo però anche che questa parola nuova nasce da un’esigenza di legalità nuova, bisognosa di stigmatizzare, chiamandoli per nome, abusi ora divenuti inammissibili.
Alla fine, in un tempo abbastanza breve, si stabilì un ordine durevole, che fece contrasto con il durevole disordine del cinquantennio o del sessantennio precedente.
Testi citati
- Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna 2013. C. Pinto, La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti, 1860-1870, Laterza, Roma-Bari 2019. G. Vecchi (a cura di), In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità a oggi, il Mulino, Bologna 2011. Per il resto devo rimandare a due miei lavori. S. Lupo, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, Donzelli, Roma, 2011. S. Lupo, La questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi, Donzelli, Roma, 2015.