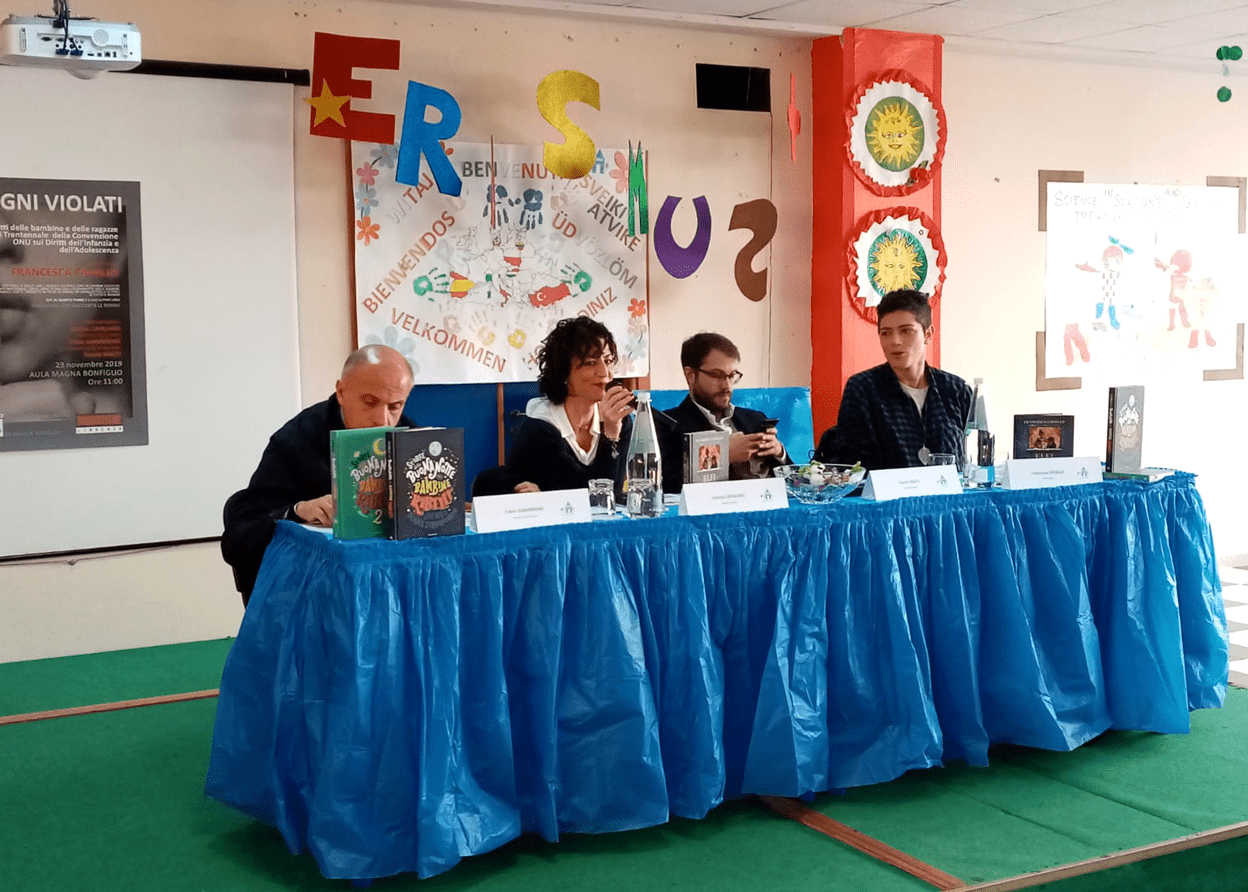Assistere alla violenza subita dalla madre crea danni al sistema nervoso dei figli: parola di neuroscienza
Uno studio del Cnr di Roma e della Harvard Medical School conferma che gli effetti dei maltrattamenti si ripercuotono drammaticamente sui minori presenti in casa
Se picchia la moglie non è un buon marito, ma non è nemmeno un buon padre: perché la violenza domestica non riguarda solo l’uomo e la donna. Se in casa sono presenti i figli anche loro saranno coinvolti dagli effetti dei maltrattamenti subiti dalla madre, e in misura maggiore rispetto a quello che si possa pensare.
Quello che succede a un minore che assiste ad abusi in famiglia si riscontra, a livello cerebrale, nell’ interruzione delle vie di comunicazione tra la parte del cervello riservata all’area visiva e il sistema limbico che è deputato all’aspetto emozionale. Lo dimostra l’esperimento su un gruppo di adolescenti condotto dall’Harvard Medical School e studiato dal neurofisiologo Marco Pagani, primo ricercatore dell’Istituto di scienze e tecnologie delle cognizione del consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Roma.
Gli esiti della ricerca hanno confermato che i soggetti esposti per lungo tempo ai maltrattamenti di un componente della famiglia subiscono un’alterazione del sistema nervoso centrale: per reprimere il dolore causato dall’essere testimoni di tale violenza, la visione dell’abuso interrompe il canale deputato all’elaborazione delle emozioni rispetto a ciò che si vede. L’esposizione prolungata a questo tipo di vessazione indiretta crea danni maggiori della violenza direttamente subita, innescando così tutti quei meccanismi di negazione che sono alla base di molte patologie, come la dissociazione e il trauma complesso.
Lo studio non tralascia nemmeno l’aspetto della violenza verbale e anzi conferma che minacce, offese e mortificazioni del padre nei confronti della moglie vengono percepite dai figli in maniera di gran lunga più pericolosa rispetto alla violenza fisica.
«La percezione che può avere la donna del trauma subito dai figli è però ridotta – ha spiegato la psicoterapeuta Anna Immordino – perché lei è già in uno stato di disagio, propensa ad adattarsi alla situazione anziché reagire. Figuriamoci come possa comprendere i bambini».
 In casa sono presenti minori? È questa la domanda che le operatrici dei centralini antiviolenza pongono immediatamente alla donna che chiede aiuto. Anna Immordino, psicoterapeuta del centro “Le Onde Onlus”, spiega infatti che, seguendo il cosiddetto “piano di valutazione del rischio” (leggi qui per un approfondimento), l’intenzione è iniziare a rendere consapevole la madre degli effetti che la violenza da lei subita possa avere sui suoi figli. Non è uno step facile da affrontare. La maggior parte della richiedenti aiuto, infatti, negherà che i bambini fossero presenti in casa al momento del litigio o che abbiano potuto sentire qualcosa perché al momento della violenza si trovavano in stanza a giocare. È solo l’ennesima negazione a se stesse. I bambini ascoltano e vedono tutto ciò che accade attorno a loro.
In casa sono presenti minori? È questa la domanda che le operatrici dei centralini antiviolenza pongono immediatamente alla donna che chiede aiuto. Anna Immordino, psicoterapeuta del centro “Le Onde Onlus”, spiega infatti che, seguendo il cosiddetto “piano di valutazione del rischio” (leggi qui per un approfondimento), l’intenzione è iniziare a rendere consapevole la madre degli effetti che la violenza da lei subita possa avere sui suoi figli. Non è uno step facile da affrontare. La maggior parte della richiedenti aiuto, infatti, negherà che i bambini fossero presenti in casa al momento del litigio o che abbiano potuto sentire qualcosa perché al momento della violenza si trovavano in stanza a giocare. È solo l’ennesima negazione a se stesse. I bambini ascoltano e vedono tutto ciò che accade attorno a loro.
Il lavoro svolto dai centri di ascolto è quindi duplice: recuperare l’autostima di una donna oltraggiata nella sua dignità di essere umano, e poi tessere nuovamente la sua capacità genitoriale scardinando dalla mente la diffusa opinione che, in fondo, se non ha picchiato i figli è un buon padre.
In Italia ancora oggi la problematica legata alla violenza assistita è trattata come mero inasprimento delle sanzioni penali, così come prevede l’aggravante di cui all’articolo 61 del codice penale. La portata della locuzione “in presenza di un minore” infatti, introdotta con l’intervento legislativo – L.119 del 2013 – contro il femminicidio, assume purtroppo una valenza minore rispetto al reale e complesso fenomeno che la riguarda. L’idea di fondo sembra essere quella di trattare la violenza assistita con scarsa ponderazione e come un temporaneo allarme sociale messo a tacere con la previsione di un’aggravante ad hoc. Nella realtà dei fatti, gli strumenti necessari per porre rimedi in chiave preventiva passano tra i banchi di scuola, dove le insegnanti possono registrare i primi segnali di malessere dell’alunno che subisce violenza assistita.
«Gli effetti sui bambini sono osservabili dai primi anni di frequenza della scuola – spiega Immordino – perché c’è una compromissione nello sviluppo dei meccanismi di regolazione emotiva per cui alcuni bambini che non regolano le emozioni nelle relazioni con gli altri bimbi, nelle competenze del linguaggio, e in base alla fascia di età osserviamo delle reazioni differenti».
In base a questi campanelli di allarme è necessario quindi che i docenti per primi siano preparati a decodificare tali indicatori e avvertire così gli organi competenti per un intervento tempestivo. Spesso, però, la mancanza di fondi per sostenere dei progetti strutturati di formazione del personale docente all’interno delle scuole non riesce a fronteggiare le esigenze la rete E.I.A.M – gruppo interistituzionale abuso e maltrattamento – che pertanto viene impegnata a danno già conclamato, cioè quando si è in situazione di estrema emergenza e il tribunale dei minorenni affida l’incarico.
La scuola è, quindi, il primo tassello da inserire nella ricostruzione del puzzle emotivo di un bambino che vive in un contesto familiare violento. A ricordare però che i maltrattamenti e gli abusi non sono una faccenda esclusiva dei ceti definiti meno abbienti della società è un’operatrice che lavora sul campo, Mariangela di Gangi del Laboratorio Zen Insieme di Palermo, secondo cui la violenza è trasversale.
E in questo periodo di quarantena in cui manca la scuola, che è il contesto protetto in cui i bambini possono sperimentare una sensazione di allentamento della tensione familiare, soprattutto quando sono piccoli, l’unico mezzo per poter fuggire dalle maglie della violenza assistita è affidato alle loro stesse madri che troveranno nei centralini antiviolenza le chiavi di uscita dal tunnel.