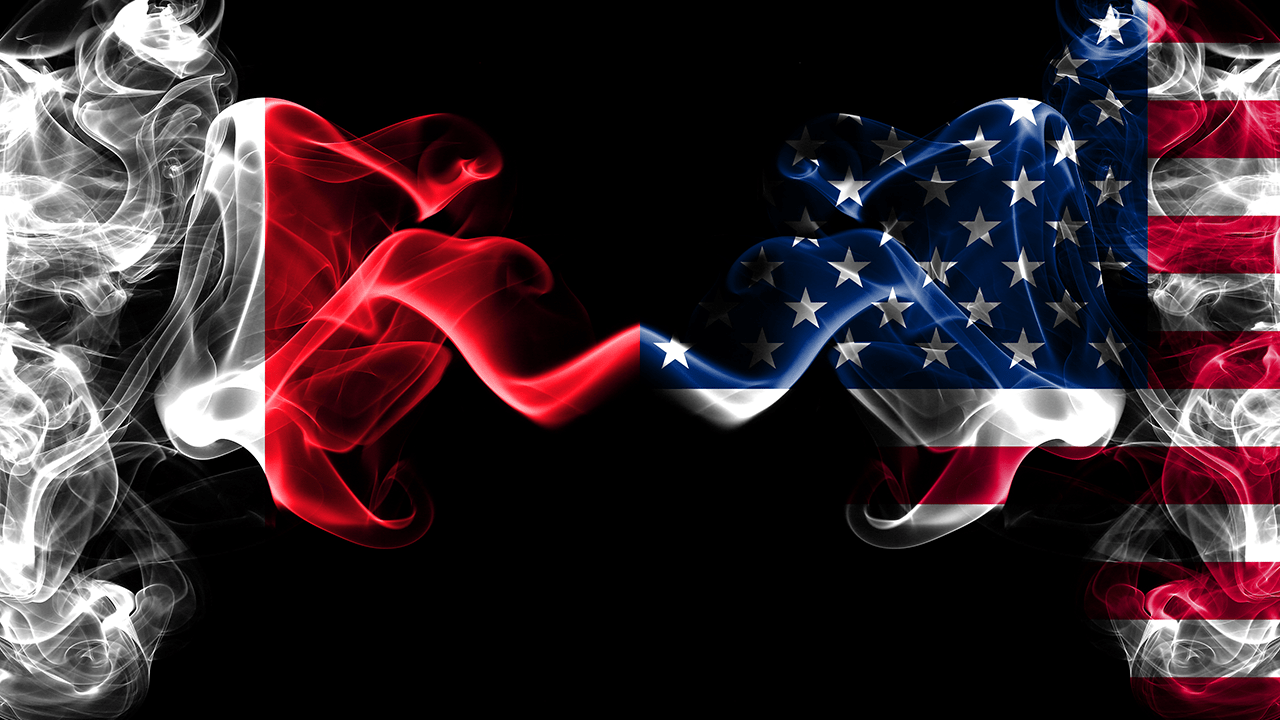Per una nuova storia politica delle rivoluzioni
Presentiamo qui, in anteprima, l’introduzione di Francesco Benigno, docente di Storia Moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa, al volume “Rivoluzioni. Tra storia e storiografia”, pubblicato a breve da Officina Libraria.
Necessità spontanea o opera di “professionisti”? Le mille sfumature di un concetto che continua a fare discutere
Concepita come un’inderogabile fase di passaggio nella crescita collettiva, snodo decisivo dello sviluppo sociale, la rivoluzione è stata a lungo l’astro più brillante del firmamento concettuale storiografico.
Modellata sull’archetipo della Rivoluzione francese, essa si è incarnata in eventi grandiosi, pensati come giunture obbligate, punti di svolta necessari all’affermazione della modernità, situati al cuore di una visione evolutiva della storia come progresso crescente scandito da stadi o tappe. La stessa espressione “rivoluzione”, quanto mai polisemica, ha acquisito grazie a ciò un’enorme valenza egemonica, ed è stata usata ben al di là dei confini del mutamento politico-sociale e istituzionale. Divenendo una sorta di passepartout, un termine usato per indicare il più generale cambiamento culturale, economico e scientifico. Senza dire poi che questo concetto è diventato stabilmente cardine di ogni discorso della sfera pubblica per illustrare il bisogno di trasformazione collettiva: ciò sia da parte della storiografia, tanto liberale quanto marxista, sia da parte dei teorici della modernizzazione. Soprattutto, essendo parte cruciale del richiamo ideologico socialista, ha costituito un riferimento indispensabile della società nuova da costruire, quell’avvenire radioso simboleggiato dalla figura del sole nascente.
Sul finire del XX secolo – con il fallimento conclamato dell’esperienza comunista sovietica e l’esaurirsi del socialismo come linguaggio politico della decolonizzazione – l’idea di rivoluzione è venuta appannandosi. Mentre trionfava un uso universale del termine per indicare il mutamento impersonale prodotto dalla diffusione dell’innovazione tecnologica (la cosiddetta “rivoluzione digitale”), la sua percezione come passaggio politico imprescindibile per la vittoria del moderno sulle pastoie costipanti dell’arretratezza si esauriva. E ciò proprio mentre emergevano dubbi consistenti sulla sostenibilità di uno sviluppo illimitato e inarrestabile e si moltiplicavano gli aggettivi volti a meglio definirlo (“sostenibile”, “bilanciato”, “eco-compatibile” etc.). La rivoluzione, così, finiva per eclissarsi, e ciò sia nella percezione corrente sia nella pratica storiografica. Essa, com’è stato notato, diveniva ormai, sul finire del XX secolo, un concetto «inflazionato, usurato e inquinato ideologicamente, di cui non è più evidente né il soggetto, né la vocazione storica né la dinamica oggettiva».
In quello scenario, gli avvenimenti storici che erano stati qualificati come rivoluzioni, sottratti a tanto schematismo interpretativo, rivelavano inaspettate possibilità di essere riletti e reinterpretati. Fuoriuscendo dalle costrizioni di una categoria ingombrante (che li aveva non solo separati ma contrapposti alle rivolte, alle sollevazioni e alle ribellioni, a lungo considerate solo tentativi abortiti o al più meri antecedenti) potevano infatti essere ripensati e ristudiati reimmergendoli nel variegato universo del conflitto politico armato. Soprattutto, tale mutamento avveniva in un clima culturale in cui veniva crescendo la consapevolezza dell’importanza della storia concettuale, e si introduceva perciò nel lavoro storiografico una maggiore riflessività.
Gli storici, come altri scienziati sociali, erano costretti, in altre parole, ad abbandonare il camice bianco di scienziati sociali che conferiva loro (presuntamente) uno statuto epistemico diverso e privilegiato rispetto a quello dei propri attori storici, messi a distanza, oggettivati e studiati come campioni da laboratorio; ritrovandosi invece ad essere produttore di discorsi non dissimili dai loro, anche se, certo, deontologicamente controllati. L’avere scoperto la pesantezza delle influenze ideologiche e degli schemi interpretativi sovraimposti, largamente denunciati dalle polemiche revisioniste, consentiva così uno sguardo nuovo, potenzialmente più ricco e più fresco su vicende, le rivoluzioni, lungamente rinchiuse entro modelli asfittici. Soprattutto, le identità politiche apparivano non più il riflesso obbligato di soggiacenti divisioni economico-sociali, ma un campo autonomo, dotato di una distinta dialettica che mescolava in una dimensione processuale passioni ed interessi, dando vita a una coalescenza sociale mutevole, non obbligata.
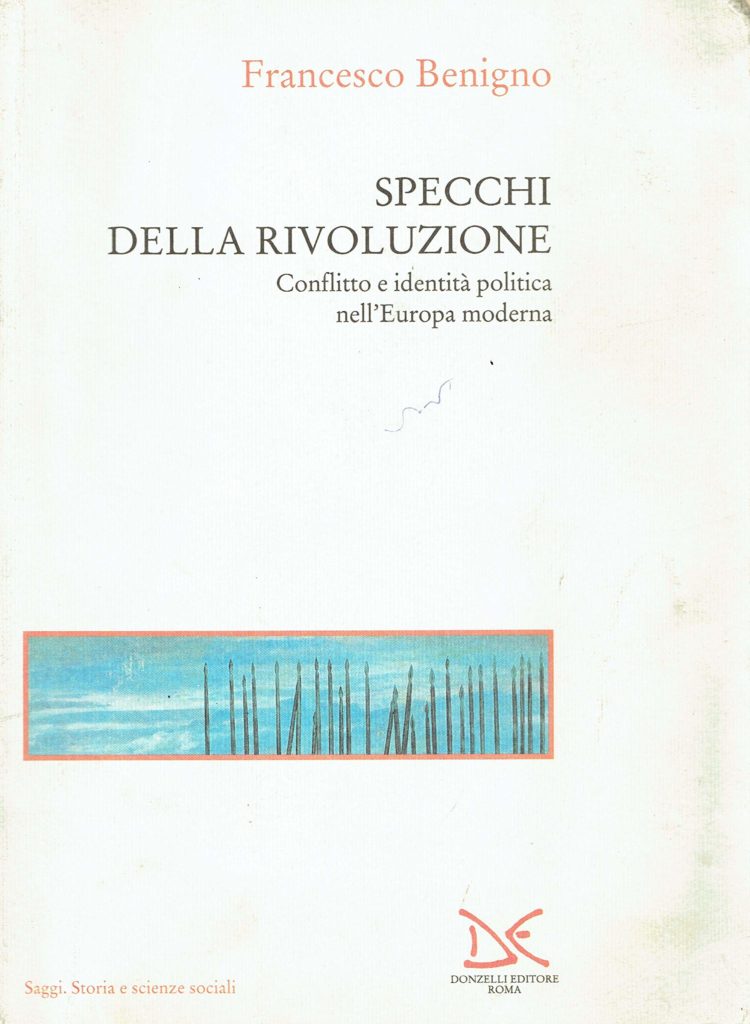 È in questo clima intellettuale che prendeva corpo il mio volume del 1999, “Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell’Europa moderna”, cui questo libro si riconnette idealmente. Raccolgo infatti qui una serie di saggi e interventi sul tema apparsi da allora su riviste o in volumi collettanei, alcuni dei quali di difficile reperibilità. Anche in questo caso, come nel precedente, la riflessione si è sviluppata tra storia e storiografia, mescolando il livello del dibattito storiografico a quello di proposte di ricostruzione in re delle vicende oggetto di analisi. Di diverso vi è che non si tratta adesso di interventi organici di storia della storiografia ma solo di discussioni critiche e di spunti di ragionamento volti a presentare taluni argomenti che considero importanti per un nuovo e diverso approccio alle forme del conflitto politico violento.
È in questo clima intellettuale che prendeva corpo il mio volume del 1999, “Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell’Europa moderna”, cui questo libro si riconnette idealmente. Raccolgo infatti qui una serie di saggi e interventi sul tema apparsi da allora su riviste o in volumi collettanei, alcuni dei quali di difficile reperibilità. Anche in questo caso, come nel precedente, la riflessione si è sviluppata tra storia e storiografia, mescolando il livello del dibattito storiografico a quello di proposte di ricostruzione in re delle vicende oggetto di analisi. Di diverso vi è che non si tratta adesso di interventi organici di storia della storiografia ma solo di discussioni critiche e di spunti di ragionamento volti a presentare taluni argomenti che considero importanti per un nuovo e diverso approccio alle forme del conflitto politico violento.
Vi è poi una seconda differenza: mentre “Specchi della rivoluzione” era dedicato alle rivoluzioni europee di età moderna (La rivoluzione/guerra civile inglese di metà Seicento; la Rivoluzione francese; la Fronda e la rivoluzione napoletana del 1647/48) qui il discorso, dopo aver sviluppato un’analisi del concetto di rivoluzione e delle prospettive di indagine odierne sul conflitto politico nel Seicento e sulla Grande Révolution, si allarga anche alle rivoluzioni nazionali ottocentesche. Con riferimento soprattutto al Risorgimento, al socialismo, all’anarchia e al comunismo novecentesco. Il tentativo è insomma quello di offrire al lettore uno sguardo aggiornato e, per quanto possibile, innovativo, sul tema.
Ciò che più ha caratterizzato il primo ventennio del Ventunesimo secolo nel campo degli studi sulle rivoluzioni è stato indubbiamente il diverso ruolo giocato dalla violenza. Un tempo considerata come uno spiacevole ma inevitabile appendice del mutamento storico – una sorta di danno collaterale, qualcosa che poteva essere messo tra parentesi perché subordinato all’essenziale, vale a dire alla costruzione del mondo nuovo – la violenza è invece divenuta nel frattempo il principale oggetto dell’attenzione. Smarrito nella nebbia quel “gancio del futuro” che legava la storia e la trascinava con sé, è come se un certo regime di temporalità fosse imploso, lasciando un presente inerte a coltivare sé stesso o a ripiegarsi nel vortice del passato, e nel suo buco nero, il trauma. Quella “tempesta che spira dal paradiso” di cui ha scritto Walter Benjamin, quel vento del progresso in cui le ali dell’angelo della storia sono impigliate, ha come smesso di soffiare. E le conseguenze sono state particolarmente visibili nel caso delle rivoluzioni, che hanno cessato – tanto nella sensibilità comune quanto nelle ricerche degli storici – di essere degli eventi-monumento, per divenire delle tragedie collettive, segnate dalla confluenza drammatica del bene e del male.
Da qui lo spostamento di enfasi sulla loro natura: da fenomeni oggettivi, di cui indagare le cause e gli effetti, a esperienze collettive condivise, in cui analizzare soprattutto la dimensione soggettiva, con una particolare attenzione alle scelte di carattere etico e valoriale che comporta. Da qui anche la prevalenza del concetto di “guerra civile”, con la sua pretesa di neutralità ideologica, come principale strumento euristico.
Questa predilezione per una storia esperienziale e per la connessa soggettività rivoluzionaria ha trovato alimento anche nella più generale attenzione rivolta alla dimensione psicologica e a quella tendenza che è divenuto abituale denominare “storia delle emozioni”. Si sono venuti affermando per questa via ripetuti tentativi di indagare la dimensione traumatica della politica attraverso il concetto di paura e la costruzione di figure che la incarnano. Si tratta di quelle rappresentazioni che ruotano attorno alla paura del complotto e alla sindrome (e alla psicosi) della cospirazione, e che nella loro punta estrema – dalla Grande peur del 1789 alla leggenda della macchinazione giudaica dei falsi protocolli dei Savi di Sion – tendono a svelare l’arcano del trauma originario, sia esso il Terrore rivoluzionario ovvero quella sorta di piano inclinato che conduce allo sterminio di massa novecentesco.
E tuttavia, come si sottolinea nel testo, il ricorso alle emozioni come un dato naturale e tendenzialmente astorico non è accettabile in prospettiva storica, in quanto attraverso esso si tende a studiarne gli effetti a prescindere dal fatto che gli attori storici avevano delle proprie idee su cosa fossero le emozioni. Si ignora così, in altre parole, il tessuto culturale che le informava, e per il quale sentimenti come l’amore e l’odio, la gioia e la paura venivano concepiti e perciò percepiti in modi diversi in tempi e luoghi differenti. Nell’Europa del Seicento, per dire, quelle che noi chiamiamo emozioni erano denominate diffusamente passioni, oggetto di imponenti tentativi di teorizzazione di cui è non solo anacronistico ma anche fuorviante non tenere conto.
Di più: il trasformare le emozioni naturalizzate in una sorta di motore immobile di alcune dinamiche traumatiche particolarmente sensibili negli eventi rivoluzionari ha il difetto di omettere i tentativi coscienti di controllo e di manipolazione della sfera pubblica e dell’immaginario collettivo. Tentativi che, a loro volta, dipendevano da un sentire comune condiviso su cosa fosse il popolo o la folla e di come si potesse influenzarne e condizionarne la sensibilità.
La critica esplicita delle prospettive interpretative caratterizzate da una deriva naturalizzante a base psicologica ed emotiva si accompagna poi in queste pagine alla contestazione della tradizionale, ma perdurante, tendenza che fa invece del repertorio ideologico la chiave di tutto, una sorta di script di cui le rivoluzioni sarebbero poi solo una scontata e obbligata messa in scena. Se per l’età moderna tale orientamento ha come fulcro la valorizzazione del calvinismo riformatore, dell’Illuminismo e di un sempiterno repubblicanesimo, per il Novecento essa si è incentrata sulla teoria delle cosiddette religioni politiche. L’assolutizzazione di quest’ultima prospettiva come fatto caratterizzante del XX secolo (e delle rivoluzioni novecentesche) – che tende a fare del super-investimento della politica nella ideologia un unicum, anche se modellato sulle religioni storiche – ha avuto un’enorme eco.
Su un piano meno tradizionale e che sconta di più la svolta ermeneutica, si è manifestato poi quell’orientamento – definito correntemente “culturalista” – che punta ad esaltare l’autonoma potenza performativa dei discorsi, destinati così a divenire protagonisti della narrazione storica al posto delle persone e delle associazioni. Si tratta della tendenza ad attribuire ai discorsi una capacità pressoché assoluta di organizzazione dell’universo sociale, tale da farne gli unici veri soggetti della politica; riducendo individui e gruppi a meri replicanti obbligati, attivi solo nella scelta di questo o quel discorso.
Secondo una modalità non troppo lontana da quest’ultima, parallela anche se diversa, si è affermata poi più recentemente, proprio nel campo degli studi sulle rivoluzioni, una sorta di deriva funzionalistica di stampo luhmanniano, per la quale i sistemi comunicativi vengono posti al centro della ricerca come i veri e anzi per meglio dire gli unici soggetti della comunicazione. Da qui una crescente attenzione, nel caso dell’età moderna, per i resoconti anonimi e “automatici”, come gli avvisi e le gazzette, per una diffusione e circolazione di idee anche eterodosse, ma che in certo senso prescinde dalla loro fabbricazione e dal loro contenuto specifico, applicazione palmare anche se spesso piuttosto inconsapevole della celebre tesi per cui il medium è il messaggio.
Un ultimo orientamento emerso negli ultimi lustri è poi quello di leggere le rivoluzioni non per via genealogica, per ascendenti storici, in una dimensione eziologica per così dire “verticale” ma viceversa per via orizzontale, spaziale, “transitiva”. Come espressioni di mutamenti contemporanei e interrelati, frutto di storie connesse e della “scoperta” del mondo globale.
Il primo terreno di sperimentazione di tale prospettiva è stato sicuramente quello delle cosiddette “rivoluzioni atlantiche”, espressione coniata al tempo della guerra fredda come sorta di sostegno storiografico alla Nato quale ombrello della libertà . Ma divenuta poi col tempo qualcosa di diverso e di più complesso, includendo oltre al “ponte” tra la rivoluzione americana e quella francese anche la rivoluzione di Haiti e poi le rivoluzioni nazionali primo-ottocentesche dell’America Latina. Al centro di uno scenario “spazializzato” sta ora soprattutto lo spostamento dei volontari in armi, degli uomini andati a morire per la patria degli altri e ad “esportare” la rivoluzione . Una dimensione, invero, alquanto trascurata da una storiografia tradizionale, incentrata su canoni essenzialmente nazionali e a cui adesso viene meritoriamente restituita centralità. Non diversamente da quanto viene accadendo per l’emigrazione anarchica su scala globale, a lungo marginalizzata dalla preferenza accordata al movimento socialista. Tale prospettiva, che ha il pregio della estensibilità ad altre aree, ad esempio a quella mediterranea, tende però a scambiare non di rado la comparazione con la causazione, e a fare della contestualità un principio di spiegazione.
Tale visione ha avuto inoltre una sorta di incoraggiamento a seguito di eventi che sono stati inquadrati come una sorta di “ritorno della rivoluzione”, anche se inusitati e difficilmente inquadrabili nella fenomenologia tradizionale: si pensi alla “primavera araba” e alle “rivoluzioni colorate”, ma anche ai tanti movimenti di resistenza e di contestazione di regimi autoritari o dispotici affioranti in un mondo sempre più interconnesso e in cui dilaga il terrorismo. L’espressione forse più radicale di tale punto di vista sul piano globale è data dal volume di Geoffrey Parker sulle crisi politiche contemporanee registrate in varie parti del mondo alla metà del Seicento e attribuite ad un’unica causa, il temporaneo raffreddamento climatico di quegli anni, la cosiddetta “little ice age”.
Le tendenze storiografiche sopra ricordate (storia delle emozioni, storia intellettuale, storia discorsiva e storia connessa in dimensione spaziale) rappresentano gli orientamenti più diffusi e promettenti nello studio delle rivoluzioni registrati negli ultimi lustri. Esse, tuttavia, nella loro diversità sono a ben vedere caratterizzate da uno stesso rifiuto, quello di considerare le rivoluzioni avvenimenti pienamente “politici”, intendendo per “politica” quella modalità specifica di regolazione della vita collettiva operata da individui e gruppi in difesa dei propri valori e del proprio potere secondo le forme ammesse dai regimi esistenti. È come se tra la vita politica ordinaria e la politica rivoluzionaria si tendesse a delineare uno iato, una frattura, rimandando la prima al mondo prosaico degli interessi e la seconda a quello, assai più suggestivo, dell’entusiasmo ideologico. Un mondo, quest’ultimo, dominato dai movimenti collettivi e su cui la sociologia e la psicologia sociale hanno costruito imponenti elaborazioni, che vanno dalle teorie della folla di età positivistica a quelle più recenti dello statu nascenti, tipizzazione modellata sui movimenti giovanili di contestazione degli anni Sessanta.
Sia la storia intellettuale, tradizionale o di impostazione discorsiva, sia la storia sociale, nelle sue molteplici varianti, continuano a nutrire insomma su questo terreno un parallelo distacco nei confronti della storia politica evenemenziale, dei suoi incidentali twists and turns. Nel caso della storia sociale, essa pare anzi ancora legata alla celebre definizione di George Macaulay Trevelyan per la quale la social history sarebbe the history of the people with the politics left out.
Si è cercato, viceversa, in queste pagine, di articolare una posizione diversa, consistente nel guardare alle rivoluzioni (alle rivolte, alle sollevazioni, alle ribellioni) come fasi di trasformazione della politica e non come periodi di superamento o di abbandono di essa, di una sua – se si può dir così – sublimazione.
Il gioco politico ordinario delle influenze, dei rapporti di potere, dei legami clientelari e fazionari non viene, in tempi rivoluzionari, semplicemente abolito, ma assume forme nuove, caratterizzandosi anzitutto per un’inusitata apertura a gruppi, ceti o classi che abitualmente non vi prendevano parte o erano ammessi solo con modalità ristrette, entro precisi limiti.
Questa riconsiderazione delle rivoluzioni come eventi di natura strutturalmente politica si articola qui in tre diverse prospettive che meritano di essere brevemente sottolineate e che sono tutte e tre precedute e accomunate dal rifiuto di assolutizzare il concetto di rivoluzione, attribuendogli una dimensione esclusiva, per ricondurlo invece alla sfera variegata, mutevole e contingente delle varie forme di contestazione in armi e di abbattimento violento dell’ordine politico costituito.
La prima prospettiva d’indagine attiene al carattere eminentemente processuale della sfera rivoluzionaria, caratterizzata dalla formazione di nuove identità politiche connessa al succitato allargamento e rivolgimento dei gruppi politicamente impegnati, che ne costituisce l’aspetto più appariscente. Superare la concezione “moderna” o classica della rivoluzione significa concepirla non come l’effetto quasi meccanico dell’azione predeterminata di rivoluzionari di professione, ma invece come l’esito di una crisi politica in cui si manifestano spinte e tendenze contraddittorie. E in cui, col tempo, si forgiano inediti sensi di appartenenza, nuovi modi di concepire e di separare un “noi” da un “loro”. In questa visione non sono tanto i rivoluzionari a fare la rivoluzione quanto la rivoluzione a “fare” i rivoluzionari. Di questa costruzione identitaria rimangono, a volerle osservare, tracce evidenti sia nella tradizione memoriale sia nell’universo, pur in seguito spesso censurato, delle rappresentazioni.
La seconda riguarda le forme della politica rivoluzionaria. Diverse, certo, dai modelli tradizionali della politica ordinaria, e per molti aspetti inusuali, esse sono tuttavia meritevoli di essere indagate tanto nelle loro novità quanto nella persistenza di tratti salienti. I legami di gruppo, di fazione e di clientela che preesistevano nella quotidiana vita politica non spariscono d’incanto nel vortice della rivoluzione ma si trasformano e si riproducono nella sua fucina. In presenza di nuovi quadri strutturali, giuridici e istituzionali, e di nuove soggettività politiche, il tessuto politico ordinario si frantuma e si sfrangia, diventa altra cosa, si trasforma, ma persiste.
Di questa resilienza fanno parte idee ricevute su come si organizzi e si gestisca l’ordine pubblico, su come si attivi la contestazione, su come si reprimano le trame degli avversari del regime esistente, su come si manipolino le folle. La famosa frase del citoyen Marc Caussidière, prefetto di polizia del governo rivoluzionario parigino del 1848, per cui “Il faut faire de l’ordre avec du désordre” mette in chiaro come una pratica ben collaudata, quella dell’infiltrazione e del reclutamento nelle file avversarie e nel tessuto sociale criminale, vada rivolta al servizio della rivoluzione.
Detto in altri termini, l’estremismo politico e i processi di radicalizzazione ideologica non dovrebbero essere separati dalle modalità concrete di conduzione della lotta politica, che persistono anche laddove la fantasmagoria rituale delle adunate di massa e la figura di un capo rivoluzionario, di un autocrate onnipotente, sembra ridurle in polvere.
Di queste nuove forme di lotta politica fa parte non solo lo scontro per allocazione e distribuzione delle risorse materiali ma anche – e sta qui la terza prospettiva che queste pagine puntano a introdurre – la competizione per l’assegnazione e la gerarchizzazione delle risorse simboliche, ugualmente riprese dal mondo prerivoluzionario ma al contempo intimamente trasformate; e decisive nella costruzione dell’immaginario collettivo e delle rappresentazioni simboliche tipizzate che lo popolano.
In questa competizione ha grande importanza l’uso dei precedenti storici, e cioè di un passato familiarizzato e reso funzionale alle esigenze del presente. V’è chi recentemente ha teso ad interpretare tale ruolo con riferimento al concetto di rivoluzione, rimarcando giustamente il valore performativo del richiamo al passato ma reintroducendo per questa via una primazia dell’ordine ideologico-discorsivo. Come si è cercato di dimostrare altrove, l’uso di precedenti storici ha un’importanza decisiva ma piuttosto che essere ricondotto al potere plasmante del paradigma rivoluzionario in quanto tale andrebbe invece connesso alla capacità di attualizzare scenari storici particolari (fatti di gesti, ruoli, scelte, atti politici) e renderli egemoni nel dibattito della sfera pubblica. Il richiamo di un passato suscettibile di essere ripetuto non deriva dunque tanto dall’autonoma potenza dell’idea di rivoluzione, quanto da singoli frammenti storici attualizzati e resi così capaci di interpretare e di sostenere nel dibattito pubblico le svolte della politica.
Per queste vie – che il libro cerca di percorrere – la rivoluzione, certo oggi non più quella di una volta, può tornare ad essere uno straordinario laboratorio di indagine per gli storici, e, rientrando in contatto con le domande del tempo presente, raccontare al pubblico odierno come ha preso forma in passato il processo di cambiamento dei modi, delle forme, e delle idee della politica.