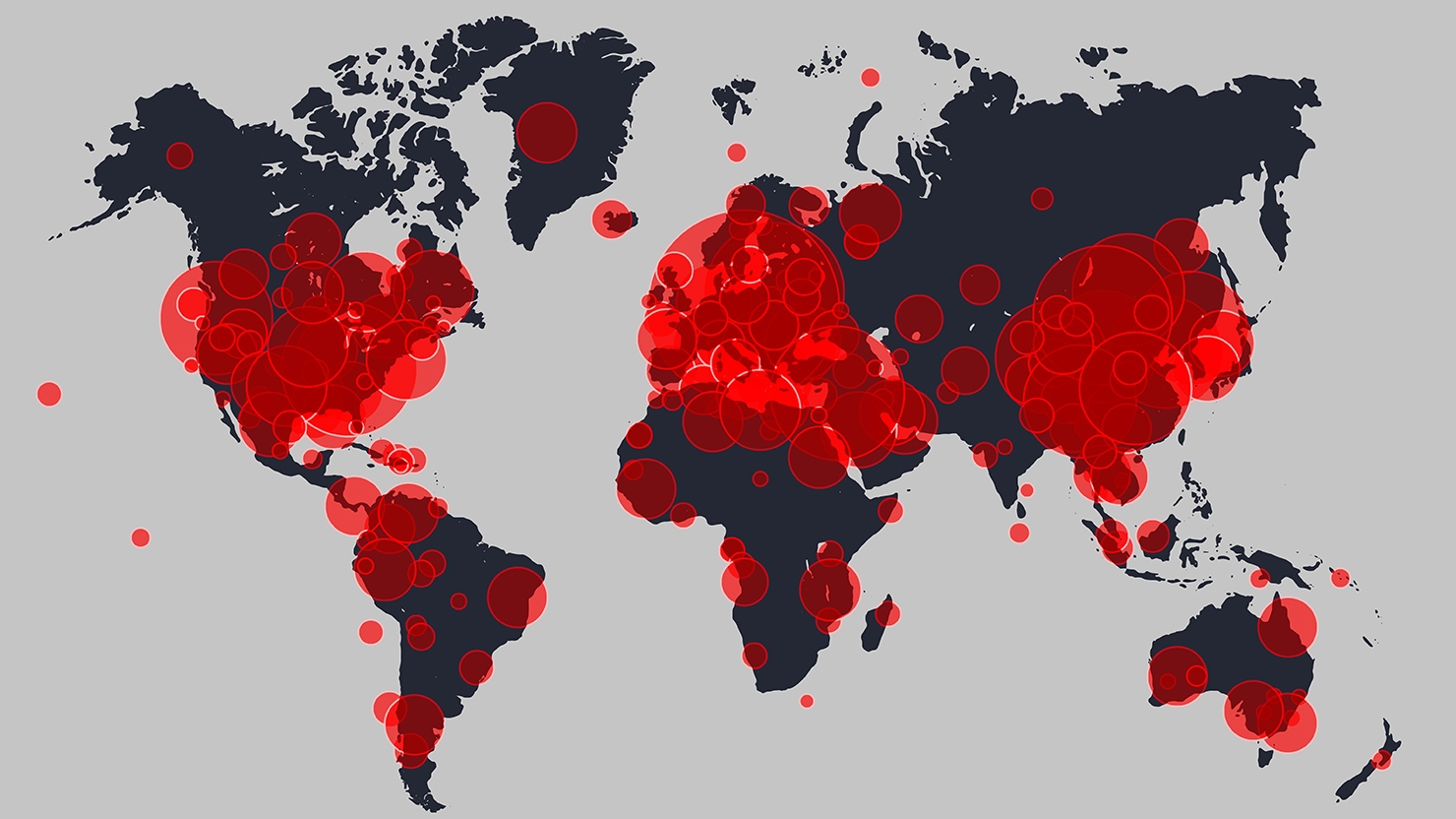La peste nera del 1348 a Palermo
Cronaca di una città che negò il contagio
La prima tappa europea della peste nera, l’epidemia che sconvolse l’Europa nel 1348, è stata in Sicilia, a Messina, e un cronista catanese, noto come Michele da Piazza (anche se certamente non si chiamava così) ha il poco invidiabile privilegio di essere il primo a descriverne i sintomi. Se altrove la peste arriva come una catastrofe annunciata e temuta, in Sicilia invece il colpo è repentino: alla violenza del morbo si aggiunge l’assoluta impreparazione.
Sicché il cronista, raccontando l’insorgere e il diffondersi dell’epidemia, la desolazione e il panico delle città colpite, non può evitare di assumere il punto di vista dell’osservatore obiettivo di un fenomeno fino allora del tutto inedito. Ma se riesce a mantenere un tono distaccato nel descrivere i dolori, gli sputi sanguinolenti, le pustole infette, i morti abbandonati nelle case e per le strade, non ce la fa a reprimere il suo orrore di fronte ad altri sintomi che la peste porta con sé: quelli dell’indifferenza e dell’egoismo. Annotando, accanto al disfacimento dei corpi, quello di ogni senso di umanità.
Dopo aver parlato dell’arrivo della peste a Messina e del suo estendersi a Catania, il cronista accenna al diffondersi del contagio nel resto dell’isola, parlando di Sciacca, di Agrigento, di Trapani (città, quest’ultima, particolarmente colpita): non accenna a Palermo. L’unica fonte narrativa che riporta notizie ed informazioni sulla capitale, il Chronicon Siculum, che dovremo ormai chiamare Chronica Sicilie, dà un sintetico cenno sulla peste a Palermo, e dice che anche vi si facevano processioni e orazioni pubbliche, invocando la misericordia di Dio. L’estrema stringatezza della notizia, che è in pratica solo un’annotazione, e il fatto che la cronaca si interrompa bruscamente quasi subito fa pensare che l’anonimo autore sia stato tra i primi palermitani uccisi dal morbo. Che abbia avuto il tempo di assistere solo allo scoppio dell’epidemia, e non alla sua evoluzione.
Solo indirettamente si può arrivare ad intuire qualcosa sulla presenza e l’andamento del morbo nella capitale. Per esempio il fatto che, in una raccolta di documenti quanto mai eterogenea come è quella contenuta nel tabulario del monastero di S. Martino delle Scale, ci si imbatta improvvisamente, tra il febbraio e l’aprile del 1348, in un gruppo compatto di sei tra testamenti e inventari post-mortem. Due di essi sono riferiti al decesso di altrettanti membri di una stessa famiglia, un dato che può servire ad indicare il momento in cui l’epidemia era sicuramente presente in città e molto probabilmente aveva raggiunto la massima virulenza. Ma l’epidemia è esplicitamente citata come causa di aumentato timore della morte, per quanto ne so, in un solo caso: e cioè in uno dei numerosi testamenti di Matteo Sclafani, che nel maggio del ’48 detta le sue ultime volontà eiusdem urbis egritudine ductus. Anzi, se è stato notato altrove come durante la peste i notai rogassero in maniera sciatta e frettolosa, senza troppo curare stile e scrittura delle ultime volontà di coloro che si sentivano minacciati dal morbo, a Palermo questo non succede: addirittura, nel rogare il testamento di un mercante palermitano, il notaio dilata il consueto preambolo fino ad un’ampia trattazione retorica sulla necessità di testare nel pieno delle proprie facoltà fisiche e mentali, quando meglio si può pensare alla salute dell’anima e provvedere alla cura del patrimonio terreno.
Anche la documentazione cittadina è avara di notizie. Una mancanza difficile da spiegare, perché non è dovuta ad una lacuna nella documentazione (che è invece piuttosto consistente negli anni dal ’47 al ’49), ma non contiene segni espliciti dell’arrivo in città della peste, dei provvedimenti presi dall’universitas per prevenirla o contrastarla, di processioni o altre manifestazioni religiose, di problemi relativi ai cadaveri degli appestati e alle loro sepolture. Se ci si dovesse basare sulla documentazione cittadina si potrebbe pensare che la peste che ha devastato tutta l’Europa abbia risparmiato Palermo. Bisogna dunque forzare l’ostinato silenzio delle fonti, procedendo ad una lettura che ci consenta di ricavare, indirettamente, il massimo delle informazioni dal minimo degli indizi.
Il registro del 1347-48, che contiene documentazione relativa all’amministrazione, si conclude bruscamente all’inizio di febbraio del 1348. Ma i tre ultimi documenti corrispondono a tre lugubri avvertimenti, tre rintocchi di campana a morto: tre uffici sono rimasti vacanti per la morte di tre funzionari, e re Ludovico, da Catania, nomina i sostituti. Segue una drammatica pausa di otto mesi, e il registro successivo, che comincia nell’ottobre del ’48, per tutto l’autunno e l’inverno che seguono non è che un diluvio di morti: morti che hanno lasciato debiti e conti in sospeso,vedove che rivendicano beni del marito, eredi che debbono farsi riconoscere come tali, cause per eredità e sostituzioni.
Muoiono mastro Giacomo Cannavaro (sopraintendente all’opera delle mura cittadine), Tommaso de domino Bonaccurso (incaricato delle riparazioni al Palazzo reale, alla Sala verde e alla cappella palatina), e Giovanni de Galterio (incaricato della fabbrica del nuovo campanile della cattedrale). Muore donna Ludovica Baverio, lasciandosi dietro una causa per l’eredità tra il fratello e il marito, un Tagliavia; muore Giordano Filangeri, della più antica aristocrazia palermitana. Muoiono, in tanti, coloro che avevano mutuato finanziato il contingente armato diretto all’assedio di Vicari, dove si erano rifugiati i Catalani fuggiti quando la città era insorta nel nome dei Palizzi e dei Chiaromonte: i fratelli Cossio e Guglielmo Paruta, Francesco Abatelli, Colo Masca, i Bilingerio e uno dei Cisario, tutti personaggi di primo piano nel giro dei ricchi mercanti palermitani, in gran parte di origine toscana.
Nel gennaio del ‘49 i riferimenti ai morti e le questioni ereditarie cominciano a diradarsi progressivamente. All’inizio dell’estate si può dire che i contenuti della documentazione rientrino nella normalità.
Sulla base degli scarsi dati disponibili possiamo pensare che la peste sia arrivata a Palermo dopo un paio di mesi dallo scoppio a Messina, alla fine del ’47 o all’inizio del ‘48; che l’epidemia abbia raggiunto la sua punta massima nel febbraio del ’48, (le indicazioni ricavate dal Chronicon siculum, dalla documentazione notarile e dagli Acta Curie puntano tutte concordemente su questa data) e che, nell’autunno dello stesso anno, la città abbia cominciato a prendere atto dell’allontanarsi dell’epidemia, e a tirare le somme dei danni subiti.
Anche se vogliamo esaminare la politica sanitaria cittadina negli anni dell’epidemia dobbiamo contentarci di notizie indirette. Sappiamo che ricoprono il ruolo di ufficiale sanitario due medici, Giacomo de Cremona, medicinalis sciencie professor, precordialissimo et utili concivi, virum honoratissimum ac sapientem et necessarium pro salute corporea conservanda, e Giovanni Rossi da Velletri, medicinalis sciencie professor anche lui, che – oltre al merito di aver dispensato la sua scienza circa medendum humana corpora languentia – ha anche quello di essere venuto da fuori, moram trahendo in urbe predicta. Il salario destinato ai due medici è di 10 onze l’anno per ciascuno.
L’anno dopo, una volta superata l’emergenza, ad occuparsi della salute dei palermitani rimane solo Giacomo da Cremona. Evidentemente il medico laziale era stato chiamato in aiuto del titolare proprio nel difficile momento in cui l’epidemia aveva colpito la città, e i corpi languenti a cui si fa riferimento nel suo mandato di pagamento sono quelli degli appestati.
La grave crisi attraversata dalla città traspare anche dalla lettera regia del 7 gennaio 1349, che concedeva agli ebrei palermitani una moratoria di un anno per il pagamento dei debiti. Nella lettera il sovrano spiega come la moratoria venga concessa non perché ci sia stato un calo del livello degli affari in cui erano coinvolti i membri della comunità giudaica, ma perché costoro erano stati vittima di furti e violenze (tumultuosos discursus disrobaciones violentas et dampna gravia) da parte di «insolenti», per cui sono ridotti in estrema povertà. Sei mesi dopo, il ricordo delle violenze subite dagli ebrei di Palermo in occasione della peste si ritrova in un documento in favore di un ebreo palermitano: una banale attestazione della cittadinanza, in cui però pretore e giudici ritengono necessario aggiungere che l’interessato aveva perso i suoi beni, saccheggiati dagli insolentes de populo. A Palermo, dunque, come quasi dappertutto, la “colpa” della peste ricadde sugli ebrei; ma siamo ben lontani dai veri e propri progrom, considerati i più impressionanti di tutta l’età medievale, che si erano verificati nell’Europa centrale, perché è chiaro che le violenze si erano rivolte ai beni più che alle persone, e le disrobaciones non avevano provocato vittime.
In quanto alla reazione delle autorità, se l’intervento della Corona in difesa della comunità ebraica palermitana rientra tra le consuete misure di protezione degli ebrei, servi della regia camera, posti, dice il sovrano, sub umbraculo magestatis nostre, il fatto che le autorità cittadine si sentano in dovere di ricordare i danni subiti dagli ebrei mesi dopo il provvedimento regio e in un contesto in cui non è assolutamente necessario farlo mi sembra un chiaro segno del fatto che l’episodio era stato vissuto come un trauma da parte di tutta la città, colpita in una parte di sé non separata dall’organismo urbano.
La peste potrebbe anche aver avuto un’ incidenza di lunga durata nella vita politica e sociale della capitale. Nell’estate del 1348 – nel momento in cui, secondo la ricostruzione fin qui effettuata, l’epidemia cominciava a diminuire – i palermitani insorgono contro i catalani, cacciati dalla città e costretti a rifugiarsi a Vicari, ma i cosiddetti “Vespri anticatalani” servono soprattutto ad eliminare i superstiti difensori della vacillante autorità regia contro le grandi famiglie. Tre anni dopo, nel dicembre del ’51 la rivolta contro i Chiaromonte, guidata da un loro familiare e prontamente domata, consente alla grande famiglia feudale di impadronirsi definitivamente e totalmente della città. La vita cittadina della capitale, che dal Vespro alla Peste si era svolta all’insegna di una notevole stabilità, in cui l’emergere dei nuovi poteri delle grandi famiglie, nel caso particolare Chiaromonte e Sclafani, doveva fare i conti con una ceto dirigente forte e ben radicato, subisce una drastica svolta.
Alla metà del secolo accanto al palazzo dei Chiaromonte, lo Steri, la famiglia dei signori di Palermo innalzava una cappella dedicata a Sant’Antonio abate, guaritore invocato contro la peste: un ex-voto, probabilmente. Ma la coincidenza cronologica quasi perfetta tra la celebrazione della festa del santo e la data del definitivo trionfo dei Chiaromonte sulla città, il 25 gennaio del ‘52, lascia sospettare che l’ex voto servisse anche a celebrare, nel linguaggio ambiguo e insieme protervo dell’ambiguo potere chiaromontano, un evento che cambierà la vita della capitale.