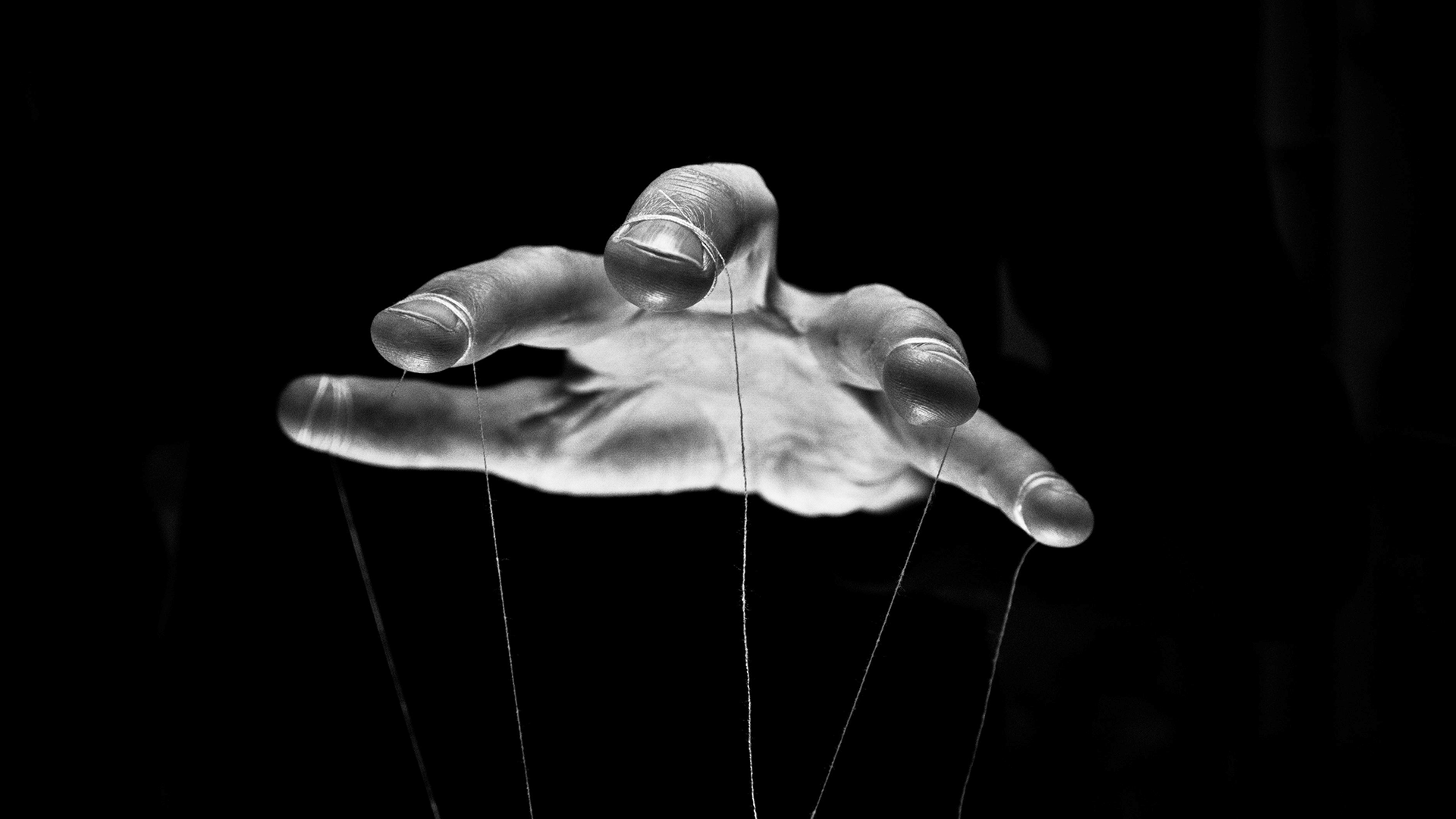Benedetto Croce diplomatico: un filosofo tra le macerie della King’s Italy
Il nuovo saggio di Eugenio Di Rienzo, Benedetto Croce. Gli anni dello scontento 1943-1948 (Rubbettino Editore), pone l’accento sulla diplomazia personale sviluppata dal filosofo tra 1943 e 1945 nell’intento di evitare al nostro Paese i rigori di una «pace punitiva», voluta fortemente da Londra, che si sarebbe dovuta sostituire alla «pace ricostruttiva», ambiguamente garantitaci nell’armistizio di Cassibile (3 settembre 1943) e poi negataci da quello di Malta del 29 settembre successivo. Il cosiddetto Long Armistice, siglato nell’isola del Mediterraneo, sottoponeva, infatti, l’Italia alle durissime condizioni di un’unconditional surrender che, secondo Croce avrebbe messo forse a rischio la nostra stessa integrità territoriale e sicuramente impedito un’ordinata ricomposizione del tessuto politico e sociale della Penisola dopo la fuoriuscita dal ventennale carcere del regime fascista.
Che i timori di Croce a questo riguardo fossero tutt’altro che infondati lo dimostra la ricca documentazione archivistica utilizzata da Di Rienzo e in particolare il memorandum elaborato congiuntamente dal Foreign Office e dal War Office, alla fine d’ottobre del 1944, dove si stabiliva addirittura la spartizione dell’Italia a favore di tutte le Nazioni aggredite dall’Asse e facenti parte dell’alleanza che si era contrapposta al fronte nazi-fascista. Secondo questo programma, si prevedeva di dare alla Grecia la Puglia e altri territori del Mezzogiorno adriatico; alla Iugoslavia, una porzione di territorio estesa dall’Istria al Veneto; alla Francia, l’isola d’Elba, la Val d’Aosta, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e cioè tutto il cosiddetto “triangolo industriale” che era definito con cinico humour britannico come “il cestino del pane”. Al Regno Unito sarebbero toccate, invece, la Calabria, la Sardegna, la Sicilia con le isole a essa antistanti (Linosa, Lampedusa Pantelleria), mentre gli Stati Uniti si sarebbero dovuti limitare all’occupazione di Roma, la cui amministrazione civile sarebbe stata affidata al Pontefice.
Questo memoriale faceva seguito al rapporto stilato, il 18 ottobre, da Sir Horace Anthony Claude Rumbold, allora membro dello staff dell’Alto Commissario nel Governo militare alleato in Italia, Harold Macmillan. In esso, Rumbold rigettava assolutamente l’ipotesi di arrivare a siglare un trattato di pace con l’Italia prima della vittoria finale contro le forze del Tripartito, almeno che questo trattato non configurasse per l’Italia l’accettazione di una vera e propria “pace cartaginese”.
Non vi sarebbe alcun vantaggio nel fare un trattato di pace con l’Italia per porre fine allo stato di guerra con essa. Un simile trattato renderebbe soltanto più facile adottare lo status e reclamare il trattamento di alleata. Questo la toglierebbe dal banco degli accusati e la installerebbe nel consiglio giudicante, insieme alle Potenze alleate. Inoltre, io ritengo che l’obiezione generale più forte contro il trattato di questo trattato, a questo stadio, è che ci dovremo impegnare su molte questioni che saranno inevitabilmente influenzate dal corso ulteriore della guerra di nostri obiettivi generali di politica che solo dopo la resa della Germania si configureranno con sufficiente chiarezza. Attualmente, infatti, noi non abbiamo alcun obbligo ufficiale o morale che ci vieti d’imporgli condizioni di pace gravose e umilianti, per l’Italia, ma capaci di soddisfare i nostri alleati minori, come i Francesi, i Greci e gli Iugoslavi. Il far permanere l’Italia nelle condizioni di Nazione armistiziata ci consentirà di avere mano libera su tutte le questioni territoriali e in particolare sulla più importante di queste che riguarderà la frontiera italo-iugoslava.
La sola specie di trattato preliminare di pace, vantaggioso per noi, sarebbe quello che, nonostante la parte svolta dall’Italia come cobelligerante contro la Germania, ci mettesse in grado d’imporle moralmente o con l’uso della forza, quei termini alla quale noi avremmo desiderato di obbligarla se l’Italia non avesse svolto alcuna parte come cobelligerante della Germania. Un trattato sarebbe vantaggioso per noi solo se obbligasse l’Italia a rinunciare in anticipo a ogni reclamo che, nell’assenza di un protocollo diplomatico, la sua cobelligeranza potrebbe dargli diritto più tardi di avanzare. Particolarmente, il trattato dovrebbe esigere che essa rinunzi a ogni pretesa sui territori che sono ufficialmente sotto la sua sovranità e cioè anche a tutti i territori metropolitani distanti centinaia di miglia dalle frontiere del 1940 con la Francia e la Iugoslavia. In questo caso, e solo in questo, sarebbe vantaggioso firmare con l’Italia un trattato preliminare di pace. Infatti, noi non ci impegneremo a niente e questo trattato ci permetterebbe, senza ulteriori discussioni, di trattare l’Italia duramente come appunto desiderano.
Croce fu informato con forte anticipo di questi progetti da Vittorio Emanuele Orlando che già, il 12 luglio 1944, gli rivelava “che l’Inghilterra mira a un totale schiacciamento e annullamento della forza italiana, dopo che Mussolini le ha aperto gli occhi sui pericoli che, per il suo Impero, rappresenta un’Italia nel Mediterraneo, se le si mette contro”. Per parare questa minaccia, l’autore della Storia d’Italia organizzò una manovra che doveva incidere profondamente sul piano interno e su quello internazionale. In primo luogo occorreva dare all’Italia un governo forte, autorevole, gradito all’opinione pubblica antifascista, costringendo all’abdicazione Vittorio Emanuele, il Principe ereditario e liquidando Badoglio. In secondo, occorreva intensificare lo sforzo bellico italiano contro la Germania, convincendo Londra e Washington a far entrare in linea il maggior numero di unità del Regio Esercito e affiancando a queste un “Corpo di Volontari della libertà”. Solo gettando sulla bilancia della storia il peso della spada di Brenno, l’Italia poteva sfuggire, infatti, al triste destino di Nazione non solo vinta ma anche debellata e ridotta a semplice pedina nello scacchiere internazionale del dopoguerra.
Come il filosofo annotava nei Taccuini di lavoro, nessuna di queste richieste fu però esaudita dal Governo militare alleato in Italia. Inglesi e statunitensi, infatti, preferirono utilizzare il grosso dei militari italiani per controllare le retrovie o come forza-lavoro e arrivarono addirittura a privarli dei loro armamenti per cederli al IX Korpus sloveno di Tito che premeva minacciosamente sul nostro confine orientale dalla Dalmazia al Friuli. Si trattava, come Croce intuì immediatamente di un “rifiuto politico” che preparava la strada al durissimo diktat impostoci a Parigi, il 10 febbraio 1947 che il direttore de “La Critica” si rifiutò di votare nella seduta della Costituente del 24 luglio seguente pronunciando un fiero discorso «contro l’approvazione del dettato di pace».
In quell’intervento, l’ospite di Palazzo Filomarino ammoniva tutti gli Italiani, vinti e vincitori del 25 aprile 1945, sostenitori, oppositori e vittime del regime, a far gravare sulle loro coscienze il grave lutto che aveva colpito la Nazione. Nessuno, davvero, poteva sottrarsi, infatti, in quel triste momento, all’obbligo di reagire all’umiliazione di essere forzati a ratificare un atto che confliggeva col secolare Jus publicun europaeum. Quella giornata non ammetteva diserzioni perché il documento, che era sottoposto al voto dell’assemblea, non costituiva “solo la notificazione di quanto il vincitore chiede e prende da noi ma un indebito giudizio morale e giuridico sull’Italia e la pronunzia di un castigo che essa deve espiare per redimersi”.