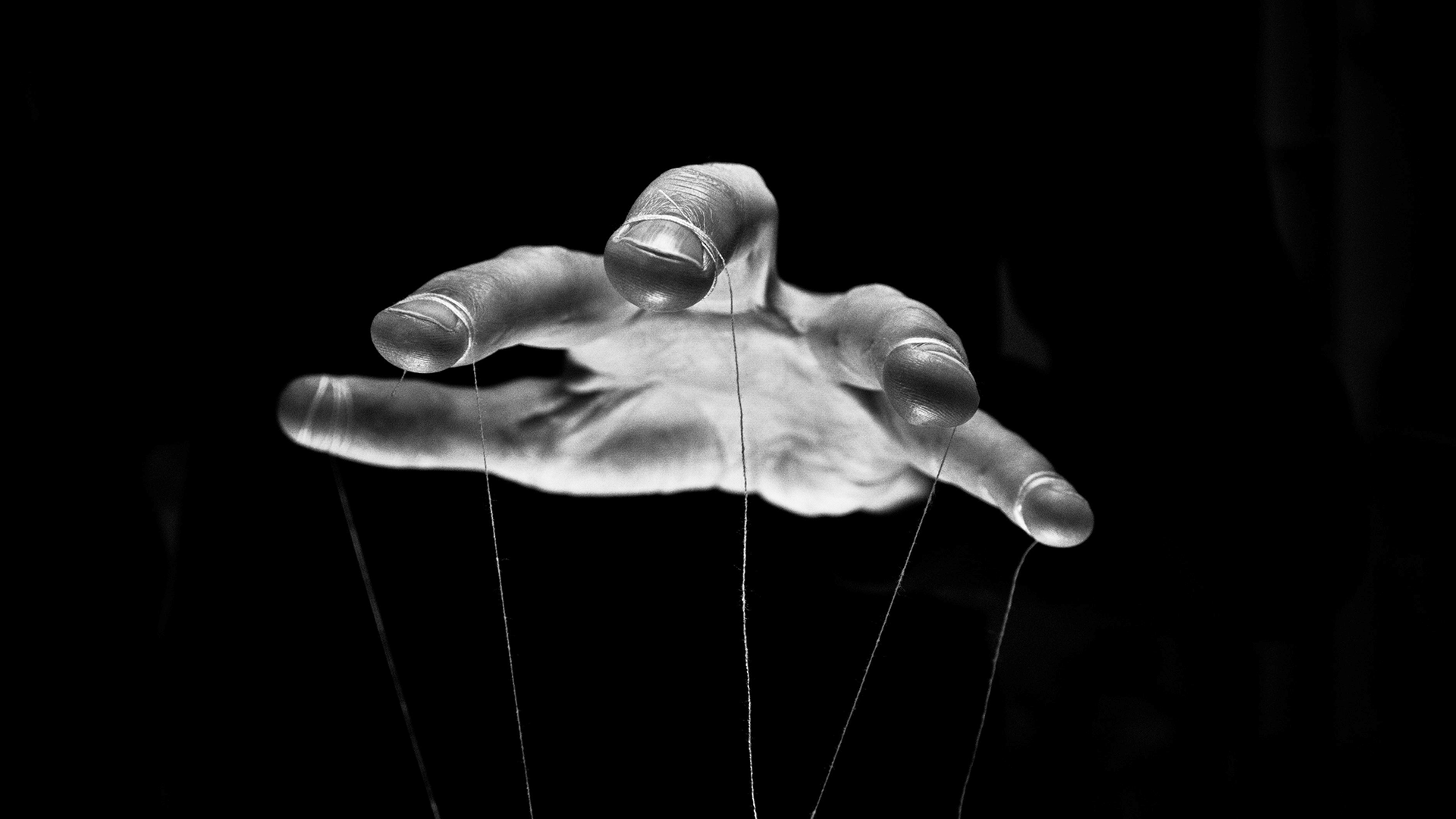Paura e rinuncia: dalle macerie della pandemia a un nuovo orizzonte etico
Le restrizioni, la lezione di Epicuro e le strade da (ri)percorrere
La situazione pandemica che per mesi ci ha circondati, avvolti e bloccati suscita questioni che si muovono su piani diversi e diversamente importanti; innegabile, tuttavia, che essa imponga un attimo di pausa e un supplemento di riflessione anche per chi si occupi di filosofia, di pensiero più o meno puro.
Non ho qui la pretesa di esaurire la gamma vastissima di approcci, secondo cui questo tempo dilatato e scuro del Coronavirus può o deve essere analizzato. Lo spazio a disposizione, inoltre, suggerisce una trattazione che non si perda in chiacchiere, ma che sappia individuare nodi cruciali, tali da poter diventare oggetto di più ampia discussione.
Per parte mia ne vorrei, sommariamente, isolare solo due aspetti: la paura e la rinuncia. Di fronte allo scatenarsi di un fenomeno patologico così invasivo oserei dire che la paura non è un optional; anzi aggiungerei piuttosto che abbiamo dovuto farci compagna la paura, una paura che non si blocchi sulla soglia dell’oggetto che ci spaventa, ma scateni energie o promuova soluzioni in grado di risolvere i problemi che quell’oggetto nuovo e terrificante suscita. Pur avendo dovuto accettare i confini imposti dalla pandemia, dovremmo forse provare a percorrere la strada di una nuova, razionale e consapevole moralità a tutto vantaggio di un produttivo controllo dei rischi aperti dal nostro (spesso disastroso) agire, che in non pochi casi si è trasformato in una forma inconsulta di agitazione (produttivistica e efficientista).
Dovremmo, insomma, con uno scarto di originalità e perfino creatività, imparare, nuovamente, ad aver paura. Per far questo credo possa essere utile tornare all’ammonimento di Hans Jonas, il quale difendeva, già nel 1979, la necessità di una proficua euristica della paura. Meritano di essere ricordate, allora, direttamente le sue parole: “si dovranno apprendere nuovamente il rispetto e l’orrore per tutelarci dagli sbandamenti del nostro potere […]. Il paradosso della nostra situazione consiste nella necessità di recuperare dall’orrore il rispetto perduto, dalla previsione del negativo, il positivo: il rispetto per ciò che l’uomo era ed è, dall’orrore dinanzi a ciò che egli potrebbe diventare, dinanzi a quella responsabilità che ci si svela inesorabile non appena cerchiamo di prevedere il futuro” (H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P. Portinaro, Einaudi, Torino 1990, p. 286).
Non certo sganciata dalla rivalutazione del ruolo della paura è, a mio avviso, la possibilità di dare un senso diverso al nostro abitare il mondo. Invece di misurare la dimensione della nostra felicità attraverso una sorta di registratore di cassa, che dunque la intende e la impone come un’acquisizione continua, un tendere, più o meno sfrenatamente, all’accumulo di beni, spesso solo esteriori e caduchi, una conquista che ci regala il surplus del profitto utilitaristico sulle ricchezze, del mondo e umane. Invece di tutto questo, dunque, le restrizioni dovute alla pandemia possono contribuire a costruire uno scenario nuovo, dove la felicità ha senso non se si aggiunge, ma se si toglie, non se si accumula, ma se si rinuncia. Anche in questo caso vorrei farmi alleato un filosofo, antico e che ha purtroppo goduto per secoli di cattiva pubblicità”: Epicuro.
L’orizzonte da lui offerto alla riflessione umana, nella sua valenza oggettivamente terapeutica, mira infatti a privare la vita di ogni aggettivo superfluo, soprattutto astrattamente valutativo: importante è dunque non lo eu zên (il vivere bene), ma il semplice, facilmente raggiungibile zên (vivere). Questo sforzo di “normalizzazione” passa anche attraverso un significativo recupero della dimensione temporale del presente, anche e perfino se segnato da difficoltà e problemi severi, con un conseguente ridimensionamento del peso angosciante del futuro e uno spazio funzionalmente produttivo di gioia riconosciuto al passato.
Si tratta di un quadro etico di grande equilibrio, di estremo controllo o meglio autocontrollo, di convinta accettazione dei limiti e insieme delle opportunità della nostra condizione umana. Chiunque accetti di formarsi alla scuola di Epicuro, inoltre, sposta l’asse del suo benessere verso altre significative aperture, riconoscendo come elementi non eliminabili tanto l’utilità derivante dal rispetto delle norme giuridiche stabilite convenzionalmente quanto l’inestimabile arricchimento derivante da quel bene grandissimo che è l’amicizia, valore supremo interno alla propria comunità di riferimento.
Una nuova antropologia, insomma, un ritratto di esseri umani che non inseguono il crescente castello della soddisfazione di bisogni non naturali né necessari, ma percorrono fino in fondo (anche abituati a sopportare situazioni di estrema e tragica eccezionalità, come appunto è stata la nostra) la via dello scarto e della rinuncia al superfluo, ancorata a un nuovo panorama di bisogni, questi sì naturali e dettati da mera, reale, non indotta necessità.
Potrebbero dunque comparire, accanto e di fronte a noi, donne e uomini meno complessi, più “terrestri”, più animalmente in grado di riconoscersi nella sintesi estrema di una sentenza di Epicuro, quasi ricetta perenne e facilmente attuabile di felicità: “grida la carne: non aver fame non aver sete non aver freddo; chi abbia queste cose e speri di averle, anche con Zeus può gareggiare in felicità” (Gnomologio Vaticano 33).