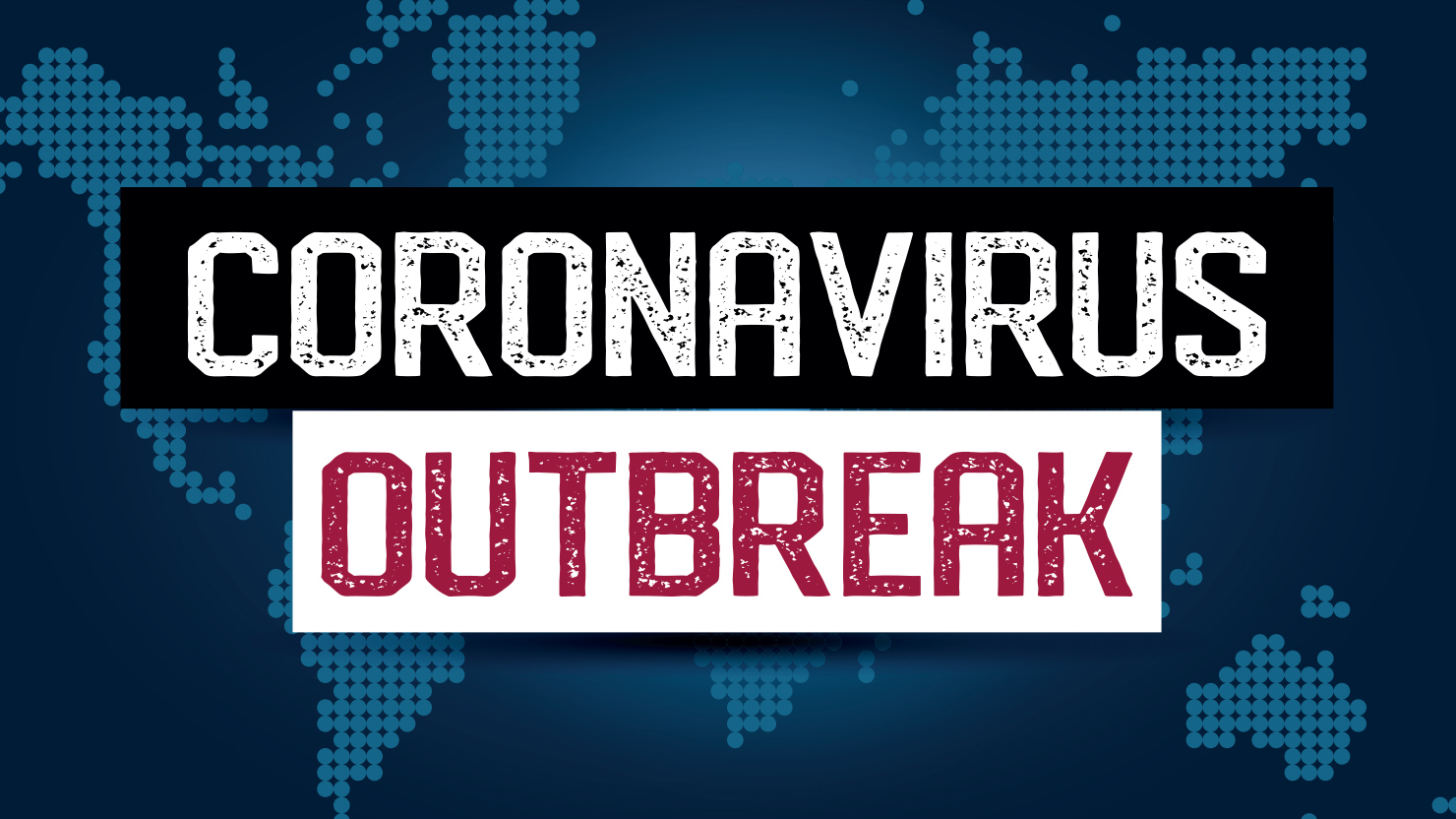Fame d’apocalisse
Uno spettro si aggira per l’Europa
Imminenza
Pare che sia imminente – con cadenza regolare, nell’opinione pubblica europea – la fine di un’esperienza umana chiamata capitalismo, nella sua forma moderna detto anche neoliberale. O forse, come mi sembra di recepire, ad esser imminente è il desiderio della fine, il suo anelito, nelle analisi di una certa tradizione di pensiero, la quale, con i dovuti aggiustamenti e le ricalibrazioni necessarie sulla base del tempo, ha il suo riferimento nel marxismo occidentale.
Qui mi riferisco in particolare all’articolo scritto da David Harvey per la rivista Jacobin USA(1), tradotto in italiano da Giuliano Santoro e pubblicato nella versione italiana della medesima(2).
Sebbene già da una prima lettura si possa notare come il titolista italiano abbia inasprito i toni dello scritto – traducendo Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19 con La fine del Neoliberismo, dunque non in modo esattamente letterale – i concetti di fondo che sembra esprimere il suo autore rimangono chiari ed in linea con l’atmosfera generale di una certa tradizione di pensiero.
Dico ciò, ovviamente, perché lo scritto di Harvey non è l’unico apparso in questi giorni dotato delle stesse intenzioni comunicative, ma è di certo uno di quelli la cui densità di pensiero porta a riflettere.
Il mio tentativo non è quello di aprire un contraddittorio netto rispetto alle analisi di Harvey, dunque quello di contrapporre una tesi di segno opposto alla sua; non c’è la volontà di difendere l’altro modello, l’altra prospettiva, ma di riflettere sul senso generale che riposa al fondo della strada che egli va perseguendo.
L’imminenza della fine, sia nella forma del desiderio che in quella della predizione, indubbiamente soffre nel restare irrealizzata. Ad ogni cenno di crisi, ad ogni rantolo di recessione (la quale, probabilmente, risulta fisiologica al processo) c’è chi accenna un finalmente, chi sussurra un era ora. Certo, non nell’atteggiamento dell’esultanza che risulterebbe imbarazzante per chi di mestiere tenta di comprendere il mondo, ma nella consapevolezza che prima o poi sarebbe venuto il tempo. Salvo poi ricredersi quando i grafici tornano a sorridere e la curva riprende a salire, dimostrando una certa resilienza del sistema, una certa portata della struttura.
È senz’altro vero che il nostro linguaggio ha capacità performative ed è proprio per tale ragione che reputo alcuni discorsi politici un tentativo, consapevole o meno, di condurre alla fine della sua esistenza questa specifica esperienza economico-sociale, al fine di costruire dalle macerie un mondo migliore.
Polarizzazione
Continua a persistere, dopo oltre un secolo di esperienza storica, una certa polarizzazione tra lo Stato ed il Mercato, come se questi fossero due elementi del sistema sociale umano che si escludono vicendevolmente. Questa polarizzazione emerge con ancor più veemenza nei momenti di crisi, come quella che Sars-Cov-2 ha generato in tutto il mondo globalizzato. Ed è proprio in questi momenti che zampillano previsioni che anche gli economisti più audaci – i quali sono anzitutto scienziati sociali (contraddicendo probabilmente l’opinione comune, che li osserva come grigi tecnocrati) – faticherebbero a pronunciare, nonostante abbiano una propensione maggiore nell’analizzare i dati ed una visione più lucida di come i due poli entrino in relazione. Qualsiasi scienziato sociale sa che, oggi più che mai, le due cose operano attraverso sottili equilibri che risulta vitale analizzare in tutta la loro portata.
Esistono, ed è una fortuna, istituzioni sovranazionali che garantiscono il corretto funzionamento e la necessaria coordinazione tra queste due azioni umane. Azioni. Perché lo Stato come il Mercato sono ambedue il frutto dell’interazione degli interessi degli esseri umani, ambedue luoghi di soddisfacimento di bisogni collettivi e individuali. Le stesse persone che si recano alle urne per esprimere i loro liberi indirizzi politici operano sui mercati per cercare di soddisfare i propri bisogni, ogni volta facendo una scelta. Di volta in volta incanalando il mondo. Nonostante questa evidenza, una certa narrazione vuole che una dicotomia profonda sia ancora in essere, alle soglie del nuovo millennio. Poveri contro Ricchi. Patrizi contro Plebei. Signori contro Schiavi. Padroni contro Operai. Tale dicotomia si fonda sull’idea marxista dell’espropriazione originaria, il fulcro della quale sembra essere, volendo banalizzare: esistono i ricchi perché hanno espropriato le risorse a coloro che adesso sono poveri e viceversa.
Ammettendo, anche con qualche perplessità, che la spiegazione funzioni in un tessuto economico-sociale basato sulla terra, ho qualche dubbio che tale prospettiva possa ancora funzionare, in un tessuto economico-sociale in cui la produzione di valore è basata sempre più sulla proprietà intellettuale. Un mondo nel quale l’idea e l’innovazione tecnologica che ne consegue sono per lo più il frutto dello sforzo individuale per migliorare le proprie condizioni d’esistenza.
Colpa
Il risultato più evidente dell’incessante polarizzazione tra Stato e Mercato è la colpevolizzazione della ricchezza individuale. Proposizioni del tipo «I lavoratori dipendenti (come me) lavorano da casa e ricevono la propria paga proprio come prima mentre i Ceo si spostano in jet ed elicotteri privati» che si trovano nell’articolo in analisi, sembrano evocare un certo disprezzo di classe, il quale non fa che infiammare gli stomaci di chi, quella ricchezza, com’è ovvio, la desidererebbe per sé. Questo atteggiamento, rischiosamente retorico, può generare un’atmosfera di tensione generale che sfocia, spesso, nella colpevolizzazione della stessa idea che va sotto il nome di miglioramento delle condizioni, di sforzo individuale, di rischio connesso ad ogni successo, del quale si nutrono le menti più pigre e verso il quale si disilludono quelle più attive.
Lungi da me il gettarmi di testa in un’apologia del classismo intellettuale o in una giustificazione di una certa superiorità di status che renderebbe qualcuno meritevole di ogni ricchezza. Discorsi di questo genere sono probabilmente del tutto insensati. Come pure non intendo giustificare un certo paternalismo miope davanti alle potenzialità di ogni individuo, con l’esplicita richiesta di non attivarle e di non attivarsi per migliorare la propria condizione, alla mercé di un atteggiamento che rasserena i cuori al motto «tranquilli, c’è qualcuno che pensa a voi». Che pensa per voi. Una volta di più, la polarizzazione.
Italia
Il caso italiano, in tal senso, è un’opportunità di riflessione. È, probabilmente, uno dei pochi Paesi occidentali in cui la polarizzazione è strutturale e forse, sbilanciata da uno dei due lati. Le costanti critiche alle istituzioni che dovrebbero mantenere quel magico equilibrio tra i due poli. Le banche centrali – accusate per lo più di affamare i popoli, sovente senza neanche sapere come operino e quali siano le loro prerogative, con il placido assenso di una pessima informazione condita di populismi e semplificazioni varie – sono un esempio lampante. E non serve a nulla far notare che i problemi possano essere sistemici e culturali, nel Belpaese, fintantoché ci sarà qualcuno più in alto da incolpare. Ebbene pare proprio che in Italia la parentesi del professor Harvey, la quale dice forse molto più di quel che sembra, sia rovesciata. La citerò per esteso «(il che significa incolpare sé stessi o Dio se qualcosa va storto ma non osare mai insinuare che il capitalismo potrebbe essere il problema)». La traduzione italiana potrebbe recitare (il che significa incolpare il capitalismo o Dio se qualcosa va storto ma non osare mai insinuare che è in sé stessi che potrebbe risiedere il problema).
Il virus che sta colpendo la nostra quotidianità può e deve essere usato come momento di riflessione. L’hashtag che va tanto di moda #restateacasa dovrebbe essere viralmente sostituito con un più positivo #pensateaxasa. Volendo evitare la noia generata dall’analisi dei numeri, dal ricordo di quei grafici post-2008 e post-2011 che, invece di formare una V formavano una L, dovremmo affrontare il costo intellettuale e fattuale di quella che da noi si configura come una crisi di produzione; o, in gergo economico, come una crisi dal lato dell’offerta.
Se i numeri non sono il nostro forte almeno la logica, come specie, dovrebbe intrinsecamente appartenerci, e attraverso questa potremmo facilmente notare come l’Italia manchi profondamente di un sistema produttivo in grado di assorbire la forza lavoro dal basso ed offrire ai cittadini beni e servizi di elevata qualità. Non è certo per caso, né per fame di neoliberismo, che un’istituzione come la BCE ha più volte ammonito l’Italia per le sue politiche colme di sprechi di risorse o di allocazione inefficiente di queste ultime, anche per via di una classe politica claudicante. Soprattutto è necessario ricordare che le politiche della banca centrale post-2008, -2011, e ancora una volta adesso, ai tempi del Covid19, sono sempre state indirizzate a introiettare nel circuito del Paese grossi dosi di liquidità, attraverso strumenti di politica monetaria in grado di garantire agli individui ammortizzatori sociali non indifferenti. La lettera di Mario Draghi(3), presidente uscente della BCE, del 26 marzo per il Financial Times, è una riproposizione di quell’ormai iconico Whatever it takes, così come pare esserlo il documento della banca centrale a firma di Madame Lagarde(4).
Occorre anche ricordare, forse, per mostrare quanto il neoliberismo sia lontano dall’essere una realtà operativa del bel Paese, che l’Italia è uno dei Paesi occidentali con il più grande tasso di trasferimenti per spesa pensionistica nell’area Ocse, per citare un dato, oltre ad avere sotto controllo e garanzia politica un numero enorme di grandi e medie aziende (vedi cassa depositi e prestiti)(5), le quali, ovviamente, sono salve dalla competizione sui mercati, occupando asset strategici attraverso operazioni manageriali di pessima fattura. Alitalia ne è uno dei casi più emblematici. Nessuno vuole metter in dubbio l’importanza delle spese di cui uno Stato deve farsi carico per l’assistenza alle categorie di individui meno abbienti. Nessuno vuol discutere la fondamentale importanza delle politiche di welfare o di quelle che mirano al rafforzamento della sanità pubblica, le quali in questo momento sarebbero più utili che mai. Non sussiste nemmeno il tentativo di difesa della competizione ad oltranza. Ancora una volta, sarebbe una polarizzazione. Ciò che qui si vuol contribuire a mostrare è il dato di un Paese che, dal punto di vista culturale, ristagna in un insanabile rigetto della modernità che avanza. Una cultura che non ha alcuna voglia di confrontarsi con il cambiamento tecnologico, in preda ad un’arrogante smorfia di superiorità per il fatto che un po’ di magnificenza storica l’ha in qualche modo toccata nel corso dei millenni. Non si può continuare a considerarsi il centro di un mondo che non c’è più. Se c’è una cosa di cui l’Italia manca è più probabilmente nostalgia di futuro.
Cina
L’analisi di David Harvey mette in luce anche una strana dicotomia di opinioni nei confronti di un Paese come la Cina. Conosciamo la storia di questo Paese, siamo ben consapevoli di quale genere di esperienza umana esso sia figlio. Forse l’ammirazione per certe misure nasce da una certa comunanza ideologica (nel peggiore dei casi) salvo poi accorgersi che la Cina è anche quella dei fatti di Hong Kong.
Non si comprende in tutte le sue implicazioni l’ammiccare ai risultati cinesi per il contenimento del virus, oscillando da un rigo all’altro (tra frasi avversative seguite da un non troppo tra le righe “nonostante ciò”) e sostenendo che, viceversa, nei Paesi meno neoliberisti la stessa cosa starebbe avvenendo con maggiori difficoltà (fortunatamente senza temere di sparire per aver fatto due passi in più del consentito). Ci si dimentica che il virus si è originato proprio lì, probabilmente perché le condizioni generali del Paese continuano ad evidenziare una percentuale davvero elevata di popolazione molto al di sotto della soglia di povertà, in condizioni assolutamente deprecabili di vita. La quale probabilmente auspicherebbe i controlli, la qualità del servizio medico-sanitario, gli standard minimi di sicurezza previsti nei Paesi occidentali. Se la globalizzazione e la competizione sui mercati hanno indubbiamente influito sul prodursi delle condizioni affinché il virus potesse effettuare un salto di specie e diffondersi con estrema facilità in tutto il mondo, allo stesso modo l’incapacità di liberalizzare asset strategici per il Paese ha influito sul mantenimento di certi standard igienico-sanitari, difficilmente replicabili in occidente, che sono stati una concausa dell’affiorare del virus.
È difficile spiegarsi, altrimenti, come autorevoli uomini di scienza e ricercatori avessero previsto non solo l’insorgere di virus di questa natura, ma addirittura avessero fatto ipotesi accurate sui luoghi da cui questo avrebbe potuto originarsi. Qualora non siano sapientemente equilibrati, aspetti culturali, economici e sociali possono generare problemi collettivi di enormi proporzioni. Ancora una volta la polarizzazione risulta essere il problema. Difficile affermare, tuttavia, che tali condizioni di vita siano il frutto di decenni di politiche neoliberiste, che la Cina ha iniziato ad attivare parzialmente e da tempo solo relativamente recente. Altre spiegazioni necessitano di essere ponderate.
Global warming
Un ultimo fatto vorrei analizzare, prima di trarre alcune provvisorie conclusioni da queste riflessioni da quarantena, ed è collegato alla straordinaria contraddizione con cui il villaggio globale dovrà fare i conti nei tempi della sua maturità, che paiono avvicinarsi ma essere ancora troppo distanti. Contraddizione che, come tale, ci pone davanti ad un paradosso: il global warming. Harvey analizza la questione in coda alle altre, sbrigativamente, senza analizzare a fondo le sue implicazioni: «La scelleratezza di questo sovra-consumo ha avuto un ruolo importante nel degrado ambientale. La cancellazione dei voli delle compagnie aeree e la riduzione radicale dei trasporti e dei movimenti hanno avuto conseguenze positive nelle emissioni di gas a effetto serra. La qualità dell’aria a Wuhan è molto migliorata, come anche in molte città degli Stati Uniti. I siti di ecoturismo avranno il tempo per riprendersi. I cigni sono tornati ai canali di Venezia. Nella misura in cui il gusto per il consumo eccessivo e sconsiderato è ridotto, ci potrebbero essere alcuni benefici a lungo termine».
Affermazioni di questo tipo appaiono semplificazioni estreme almeno per due ordini di ragioni. La prima costatazione da fare, la più urgente dal punto di vista dell’analisi, è che il problema del global warming è qualcosa che uno Stato, una comunità, una civiltà deve potersi permettere. Senza esplicitare ulteriormente è difficile capire la natura di questa affermazione, ma se ci riflettiamo più da vicino possiamo vedere come l’urgenza di tale problema possa esser considerata in tutta la sua portata solo da una prospettiva di generale benessere e soddisfazione del più alto numero possibile di individui interni ad una comunità. Se l’allocazione di risorse ed energie ed il susseguente inquinamento provocato dal loro uso è volto al soddisfacimento dei bisogni essenziali degli esseri umani (case, cibo, utilities come energia elettrica, acqua corrente), non solo è complicato dedicarsi a problemi che non siano immediatamente urgenti quanto il riuscire a sopravvivere fino al giorno successivo, ma non si avrebbero le risorse necessarie (psicologiche, fisiche, intellettuali) per sviluppare delle soluzioni efficienti. Non è un caso che l’Europa si sia effettivamente occupata del problema in un periodo storico in cui le esigenze principali degli individui che la abitano sono, per la stragrande maggioranza, soddisfatte pienamente. Questo ragionamento ci porta dritti a comprendere come mai Paesi in via di sviluppo come Cina, India, sud est Asiatico non solo siano tra i Paesi nel mondo ad emettere un maggior numero di scorie tossiche per l’ambiente, ma anche quelli più sordi in occasione delle conferenze sul clima come quella di Parigi dello scorso 2018. Una percentuale ancora eccessivamente grande della popolazione di questi Paesi vive, o meglio tenta di sopravvivere, in condizioni di vita medievali (volendo usare l’accezione in senso negativo), ed è pertanto difficile aspettarsi da questo fronte un impegno collettivo per un risultato meno urgente rispetto a quello di procurarsi da vivere per l’immediato futuro.
Il secondo ordine di ragioni, dal quale è possibile ricavare quella che è forse la contraddizione decisiva del nostro tempo, è relativo alle tecnologie. Il global warming è un problema risolvibile esclusivamente sulla scia di un miglioramento ed una riconversione, lenta e costante, delle tecnologie impiegate per la produzione. Tali miglioramento e riconversione devono esser favoriti da una crescita economica sostenuta e da investimenti cospicui .
Ma un rallentamento dell’economia, va da sé, significa un rallentamento nella produzione di tali risorse e quindi un inevitabile, ulteriore slittamento rispetto alla risoluzione del problema. Sta proprio qui la contraddizione. Il riuscire a ridurre le emissioni generate dalle nostre tecnologie deve passare attraverso l’espansione esponenziale di queste ultime(6). Ecco che la sensazione di leggerezza che l’affermazione di Harvey genera nel lettore viene subito disattesa da una più attenta disamina del problema. Ma se è questa, come ho cercato di mostrare, la contraddizione del nostro tempo, sarà il suo scioglimento a dare la misura della nostra maturità.
Last but not least
Bisognerebbe partire da lontano e mostrare come, forse, il “capitalismo” esista da sempre, se l’accezione è quella che descrive il tentativo umano di migliorare la propria condizione attraverso l’ausilio delle risorse fisiche ed intellettuali di cui si dispone. Senza dover scomodare la natura, il cui processo operativo di selezione sembra coincidere, ad un primo sguardo (ma sul quale bisogna ancora ragionare). Non per dimostrare che l’originaria forza selettiva di quest’ultima debba essere la misura dell’umano, ma nel tentativo più incerto di cucire quella frattura originaria con il mondo animale attraverso la quale l’uomo ha creduto di originarsi, e per via della quale egli ha sofferto il suo dramma esistenziale). Soprattutto oggi, laddove il tentativo di soddisfare i propri bisogni può prendere strade diverse, eticamente sostenibili.
Siamo organismi giovani ed erranti, abbiamo fatto certi passi e molti di questi sono stati drammatici. Forse, allora, il termine capitalismo risulta inadatto a descrivere una modalità operativa della nostra specie, ed ancor meno senso ha la sua criminalizzazione, così come la conseguente polarizzazione tra Stato e Mercato. La partita oggi più che mai si gioca sugli equilibri incerti di ciò che possediamo, attendendo che sia il tempo per istituire qualcosa di nuovo. Oggi un numero crescente di individui può abbandonare la condizione alla quale è stato destinato alla nascita; più che polarizzarci dovremmo raffinare i nostri strumenti per renderlo possibile ad un numero sempre più crescente di esseri viventi. Non so se sia questo il destino irrealizzato dell’occidente. Spero sia quello della mia generazione.
Note:
1 https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions
3 https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Cassa_Depositi_e_Prestiti#Dati
6 https://www.internazionale.it/opinione/gabriele-crescente/2020/03/19/coronavirus-clima