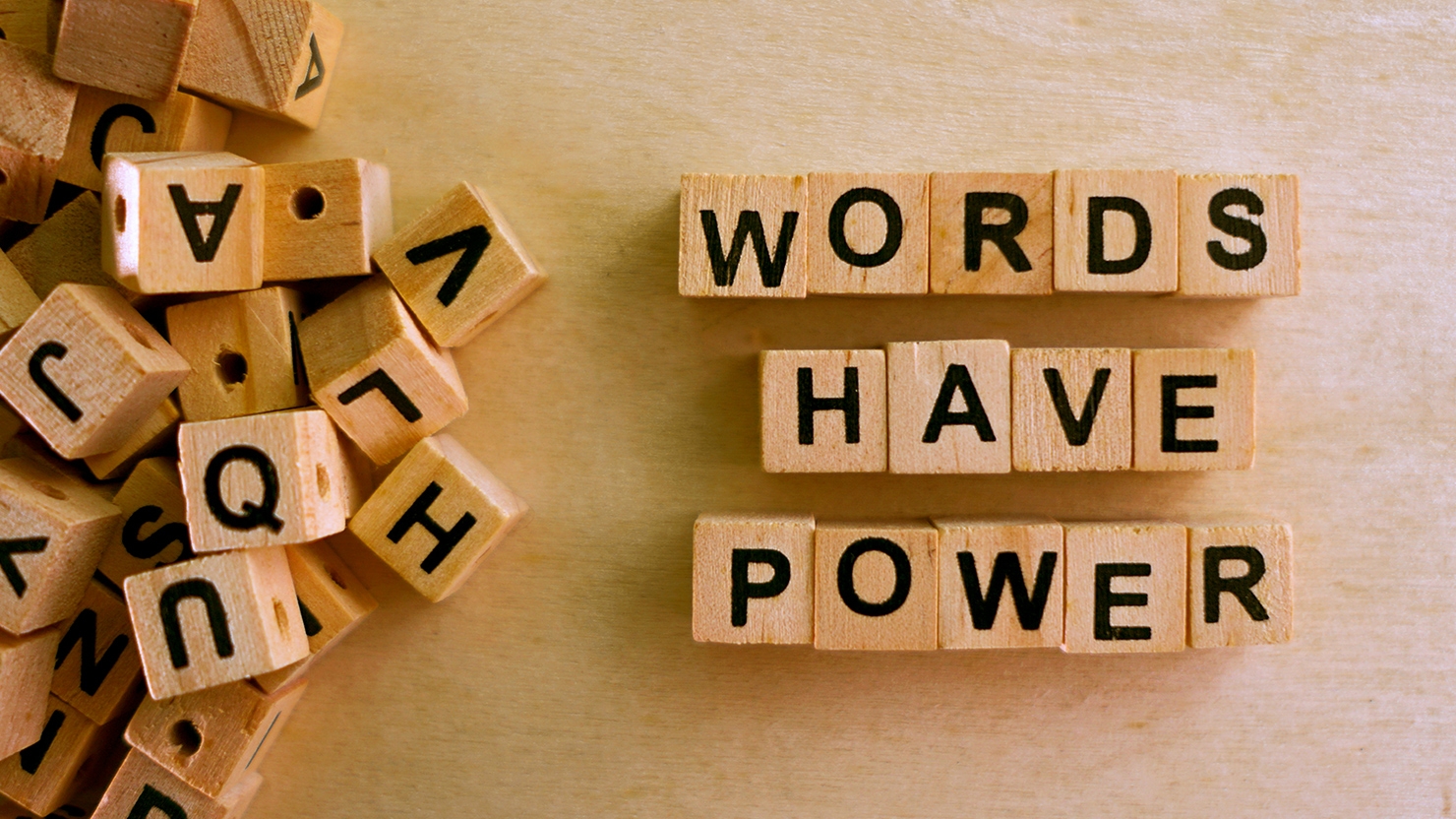Stato di eccezione, salus populi e storia del diritto
O della poca eccezionalità dello “stato di eccezione”
Fa una certa impressione leggere in retrospettiva le parole usate da Giorgio Agamben a partire da fine febbraio sulle colonne del Manifesto e in un’infilata di interventi online sul sito della casa editrice Quodlibet che invitano a riflettere, fra le altre cose, sullo stato di eccezione determinato dal diffondersi del contagio da COVID-19. Per il filosofo romano la “invenzione di un’epidemia” avrebbe consentito al governo italiano di varare “frenetiche, irrazionali e del tutto immotivate misure di emergenza”. Con la complicità dei mezzi d’informazione le autorità avrebbero creato un “clima di panico” diretto a legittimare l’impiego dello “stato di eccezione” come “paradigma normale di governo”.
Il diffondersi del virus in tutto il mondo e i crescenti dati sulla mortalità, nel frattempo, hanno smentito il punto di partenza di queste osservazioni dal tono provocatorio. Ma in esse può cogliersi forse un nucleo di verità. Come già in passato, infatti, anche di recente vari provvedimenti che hanno inciso in modo significativo sulla riduzione dell’ampiezza e sul riconoscimento stesso dei diritti fondamentali sono stati giustificati come risposta a un bisogno di sicurezza.
Potrebbe avere ragione Agamben, dunque, a sottolineare quanto poco eccezionali siano le frequenti situazioni di emergenza che ricorrono nel discorso politico degli ultimi anni insieme alla ripetuta evocazione di uno stato di eccezione. A parte questo spunto di riflessione, però, la ricostruzione di una teoria generale da lui offerta nel saggio pubblicato nel 2003 con il titolo Stato di eccezione e ripresa nei recenti interventi appare a più livelli frutto di distorsioni e forzature. Così, il tentativo di individuare nel iustitium dell’antico diritto romano l’archetipo dello stato di eccezione costituisce l’esempio di un uso della storia basato su una lettura parziale e deformante delle fonti antiche condotta sulla scorta di rapide incursioni in alcune pagine della storiografia del secondo Ottocento tedesco.
Ha certamente torto Agamben quando, appoggiandosi a uno studio di Adolph Nissen pubblicato nel 1877, afferma che il iustitium avrebbe comportato “una sospensione del diritto come tale”. Ha torto ed è ingenuo a pensare che la natura di tale fenomeno di arresto del ius potrebbe ricavarsi dall’etimologia del termine latino, riconducibile a ius stare: “quando ius stat”, come si legge in un passo del grammatico Carisio (IV sec. d.C.) ripreso testualmente da uno scoliaste di Lucano. Agamben parla genericamente di “grammatici” al plurale, facendo credere che questa etimologia possa considerarsi sicura. Egli omette inoltre le parole “nec causa agitur”, che nel passo dello scoliaste lasciano trasparire come il ius stare di Carisio fosse connesso a una sospensione delle attività giudiziarie (“iustitium quando ius stat nec causa agitur, sicut solstitium dicitur”).
In realtà, gli studiosi della lingua latina e del diritto romano hanno chiarito da tempo che la parola iustitium deriva piuttosto da ius sistere, da interpretare con significato diverso da quello rivendicato da Agamben. Nelle fonti, infatti, il vocabolo ricorre con riferimento ai primi secoli della res publica romana per indicare una sospensione dell’attività giudiziaria (ius, dunque, nel suo significato processuale), che in alcuni casi poteva comportare anche quella degli affari pubblici e privati. Una conferma può trovarsi nei termini ἀπραξία e ἀργία, impiegati dagli storici greci per rendere il latino iustitium, che traducono l’idea di un’inattività, non quella di una sospensione dell’intero ordinamento giuridico.
Nel 431 a.C., per esempio, il dittatore Postumio Tuberto aveva indetto il iustitium insieme al tumultus in quanto “la città non doveva fare altro che prepararsi alla guerra” (Liv. 4.26.12). Si trattava dunque di una sospensione disposta insieme alla dichiarazione del tumultus per fronteggiare i pericoli di una guerra imminente e per facilitare, oltre alle operazioni di leva, la preparazione delle trincee e delle attività belliche. In tali circostanze poteva disporsi anche la chiusura delle tabernae in tutta l’Urbe o in una sua parte. Ciò avvenne con il iustitium proclamato nel 458 a.C. dal dittatore Quinzio Cincinnato e con quello proclamato nel 456 a.C. dal dittatore Emilio Mamercino in occasione della guerra contro gli Equi e i Volsci e di quella contro i Veienti e i Fidenati (Liv. 3.27.2 e 41.3.9).
Il iustitium dei Romani, pertanto, non era il iustitium di Agamben. Non determinava una sospensione del diritto o delle garanzie fondamentali dei cittadini. Non era uno “spazio anomico” nel quale sarebbe stato impossibile valutare sul piano giuridico la liceità delle azioni compiute, perché sarebbe mancata la possibilità di stabilire se esse trasgredissero o meno un diritto che sarebbe stato, appunto, sospeso. Di conseguenza, lo stato di eccezione non può ricondursi al modello storico di una situazione di “vuoto giuridico” dipendente dalla proclamazione del iustitium.
Con buona pace di Agamben, ben più convincente appare l’intuizione di Carl Schmitt, che nell’indagare lo stato di eccezione in rapporto alla sovranità preferiva ricondurlo alla pienezza dei poteri riscontrabile nella dittatura romana secondo la rappresentazione datane da Theodor Mommsen.
Nel diritto romano di età repubblicana, in effetti, l’idea di quello che oggi chiameremmo stato di eccezione sembra trovare punti di contatto proprio con tale figura, cui si ricorreva in situazioni di pericolo esterno o interno. Nominato in casi eccezionali da uno dei due consoli con un rito particolare e senza procedere alle elezioni, l’antico dictator concentrava nelle proprie mani un potere di comando civile e militare superiore a quello di tutti i magistrati ‘ordinari’ e non aveva colleghi di pari grado che potessero paralizzare i suoi atti. Anche il veto dei tribuni della plebe, l’intercessio, perdeva efficacia nei suoi confronti. Il suo summum imperium era simboleggiato da ben ventiquattro littori. All’interno della città di Roma essi lo accompagnavano con le scuri inserite nei fasci, a significare che il suo potere non era limitato dal ius provocationis, la garanzia fondamentale che dalla nascita della libera res publica assicurava a ogni cittadino romano il diritto di chiedere l’instaurazione di un processo innanzi al popolo prima di irrogare la pena capitale o multe superiori a un determinato ammontare. Il carattere eccezionale della dittatura romana, d’altra parte, si manifestava nella regola inveterata in forza della quale la sua durata non poteva eccedere il tempo strettamente necessario per svolgere il compito per cui era stata creata, come la conduzione di guerre contro nemici esterni (rei gerundae causa) o la repressione di sommosse interne (seditionis sedandae causa). La carica non poteva eccedere comunque il limite massimo di sei mesi. Solo entro un tempo predeterminato, infatti, poteva tollerarsi un potere che si poneva al di sopra delle due roccaforti a difesa della libertà (duae arces libertatis tuendae) di cui parla Livio: il diritto di provocare ad populum e l’intercessio tribunizia.
Agamben, inoltre, non tiene conto del fatto che già a partire dalla prima età repubblicana il iustitium non era proclamato dal senato, ma dai magistrati forniti del potere di comando militare: consoli, pretori e tribuni militari con potestà consolare. Più numerosi sono i casi in cui a disporre il iustitium, senza neppure consultare il senato, era proprio il dittatore. A fronte di questo dato risulta storicamente infondata la prospettiva secondo cui “lo stato di eccezione non si definisce, secondo il modello dittatoriale, come una pienezza dei poteri, … ma come … un vuoto e un arresto del diritto.” Tale prospettiva, infatti, trascura che durante il iustitium il dittatore che lo aveva proclamato continuava a esercitare i poteri per i quali era stato nominato allo scopo di far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo: con la conseguenza paradossale che, stando al paradigma di Agamben, sarebbero venuti a coesistere la pienezza dei poteri dittatoriali e il vuoto del diritto determinato dal iustitium.
La ricostruzione storica disegnata da Agamben, peraltro, risulta fuorviante anche nel momento in cui egli preferisce concentrarsi sul iustitium indetto dal senato nel corso dell’ultima età repubblicana, accostandolo sulla scia di Nissen al senatus consultum cd. ultimum. Con quest’ultimo provvedimento il consesso senatorio invitava i consoli e gli altri magistrati a compiere tutto quanto ritenuto necessario per la salvezza dello Stato (Videant consules, … ne quid res publica detrimenti capiat). Non ha a che fare con il iustitium, dunque, la questione della valutazione dell’operato dei magistrati in risposta a tale invito: Agamben richiama a sproposito gli episodi relativi all’uccisione di Caio Gracco da parte di Lucio Opimio (121 a.C.) e dei Catilinari da parte di Cicerone (63 a.C.), che riguardano propriamente il tema della ‘legalità’ degli effetti del senatus consultum cd. ultimum. Fuori luogo, in ogni caso, sono le precisazioni sul valore dell’aggettivo ultimum che definirebbe “la specificità rispetto agli altri consulta”, ma “non sembra avere ricevuto la dovuta attenzione da parte degli studiosi”. Anche se Agamben non lo sa, infatti, proprio gli studiosi continuano a usare l’aggettivo per riferirsi al senatus consultum de re publica defendenda consapevoli del suo significato puramente convenzionale desunto da un passo di Cesare (Bellum civile 1.5.3) in cui ricorre insieme all’aggettivo extremum con valore non tecnico.
Certo, senatus consultum cd. ultimum e iustitium hanno come obiettivo comune la salvezza dell’intera comunità politica: la salvezza del popolo – salus populi – che nel trattato di Cicerone sulle leggi assurge a suprema lex per chi è posto alla guida dello Stato (De legibus 3.1.8). Si tratta però di due provvedimenti distinti.
L’epigrafe con cui si apre Stato di eccezione, “Quare siletis juristae in munere vestro?”, è ripresa da Agamben con una variante nell’intervento pubblicato il 14 aprile sul sito Quodlibet. Anche se la sostituzione dell’indicativo “siletis” con l’imperativo “silete” appare incerta sul piano linguistico, la domanda (che riecheggia il “Sileamus in munere alieno” di Carl Schmitt riferito all’abdicazione della scienza giuridica positivista dal Völkerrecht, a sua volta ispirato al celebre “Silete theologi in munere alieno” di Alberico Gentili) è una provocazione salutare: i giuristi non possono e non devono tacere su questioni così importanti. Ma per dialogare con i giuristi un minimo di preparazione può giovare.