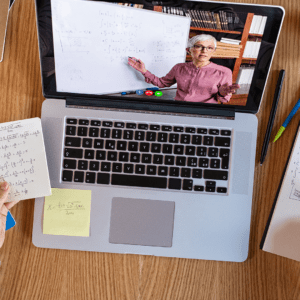La scuola e la DaD ai tempi del Covid-19
Mai come in questi giorni la scuola è stata così tanto al centro dell’attenzione. La feroce querelle scuole aperte vs scuole chiuse divide amici e persino famiglie. Ma è davvero una questione di luogo o di metodo?
Ho atteso alcuni mesi prima di scrivere questa riflessione sulla scuola ai tempi del Covid-19. Avevo bisogno di raccogliere testimonianze, di incrociare dati ed esperienze, di metterle in collegamento con la mia. Ci è voluto del tempo prima di costruirmi un recinto che fosse ben al riparo dallo strepito quotidiano che è montato sulla querelle scuole aperte/scuole chiuse. La DaD (Didattica a Distanza), manna dal cielo e deus ex-machina a marzo e aprile scorsi, si è convertita in necessità inevitabile quando non addirittura in male assoluto.
Travolta dal clamore di opinionisti, giornalisti, politologi mi rendo conto di come siano veramente pochi quelli che hanno un’idea chiara di cosa sia la scuola oggi. Da certi commenti, viene fuori il riflesso assai sbiadito di quello che la scuola è stata fino al secolo scorso. Nulla più che un ricordo. Al quale volgono il pensiero tutti quando ci dicono cosa si dovrebbe o non si dovrebbe fare oggi, nel pieno di una pandemia devastante che ha mutato profondamente il corso delle nostre vite.
>> Leggi anche: SO-STARE senza abbracci: la psicologia osserva il comportamento dei più piccoli
Chi la vive, da docente e da studente, sa che quella scuola non esiste più. Non esiste per tante ragioni. Una fra tutte: i ragazzi non apprendono più allo stesso modo in cui lo facevamo noi nel secolo scorso. Non entrerò qui nel dettaglio di tecnicismi che possono solo contribuire ad annoiare chi legge (apprendimento lineare vs apprendimento reticolare).
Va detto, tuttavia, che chi pensa che la scuola sia ancora quel luogo in cui uno (il docente) sta in cattedra a parlare per ore e altri (gli alunni) stanno seduti ad ascoltare ha un’idea obsoleta di scuola. Eppure, purtroppo, su questa visione si costruisce la narrazione di una scuola in ginocchio a causa del Covid-19.
È vero, la scuola fuori dall’edificio scolastico non è uguale a quella che si svolge davanti a un computer. Qualcuno l’ha definita “apprendimento in condizioni estreme”.
Comunque la si voglia connotare, in questi giorni sembra che tutti abbiano qualcosa da dire sulla scuola. E il loro pensiero diventa un assioma. Inconfutabile, indiscutibile. Incontrastato, appunto, come lo sono tutti gli assiomi. Quei pochi che la scuola la vivono tutti i giorni, invece, parlano molto di didattica e si interrogano. Perché, pur stando dentro le scuole e vivendole, sono sopraffatti da tantissimi dubbi.
Quando è iniziata la crisi della scuola?
Questo è un po’ il punto di partenza di questa riflessione. Partiamo dunque da un interrogativo: cosa intendiamo per didattica? A cosa miriamo quando la esercitiamo con i nostri alunni? Non dove, attenzione, ma cosa. E qui già iniziano i primi problemi. Perché se la didattica online mira a riproporre, in modo meccanico, metodi di trasmissione del sapere che sono già fallimentari in presenza è ovvio che dobbiamo preoccuparci.
Ma è davvero il luogo il problema? O piuttosto il metodo? Se si vuole insistere a tutti i costi sul prodotto finale, è ovvio che la DaD non funziona. Se gli scopi sono il programma piuttosto che le competenze, il voto finale piuttosto che il processo di apprendimento allora il senso del nostro dibattito è già svilito in partenza, ne usciamo sconfitti. Ma, lasciatemelo scrivere, abbiamo perso anche in una situazione di normalità, con scuole aperte e alunni in presenza.
L’idea di scuola, dalla riforma Gelmini ad oggi, assomiglia molto più a quella di una fabbrica che a un luogo all’interno del quale si esercitano il sapere, lo spirito critico e, dunque, il pensiero divergente. Ma la scuola è davvero una fabbrica? Dieci anni fa, Martha Nussbaum, docente all’università di Chicago, ha pubblicato per Il Mulino un saggio illuminante già dal titolo: Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica.
Nella prefazione a cura di Tullio De Mauro, si fa riferimento alla scuola come a «un insieme stratificato e complesso, eterogeneo al suo interno, connesso da legami diversi con differenti società, culture, saperi, tradizioni nazionali, dipendente da orientamenti dei decisori politici, ma anche da richieste e sollecitazioni implicite o esplicite, spesso contraddittorie, provenienti dall’ambiente in cui le scuole operano».
Partirei proprio da quegli “orientamenti dei decisori politici” che, prevalendo su tutto il resto, hanno finito per mettere al centro del sistema scolastico la crescita del Prodotto Interno Lordo. In quest’ottica, la crisi mondiale dell’istruzione è già storia. Non si sta giocando adesso, in mezzo alla pandemia, è esplosa in tutta la sua virulenza già nel 2011 e si preparava almeno da un decennio.
A partire da quel momento, in tutto il mondo, il prodotto finale del processo di apprendimento è diventato il profitto. L’ossessione per la crescita economica e la competitività ha spinto l’acceleratore sulla diffusione di test standardizzati (vedasi le Prove Invalsi) a discapito di un’idea socratica di apprendimento attivo che prevede lo sviluppo di un pensiero critico da parte degli alunni.
Contestualmente, vanno inseriti anche i numerosi tagli al budget delle scuole per rientrare nel pareggio di bilancio (analogo ragionamento vale, ovviamente, anche per la sanità). La pandemia – che pure ha creato dei danni enormi in termini anche sociali – non è la responsabile della crisi della scuola. Le ha solo assestato il colpo di grazia. Ecco perché ridurre tutto alla querelle scuole aperte/chiuse è svilente. Serve solo a mostrare la punta di un iceberg il cui fondo viene volutamente ignorato, da più parti, da almeno vent’anni.
Che cosa intendiamo per didattica?
Veniamo poi al secondo punto, a mio avviso strettamente collegato al primo. In questi anni, ci si è lamentati del fatto che gli studenti non sappiano più scrivere. È vero. Gli alunni non sanno più scrivere correttamente in italiano. Perché questo accade?
La risposta è più semplice di quanto si pensi. Non servono indagini capillari. Gli studenti non sanno scrivere perché a scuola non scrivono. O meglio, lo fanno soltanto sei volte l’anno, quando devono svolgere i temi di valutazione quadrimestrale. E non sanno scrivere anche perché non leggono, né a scuola né tanto meno a casa.
Cosa abbiamo fatto per rovesciare questa situazione? In generale, nessun ministro si è mai occupato seriamente di questo problema, a meno che non si pensi che possa aiutarci a risolverlo l’esercizio sterile per lo svolgimento delle Prove Invalsi.
Eppure, esistono dei metodi innovativi e molti docenti li utilizzano formandosi, spesso unicamente, a spese proprie. Ne cito uno solo, perché accompagna le mie lezioni da anni: è il Writing and Reading Workshop che, tramite l’utilizzo della didattica laboratoriale, aiuta lo studente a sviluppare l’abitudine alla riflessione metacognitiva e a metterlo al centro del processo educativo.
Cos’è la didattica dunque? Iniziamo col dire ciò che sicuramente non può essere: esercizio passivo. Didattica non significa stare seduti per delle ore davanti a un docente che parla (poco importa se all’interno di una classe reale o virtuale). Didattica significa piuttosto insegnare a istituire connessioni, a porsi delle domande, a rintracciare degli elementi chiave e a saperli organizzare; didattica significa fornire agli alunni degli strumenti utili a orientarsi nel testo, imparando l’arte di saper rendere visibile il pensiero e di sviluppare un proprio punto di vista.
I
n una parola, didattica significa pensare. A questo serve la scuola: osservare, comprendere in modo significativo, essere capaci di esercitare il pensiero critico. Chi, oggi, dice di essere preoccupato per la valutazione in DaD (e sono tanti quelli che lo scrivono e lo dicono) dimostra di essere lontano anni luce da questa idea di scuola che pure tanti docenti cercano di mettere in pratica con tanto sacrificio.
“Le parole che usiamo rappresentano il nostro punto di vista sul mondo”
Scelgo volutamente di concludere questa riflessione con la citazione della collega Valentina Felici, perché anche le parole che usiamo sono importanti e, come dice lei stessa, rappresentano il nostro punto di vista sul mondo.
Che vocaboli si scelgono nei vari Paesi europei per descrivere la scuola durante la quarantena? In Italia, la chiamiamo Didattica a Distanza.
Una definizione errata dal punto di vista semantico, in quanto relega ancora una volta l’alunno a un ruolo passivo e marginale all’interno del processo di apprendimento. Fanno molto meglio di noi in Spagna dove dietro la definizione di Aprendemos en casa, volutamente al plurale, si sceglie invece di porre l’attenzione su ciò che davvero dovrebbe essere la scuola sempre, anche quando non esiste alcuna emergenza: un luogo in cui si impara tutti insieme, alunni e docenti.
Approfondimenti:
- https://www.corriere.it/scuola/universita/17_febbraio_04/gli-studenti-non-sanno-l-italiano-denuncia-600-prof-universitari-3db50faa-eb16-11e6-ad6d-d4b358125f7a.shtml
- https://www.italianwritingteachers.it/
- https://felicidistudiare.com/2020/03/29/dad-una-questione-semantica-e-non-solo/