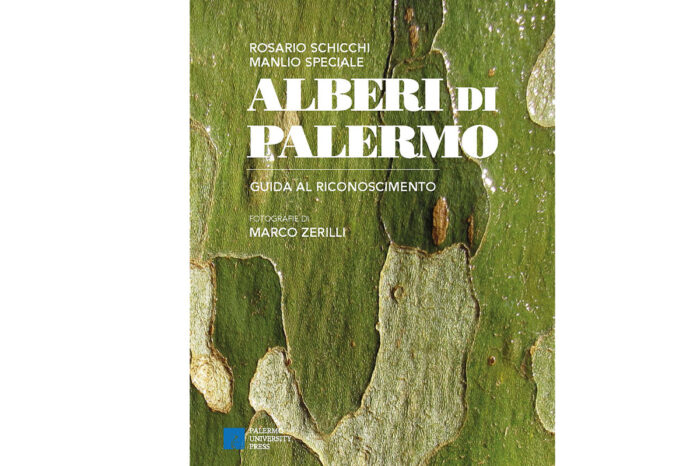Don Milani restituito (finalmente) alla storia. Su L’equivoco don Milani di Adolfo Scotto di Luzio

La personalità di don Lorenzo Milani risulta sicuramente sfuggente per l’indagine storica. Non solo per il mito che intorno alla sua figura si è costituito, e per le strumentalizzazioni cui è stata oggetto. Ma anche perché un’analisi sia teoretica sia di contesto della sua attività, con particolare riguardo alla riflessione didattico-pedagogica, comporta un approccio metodologico decisamente plurale. Non basta ripercorrerne la biografia e gli scritti, in quanto i fattori di contesto da prendere in considerazione sono, nel suo caso, molteplici: lo sviluppo socio-economico-politico dell’Italia di quegli anni, certamente; ma anche il dibattito interno al mondo cattolico italiano. Ma l’indagine storica deve anche confrontarsi con la complessa psicologia del personaggio; in particolare quando motivazioni di carattere biografico ed etico -comprensibili nel suo caso però solo all’interno di un ben determinato orizzonte teologico- condizionano prese di posizione teoriche particolarmente impegnative. Da questo punto di vista le recenti incursioni di Aurelio Musi in quel campo di studi di particolare complessità metodologica che è la storia dei sentimenti forniscono un modello convincente su come impostare il rapporto tra soggettività e storia, dimensione collettiva e partecipazione individuale all’interno di trasformazioni epocali di particolare rilevanza. In assenza di queste prerogative, è facile scadere nella mitologizzazione, spesso nascosta dietro una scansione evenemenziale apparentemente corretta, ma incapace di cogliere i nessi forti in grado di offrire interpretazioni storiografiche convincenti.
Lo studio appena pubblicato di Adolfo Scotto di Luzio (L’equivoco don Milani, Einaudi), risponde a nostro parere felicemente a tali esigenze metodologiche. Nelle sue pagine la storia si riappropria della complessa personalità del sacerdote di Barbiana, rivelando il carattere spesso caricaturale del modo in cui la sua figura viene riferita alle problematiche del presente.
Le difficoltà interpretative poste dalla personalità di don Milani e dalla sua opera si individuano già nel titolo: perché «equivoco»? Innanzitutto per un fraintendimento (non necessariamente involontario) presente in molti studi, il cui obiettivo è quello di identificare il progetto di Barbiana con un’idea di scuola (quella che si invera negli attuali progetti riformatori) rispetto alla quale lo stesso sacerdote, con molta probabilità, avrebbe fatto fatica a riconoscersi. Ma l’ambiguità all’origine dell’equivoco è presente nello stesso pensiero di don Milani; il quale è tentato di risolvere alcuni problematici nodi teorici del proprio pensiero con radicali prese di posizione di carattere axiologico. Le quali, se ben esemplificano le motivazioni che spingono Milani nel suo impegno politico-religioso, pure rivelano intime contraddizioni che conducono le sue proposte verso finalità in contrasto con le istanze di una pedagogia realmente progressista.
Scotto di Luzio, nel mettere a fuoco questo aspetto che percorre tutte le parti del suo studio, fa innanzitutto riferimento al dibattito che investe il mondo cattolico italiano nel secondo dopoguerra. La posizione in cui don Milani si riconosce intende riconquistare all’egemonia ecclesiale la massa sterminata degli ultimi, e in particolare il mondo contadino, per sottrarla all’influenza, a suo parere nefasta, della modernizzazione. Rispetto a questa esigenza egli manifesta una forte delusione per il ruolo politico assunto dalla Democrazia Cristiana dopo la vittoria nelle elezioni del 1948: «Promettendo una società giusta, nel nome degli ideali cristiani, la DC aveva ottenuto dal popolo il potere ma si era servita di quel potere per assicurare i padroni contro la minaccia dei comunisti». La polemica non verte tanto sull’anticomunismo, condiviso da tutti, ma sulla possibilità che attraverso quella politica la classe degli ultimi sarebbe stata in balia delle opposte alternative, entrambe negative, del comunismo appunto o della secolarizzazione. Con il rischio, dal punto di vista di Milani, di trasformare il contadino in borghese: «don Milani plasma un potente mito educativo di natura salvifica; […] nella lunga durata dell’illusione romantica del povero che insegna al povero.» Il proposito di non allontanare il povero dalla sua origine spiega il motivo per cui è bene non introdurlo alla ragione autonoma, «che è sempre separazione e rifiuto dell’origine». Si comprende allora la dura presa di posizione di Gianni Rodari che, in una recensione pubblicata da “l’Unità”, sbagliando peraltro il nome del sacerdote in “Angelo Milano”, polemizzava «contro la concezione attivistico-politico-dopolavoristica della parrocchia». L’apertura dei poveri alla modernità impedirebbe infatti una loro piena integrazione nella comunità ecclesiale. Si tratta di un fondamento dell’azione di don Milani importante, in quanto chiarisce la sua estraneità alla tradizione della pedagogia democratica (Lodi, Rodari), in contrasto con quanto sostenuto in modo ossessivo e poco argomentato dalla pubblicistica di questi anni.
Un altro aspetto che Scotto di Luzio ha il merito di evidenziare è la sostanziale discontinuità tra le Esperienze pastorali e la famosa Lettera a una professoressa. Non c’è dubbio che esista anche un elemento in comune, ossia la già richiamata volontà di non strappare il povero dal suo contesto. La discontinuità, assai più significativa, sta invece nel fatto che il Milani delle Esperienze pastorali è ancora, didatticamente parlando, un disciplinarista. Particolare che non deve sorprendere, se si pensa alla sua formazione iniziale, fortemente condizionata dalla frequentazione in età adolescenziale del “gentiliano” Giorgio Pasquali, «stretto da vincoli affettivi e forti legami accademico-intellettuali alla famiglia Milani». Come vedremo, tale precisazione risulta essenziale per alcune contraddizioni che caratterizzano la Lettera, non ultima la vexata quaestio su chi l’abbia effettivamente scritta.
Non poteva poi Di Luzio non affrontare la questione della lingua, sulla quale si sono fantasticate in questi anni continuità e innovazioni teoretiche senza fondamento. A dire il vero, e Scotto di Luzio non esita a intervenire in merito, a generare l’equivoco è stato lo stesso Tullio De Mauro, ipotizzando questa affinità tra le proprie riflessioni e quelle di Milani. In una fase storica sospetta, però, quando lo stesso linguista si faceva promotore di quel radicale processo di riforma della scuola tuttora in corso; e il riferimento a Milani sembrava un ottimo espediente politico per mascherare il progetto ideologico e cui l’azione di riforma obbediva. La questione verte, in particolare, sul ruolo attribuito alla grammatica. É indubbio che, in quanto codificazione della lingua, essa genera, in virtù del saperla o meno padroneggiare, una gerachizzazione sociale. Ma, nello stesso tempo, essa costituisce pure una spinta all’unificazione e strumento emancipativo. Tullio De Mauro aveva ben compreso la relazione tra lingua comune e democrazia, ed era consapevole di quanto il padroneggiare la lingua comune metta nelle condizioni di esercitare capacità critica, di proporre ipotesi trasformative rispetto all’ordine dominante. Don Milani invece -e questo è forse il suo principale errore evidenziato nello studio di Scotto di Luzio- passa dalla critica sociale (condivisibile) a quella dei contenuti didattici. Nei due successivi capitoli, intitolati brillantemente La lingua dei diseguali e La lingua degli eguali si pone in evidenza la singolarità e la paradossalità della convinzione di don Milani, per il quale «le lingue le creano i poveri e poi seguitano a rinnovarle all’infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro.» In questo modo il sacerdote pone il problema del linguaggio in modo non tecnico ma assiologico. Per giungere alla conclusione che non sia importante studiare Dante o altri classici, in quanto l’obiettivo è quello di liberare i poveri dalla soggezione della cultura dei figli dei padroni. Un modo di intendere il rapporto tra lingua e classi sociali assai poco dialettico; in contrasto con quello che, in ambito progressista, aveva invece definito Antonio Gramsci (strappare ai borghesi la loro cultura per metterla a disposizione dell’intera società). Concetto ben illustrato da Scotto di Luzio: «La scrittura viene sì trasferita in uno spazio separato, allontanata dalla cacofonia del mondo, ma è possibile farla nostra. Le regole hanno questo di caratteristico: obbligano a comportarsi in un certo modo e per questo prevedono un percorso di apprendimento. Le regole in altri termini si imparano. É così che il progetto elitario, la lingua dei diseguali, si carica di valori storicamente progressivi».
Milani si rende conto però di tale contraddizione; la sua formazione “gentiliana” crea in lui la consapevolezza di quanto sia rilevante, ai fini di una personale emancipazione, padroneggiare il linguaggio comune. Quest’aspetto contraddittorio era già stato notato in uno degli studi, troppo poco citato, più rilevanti dedicati a don Milani in anni recenti (Mino Conte, Didattica minima, Cap.3): «Siamo sicuri […] che la migliore politica contro l’oppressore comporti l’esaltare le condizioni di partenza di chi ha subito e subisce ogni forma di ingiustizia[…]? Se l’umiliato e offeso […] per riparare l’onta subita, si premura di rinforzare la propria posizione di subalternità e minorità sociale, ha nuovamente perso. Reazione umana, umanissima, ma che condanna l’escluso a rimanere tale».
Peraltro, come nota Scotto di Luzio, questa volontà di preservare la propria spontaneità, rende indisponibile proprio a chi ne avrebbe più bisogno il linguaggio con cui articolare la propria opposizione. Da qui il ruolo dell’educatore diventa contraddittorio: «Impedendo l’accesso alla cultura borghese, nel timore che questa possa stravolgere l’originaria spontaneità degli oppressi, don Milani finisce per costruire i suoi allievi». Non a caso lo studioso pone in evidenza due passi, rivelativi, in base ai quali è possibile affermare che la famosa Lettera, nonostante la dichiarazione che a scriverla siano stati gli stessi allievi di Barbiana, sia in realtà frutto del sacerdote. Il quale, grazie a quell’impostazione intellettuale dalla quale però voleva salvaguardare la propria comunità scolastica, è in grado di formulare il proprio progetto didattico alternativo. Non ci sembrano affatto pretestuose allora alcune argomentazioni di Scotto Di Luzio, che interpretano questi atteggiamenti di don Milani come un conflitto con se stesso e con la cultura nella quale era cresciuto. Volontà di rivalsa in proiettata poi sui suoi inconsapevoli allievi.
Sulla base di tali considerazioni, risulta oltre modo artificioso fare riferimento a quanto don Milani ha scritto e praticato per legittimare l’attuale politica di radicale trasformazione della scuola pubblica. La politica riformatrice si avvale quasi sempre di un lessico fortemente condizionato in senso ideologico, che stravolge concetti di per sé importanti (Scotto di Luzio si sofferma in particolare su quello di merito). La stessa operazione viene praticata con cinismo nei confronti del sacerdote di Barbiana. Scotto di Luzio mostra come la prospettiva axiologica di Milani non lo rende consapevole di quanto alcuni principi cardine della sua didattica sviluppassero una paradossale eterogenesi dei fini; dal momento che impedivano alle classi meno favorite l’accesso a quella competenza linguistica necessaria per poter rivendicare la propria emancipazione. Per i riformatori attuali, allora, diventa facile richiamarsi a don Milani per valorizzare ciò che del suo pensiero si presta a favorire un modo tecnocratico di intendere il processo d’istruzione (la superiorità del sapere utile rispetto alla cultura alta della borghesia); con il vantaggio di procurarsi una giustificazione etica di grande prestigio utile a nascondere un’idea di scuola destinata ad accentuare invece le disuguaglianze tra le diverse classi sociali che vi accedono. Restituire don Milani alla storia del proprio tempo, politica, sociale, familiare, religiosa, come fa Scotto di Luzio, è il modo migliore per evidenziarne la rilevanza storica, la rappresentatività in merito a un certo progetto di società, riferibile a una fase ben determinata della storia italiana; anche, certo, per sottolineare le molte perplessità sul suo modo di intendere la didattica, che concepisce l’emancipazione degli ultimi in modo opposto a come la immaginava, p.es., Antonio Gramsci. Non si tratta di disconoscerne la grandezza, ma di liberarlo dalle tante strumentalizzazioni che lo rendono paladino di un modello di scuola concepita a immagine dell’ideologia economica dominante alla quale egli, ne siamo certi, si sarebbe opposto con vigore.