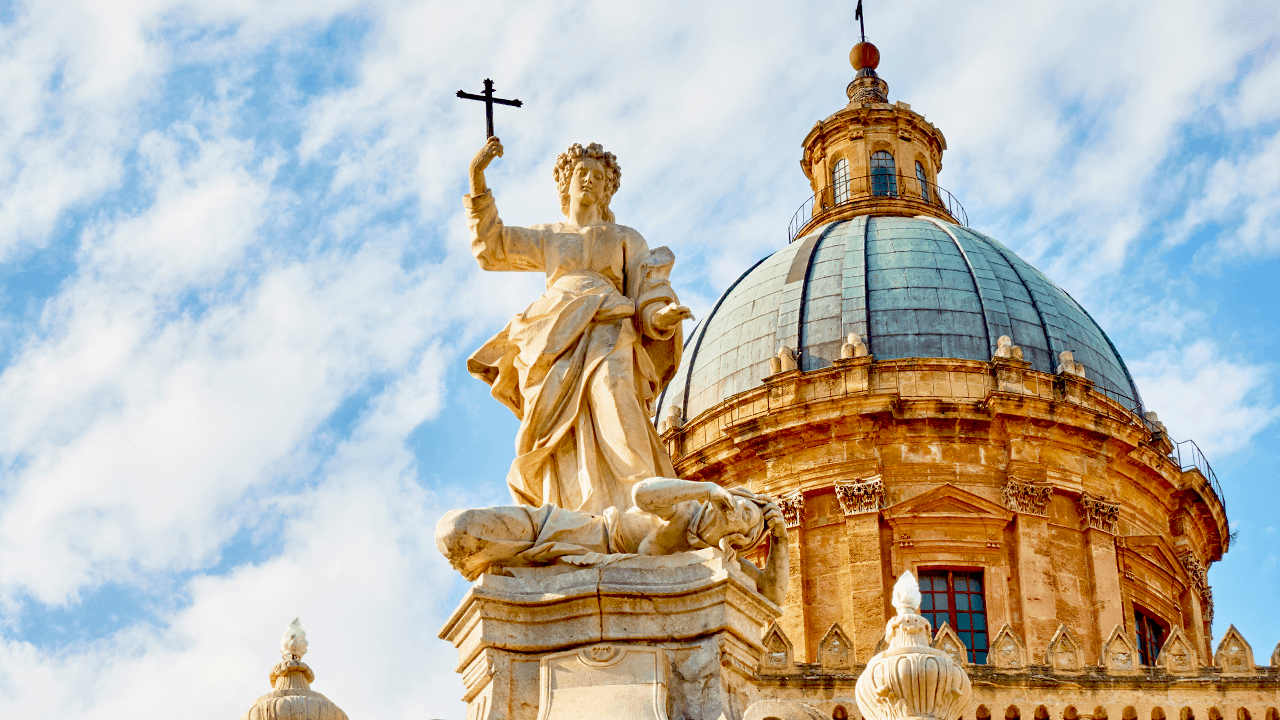Il cibo nella Sicilia medievale
Un’epoca di pestilenze e rassegnazione? Macché. Carni, pasta, pesci, dolci ripieni. Piatti ricchi e mense di strada
Inserita a pieno titolo nel contesto culinario europeo, la cucina meridionale si ispirava ai modelli proposti dal Liber de coquina, ma anche ai manoscritti dell’Anonimo meridionale e del Maestro Martino.
Questi testi, redatti alla corte angioina di Napoli, rappresentano un’importantissima testimonianza delle abitudini alimentari del tardo Medioevo. Attraverso questi ed altri documenti, come Capitoli e Consuetudini, Bresc ci guida in un viaggio molto coinvolgente alla scoperta della cucina meridionale del Medioevo, in particolare quella siciliana.
In primo luogo, il suo libro, Il cibo nella Sicilia Medievale (Palermo University Press, 2019) ha il merito di sfatare il mito, ormai datato e superato: quello di un Medioevo perennemente in crisi e passivamente immerso in carestie e pestilenze. La famosa “epoca buia”, di cui per anni abbiamo sentito parlare, è anche – e forse soprattutto – il momento in cui si cerca di conciliare la difficoltà prodotta dal precario equilibrio tra domanda e offerta con il tentativo di reagire a tale crisi. In tal modo, viene ridimensionata l’idea di un’epoca di stagnazione e di rassegnazione.

L’ultimo lavoro dello storico francese, esperto medievalista, Henri Bresc “Il cibo nella Sicilia medievale” (edito da Palermo University Press e dalla Fondazione Federico II), che è stato presentato in anteprima il 4 luglio 2019 nei Giardini del Palazzo Reale.
La cornice storica è quella, ormai nota, dello spopolamento delle campagne determinato da una serie di guerre civili devastanti e di episodi bellici: le ribellioni contro i musulmani (tra il 1190 e il 1240) e il conflitto del Vespro, per citarne solo alcuni. Questi eventi determinano il sorgere di una nuova realtà che lo storico chiama agrocittà, uno spazio popolato da imprenditori agricoli parzialmente urbanizzati. Allo spopolamento delle campagne contribuisce certamente anche la drastica riduzione della popolazione, che tocca il suo apice intorno al 1340 producendo l’abbandono delle terre e dei pascoli.
All’interno di questo quadro convulso e in divenire si inserisce la Sicilia, allora granaio del Tirreno. La sua economia, basata prevalentemente sulla cerealicoltura, produce all’epoca monocoltura per l’esportazione. Non certo per scelta, ma per ovvie ragioni politiche. Federico II appoggia la politica sui redditi della fiscalità della tratta dei grani e ciò, assieme alla guerra del Vespro, limiterà fortemente la produzione agricola, finendo per imbrigliare le enormi potenzialità dell’isola e costringendola a dedicarsi esclusivamente ai prodotti non lavorati e a importare olio e vino. Nella fattispecie, è incredibile scoprire ad esempio come quest’ultimo, praticamente assente durante i secoli della dominazione araba, venga ancora importato nel Trecento e nel Quattrocento. Anche l’olio risulta essere a lungo assai marginale.
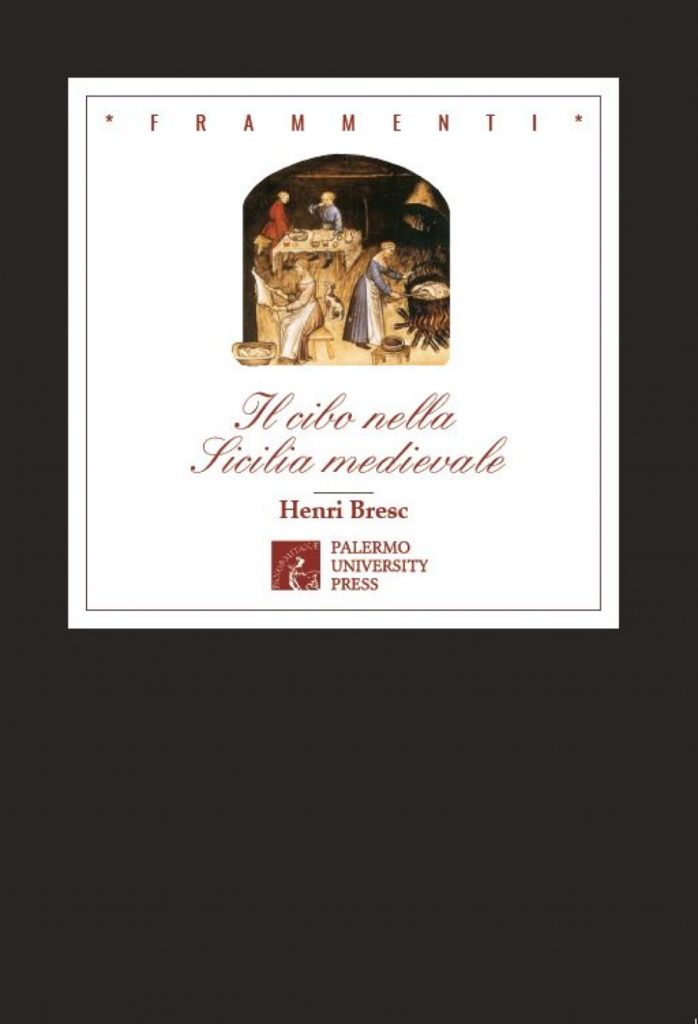 Nelle ricette di quel periodo, infatti, il burro risulta decisamente più usato nella cucina meridionale. A partire dal 1330, inoltre, le vigne vengono sostituite dalla coltivazione della canna da zucchero che inizia a diffondersi già intorno al 945, concentrandosi soprattutto nella Conca d’oro. Si può dunque affermare che il meridione d’Italia abbia anticipato di due secoli l’uso dello zucchero in cucina rispetto al resto d’Europa, sostituendo così il miele, più costoso e raro.
Nelle ricette di quel periodo, infatti, il burro risulta decisamente più usato nella cucina meridionale. A partire dal 1330, inoltre, le vigne vengono sostituite dalla coltivazione della canna da zucchero che inizia a diffondersi già intorno al 945, concentrandosi soprattutto nella Conca d’oro. Si può dunque affermare che il meridione d’Italia abbia anticipato di due secoli l’uso dello zucchero in cucina rispetto al resto d’Europa, sostituendo così il miele, più costoso e raro.
Le importazioni erano molto poche e costose: datteri dal Maghreb, avellane e frutta secca dal principato di Salerno, varie spezie da Alessandria e dalla Siria tramite Genova. Per frenare gli effetti devastanti delle carestie, i municipi vietavano di far confluire il grano nei caricatori per l’esportazione e costringevano i massari a portarlo in città. Inoltre, le città e le terre di Sicilia vengono chiuse all’importazione di prodotti concorrenti, come nel caso di Caltagirone dove, nel 1416, il consiglio municipale vieta l’immissione di vino estero prima che quello locale sia finito.
Dai dati di Bresc emerge, comunque, come la quantità di vino prodotta sia insufficiente al punto che, in un certo momento, fu persino necessario importarne dalla Calabria, da Tropea in particolare, ma anche da Napoli, dalla Corsica e persino dalla Grecia. Questi vini erano naturalmente più cari di quelli siciliani.
Ma cosa e come si mangiava in Sicilia nel Trecento e nel Quattrocento? La cucina siciliana medievale è l’incontro tra la tradizione culinaria araba e quella franco-lombarda aperta alle influenze francesi e catalane. La spiccata originalità dei suoi piatti deriva proprio dall’influenza della cucina araba: la càlia (semi abbrustoliti) la cuccìa (il grano bollito nel latte) non testimoniati però nel Medioevo; la cubaita (torrone di sesamo) il cuscusu di semola, la sfingia (ar. isfânj, frittella ripiena). L’influenza araba si sente soprattutto nell’uso abbondante della cipolla e dei carciofi. La scapece di pesce all’aceto, molto venduta nelle taverne, ricalca la preparazione di un piatto arabo: le melanzane all’aceto. Dagli arabi i siciliani prendono l’abitudine dei ripieni e delle pastelle. La commistione tra i vari elementi produce una cucina fortemente contraddistinta dalla diversità.

Il cibo, inoltre, era prima di tutto un piacere, allora come oggi. Tuttavia, se ne faceva anche un uso medico. Stupisce, infatti, l’attenzione mostrata dai siciliani del Medioevo nei confronti del regime dietetico. La correlazione tra cibi, stagione e umore – certamente influenzata dalla medicina bizantina e araba e dalla scuola di Salerno – è alla base della medicina galenica, secondo la quale alcuni alimenti sono da evitare: è il caso di alcuni pesci, come la lampreda e l’anguilla serpentina, il tonno ma anche alcune verdure e frutta fresca. La pericolosità di questi cibi può però essere corretta da contorni particolari e dall’uso di spezie, presenti per il 77% nelle ricette meridionali. Ognuna di esse aveva infatti anche delle proprietà medicinali: lo zafferano era calmante e digestivo, la cannella riscaldante e digestiva, il pepe nero stimolava l’appetito, il cardamomo e i chiodi di garofano venivano usati come antidolorifici.
L’antica arte della fitoterapia, introdotta proprio dai francescani intorno al 1200, ritorna nelle ricette destinate ai malati per curare costipazione, raffreddori e nausea. Nonostante le prescrizioni e i divieti, però, il consumo dei cibi da evitare era ugualmente assai diffuso. Come dire: anche nel Medioevo si stentava a rinunciare ai piaceri per questioni di salute.
In una società fortemente gerarchizzata, come quella medievale, anche in cucina esistevano dei ruoli ben precisi: nelle corti reali siciliane, come quella di Giacomo I, di Federico IV e di Martino V esisteva, ad esempio, la figura del capocuoco. Di solito, proveniva dalla penisola iberica e ciò spiegherebbe la presenza di influssi valenziani e catalani nella cucina meridionale. Nelle case private, invece, la cucina era praticata dalle donne, mentre nelle taverne e per strada i cuochi erano uomini. Nelle case degli aristocratici, invece, c’erano i cuochi specializzati chiamati maestri. Alcuni di loro erano salariati e potevano spostarsi, ma i documenti attestano anche casi di schiavi neri con mansioni di cuoco, come nel palazzo del maestro secreto Giovanni Abbatellis (1459).
Anche nel Medioevo c’erano i cibi dei ricchi e quelli dei poveri, sebbene nelle taverne esistesse una commistione tra i piatti della tradizione popolare e la gastronomia dell’aristocrazia. La maggior parte delle ricette ricavate dai manoscritti consultati da Bresc erano destinate alle case dei ricchi. La carne dei volatili ad esempio era la più pregiata, anche perché rara, vista la mancanza di fattorie. Veniva cucinata solo in grandi occasioni e in onore di personaggi illustri come ambasciatori e viceré; oppure in occasione dei pranzi funebri offerti ai poveri dalla famiglia del defunto, per manifestarne la generosità e la bontà d’animo.
La carne calda e umida veniva invece usata per curare la peste. Molto diffusa la caccia, specialmente nei feudi di Carini e Terrasini: le prede più ambite erano cinghiali e daini, ma anche conigli e caprioli. La carne ovina o bovina, invece, era sempre presente, assieme al pane e al vino, nei pasti di quei lavoratori che svolgevano mansioni molto faticose come i mietitori, i muratori, gli zappatori e i vignaioli. Mentre per mugnai, vaccari, pecorari o mulattieri erano previsti solo pane e formaggio.

Ed è proprio la carne la vera regina della cucina di strada gestita da coquinarii e pastillarii i cui ingredienti erano, di solito, le sue parti meno nobili: la trippa, le frattaglie e anche il riciclo di pezzi avariati. La frittola, ad esempio, chiamata malcucinato, si serviva esattamente come oggi dentro un grosso pentolone coperto da un velo e si vendeva alla Marina di Palermo, ma anche nelle taverne, accompagnata da vino. Tra i cibi di strada si annoverano pure le fave cotte, la carne bollita e allo spiedo. Tra i piatti tradizionali a base di fave, ricordiamo anche il maccu. Il nome deriva da Mangiamaccu (come testimoniano alcuni documenti del 1300 e del 1400) e fa riferimento alla modalità di preparazione del piatto, il cui ingrediente principale veniva menato in un mortaio.
La richiesta di pesce era elevata, sebbene questo si consumasse meno della carne e non sembra fosse molto apprezzato. Non tutto il pescato restava sul mercato siciliano: alcune specie, sotto sale, venivano esportate ad Amalfi, Pisa e persino Avignone. È il caso del tonno e delle sarde. Cibo del venerdì, il pesce era più caro della carne ed era considerato nocivo e di difficile digestione dalla dieta galenica. Veniva sempre accompagnato da salse o usato come ripieno di pasticci, ma anche arrostito e fatto in brodo. La pesca era concentrata maggiormente tra il golfo di Castellammare, quello di Termini e lo stretto di Messina. Erano molte le tonnare, ma veniva praticata anche la pesca di fiume (anguille e tinche) sul Simeto, sul Tellaro e sul Salso.
La produzione ortofrutticola era prevalentemente destinata al mercato urbano. La mandorla è presente in molti ricettari: una trentina di piatti la contengono, anche sotto forma di latte di mandorla. Sulle bancarelle dei mercati, si trovavano frutta e verdura come cetrioli, melanzane, cocomeri, aglio, fave, mele, pere, sorbe, ciliegie e agrumi. Questi, in particolare le arance, venivano usati per curare lo scorbuto e, infatti, se ne trova traccia nelle scorte delle galee.
Le verdure, tipiche dell’alimentazione dei poveri, venivano utilizzate anche per preparare salse. La frutta, secondo la dottrina galenica, andava consumata cotta per prevenire malattie o per fare composte. La melanzana, presente in poche ricette, veniva fritta o bollita e farcita con aglio, origano, pane e pepe, ma anche con cannella e latte di mandorla.
Il pane, dal forte valore religioso nella società siciliana e collante tra i diversi credo, veniva fatto con farine diverse: quello comune, ad uso dei ricchi, era di farina di frumento tenero; quello nero era destinato prevalentemente ai poveri. Solo le masserie e le case dei ricchi possedevano forni; esistevano, tuttavia, i fornai che permettevano di cuocere il pane precedentemente preparato in casa. Anche la pasta veniva fatta in casa, ma raramente. Nelle ricette ve ne sono di diverso tipo: maccheroni, lasagne e vermichelli. Ma si tratta di cibo per ricchi e veniva venduta in piazza, dopo essere stata fabbricata nella ruga di li maccarunari.
Il vino, molto usato in cucina, era raccomandato per l’inverno. Cefalù, Patti, Catania, Siracusa e Augusta sono note per la produzione di vini pregiati. Si usavano prevalentemente uve come il mantonico, la vernaccia e il moscatello dalle quali si ricavavano vini bianchi molto più diffusi a Palermo rispetto a quelli rossi.