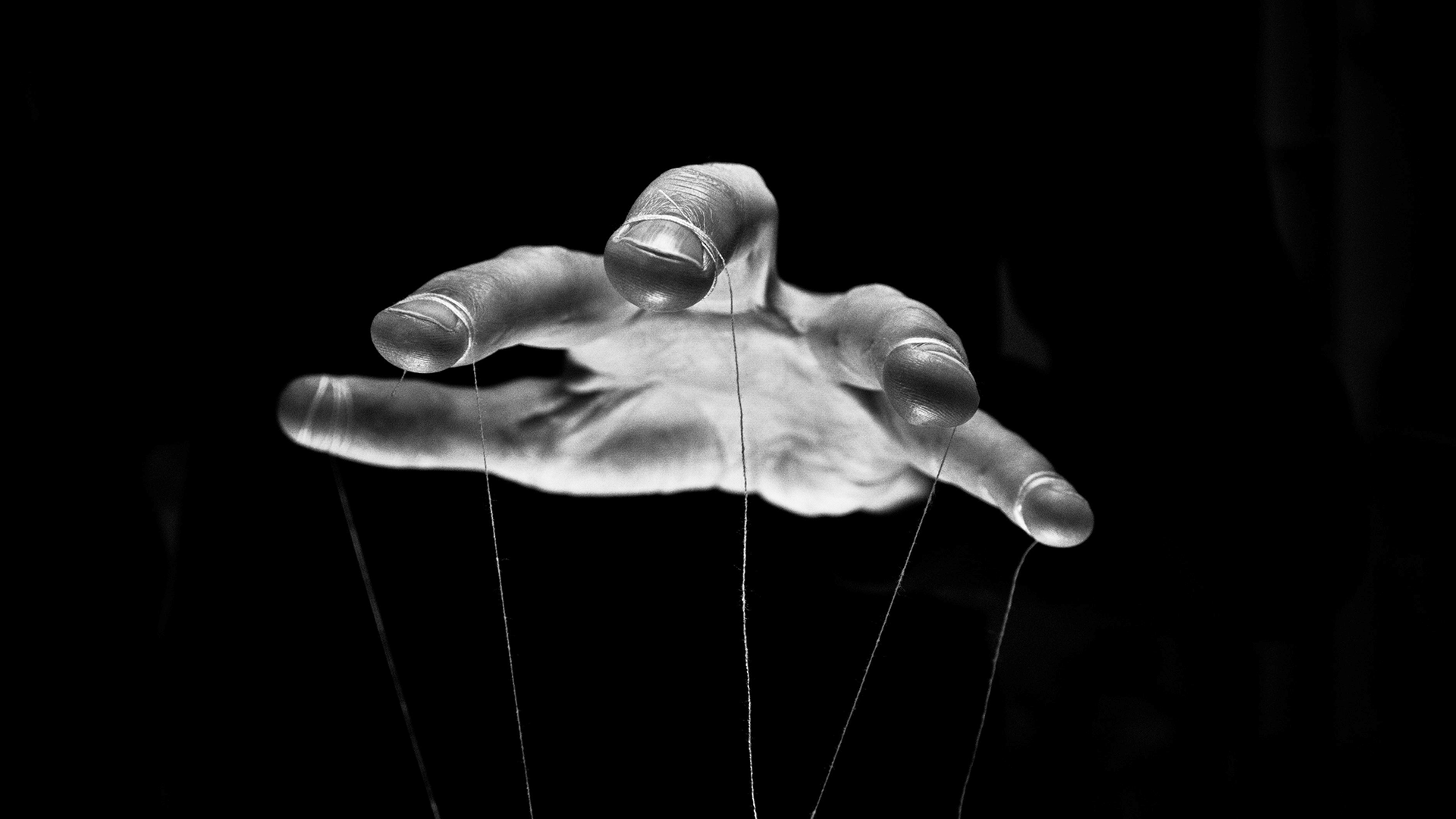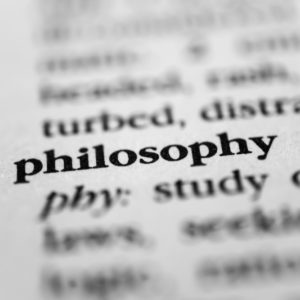Il filosofo e la piazza (mediatica). Tra scienza e divulgazione
I filosofi sono ormai una presenza costante all’interno dei talk show televisivi. Le loro apparizioni sembrano rispettare un copione fisso e consolidato: il filosofo televisivo è quasi sempre in collegamento audio-video e alle sue spalle possiamo scorgere una libreria, con qualche volume fuori posto che dia la sensazione di essere stato consultato recentemente. Il filosofo televisivo aspetta con aria annoiata e a tratti assente che il conduttore lo interpelli, e noi pubblico da casa abbiamo il serio dubbio che egli abbia ascoltato le parole dei suoi interlocutori in studio. Il conduttore gli rivolge una domanda chiedendogli cosa ne pensa su un determinato argomento, che può essere la politica nazionale o internazionale, l’economia, spaziando dall’amore al sesso passando per la morale.
Giunti a questo punto, il copione può avere due proseguimenti alternativi: il filosofo televisivo di turno dice la sua, mantenendo un’aria annoiata e altera, senza nascondere la consapevolezza di stare dicendo cose intelligenti con la certezza che difficilmente verranno comprese dagli interlocutori. Magari nel suo discorso interpola qualche citazione colta, qualche parola in greco, in latino o addirittura in tedesco che nessuno capirà (non sempre, forse queste inserzioni dipendono dal budget, non so se le produzioni in questi casi paghino un supplemento). Se nessuno in studio replica, lo contraddice o lo interrompe, il filosofo ha detto la sua e può tornare ad annoiarsi davanti alla triste scena di persone che parlano di cose loro e addirittura si capiscono.
Se qualcuno però lo interrompe o lo contraddice, ecco l’esito alternativo del copione: il filosofo e il suo interlocutore si agitano, urlano, si parlano addosso, alcune volte si insultano fino a quando uno dei due – quasi sempre il filosofo – si alza e se ne va indignato, lasciando al suo posto una poltrona vuota (niente paura, dopo la pubblicità lo ritroviamo seduto dov’era prima).
Non ho nulla contro i filosofi di professione che vanno in tv e non è intenzione di questo articolo attaccarli. D’altronde, se in questi tempi volessi attaccare qualcuno, potrei (ma non lo faccio) andare sulla sua pagina Facebook a polemizzare col diretto interessato.
La mia intenzione è piuttosto quella di affrontare una questione ben precisa. Perché i filosofi vanno in tv, ma non parlano quasi mai di filosofia?
Sembra quasi che i filosofi abbiano ormai accettato di dispensare soltanto opinioni o – peggio – certezze acritiche su qualsiasi cosa, pur autoprofessandosi per millenni amanti del sapere, della ricerca e della riflessione. È possibile che la disciplina che si è sempre definita come la più difficile da controllare e addomesticare, almeno tra quelle cosiddette umanistiche, sia stata quella che più facilmente si è lasciata imbrigliare dai tempi e dalle esigenze di una certa televisione fatta di opinioni precotte, urla, insulti e soprattutto personaggi macchiettistici e caricaturali?
Perché il fisico Carlo Rovelli può andare in un programma televisivo e parlare di fisica e scienza, o perché Paolo Mieli parla per intere trasmissioni di storia, mentre Massimo Cacciari ospite di un programma televisivo non parla della Politica come professione di Max Weber? Perché i filosofi vengono interrogati su tutto, dai sentimenti al sesso fino all’economia, alla politica internazionale e alla società, meno che sulla filosofia?
Abbiamo chiesto su questo un’opinione ad Andrea Le Moli, docente di Filosofie dell’età contemporanea presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e Storiche (di cui è Coordinatore) e Direttore Scientifico del Festival delle Filosofie di Palermo e del Festival Internazionale di Filosofia di Ischia-Napoli (con Raffaele Mirelli).
Le Moli
Indubbiamente la presenza del filosofo in TV pone qualche questione a chi di professione si occupa di filosofia. Da un lato c’è un sentimento di invidia mista a riprovazione (cioè a un sentimento di difesa dalla stessa invidia) per l’accesso che alcuni di noi hanno a platee che altri semplicemente si sognano. È la ragione per cui, al di là della componente esibizionistica, che necessariamente interviene quando ti metti in gioco davanti a un pubblico, spesso chi si occupa di filosofia a livello non mediatico si immagina di provarsi in un contesto così particolare, anche solo per vedere se il proprio stile comunicativo funziona oltre lo spazio-classe, lo spazio-seminario o convegno/conferenza. Non c’è niente di male in questo, secondo me.
Quello che però noto è che, rispetto alla divulgazione scientifica in senso stretto, la filosofia opera all’interno di un piano comunicativo un po’ diverso. Mi spiego: per la scienza cosiddetta “dura” è inevitabile, direi costitutivo, accompagnare alla formulazione tecnica delle teorie, fatta sostanzialmente di calcoli e numeri, una versione “metaforizzata”, che la renda rappresentabile al pubblico non scientifico e ne illustri le conseguenze al livello di descrizione macroscopica del reale. È un po’ il presupposto da cui parte Fritjof Capra (uno dei grandi teorici-divulgatori di questi anni) ne Il Tao della fisica. In questo senso la necessità della divulgazione, della mediazione rappresentativa, è qualcosa di strutturale alla costruzione di una teoria scientifica, e la comunicazione metaforizzata un registro che quasi sempre si accompagna a una teoria e spesso ne decreta anche il successo, oltre che facilitarne la comprensione. Con la filosofia ho il dubbio che le cose stiano così. Voglio dire: come si può non dico spiegare ma “usare” una qualunque tesi di Hegel nello spazio di un dibattito con non-filosofi nei tempi contingentati della televisione senza ricadere nello slogan o nella frase a effetto, peraltro vuoto? Prendo Hegel ad esempio perché, oltre ad essere l’autore sul quale tu hai scritto ben due tesi di Laurea, era anche uno degli esempi preferiti di Neopositivisti come Hans Reichenbach o Rudolf Carnap, i quali lo prendevano a caso esemplare di autori di proposizioni che, prese di per sé (vale a dire scisse da qualunque cornice ermeneutica) risultavano solo apparentemente composte da termini dotati di un significato e spesso mancanti addirittura di sintassi logica elementare. Questa, che spesso è stata fatta passare come la critica più radicale alle pretese epistemiche della filosofia, a me non sembra invalidi la proposizione filosofica; al contrario mi pare la esibisca come qualcosa che non vive tanto nella sua possibile condensazione, quanto nella ricostruzione delle cornici alla base delle produzioni linguistico-teoriche, nell’approfondimento delle aperture di pensiero che all’interno di queste cornici si creano e nell’espansione delle potenzialità di senso del pensiero e del linguaggio. Mi sembra cioè che dimostri, proprio nella critica alla pretesa di far valere le proposizioni filosofiche in quanto semplici “frasi”, come la tesi filosofica sia qualcosa che serve ad aprire universi di senso più che rinchiudere in poche, sintetizzabili battute, una visione del mondo o la proposizione/soluzione di un problema specifico.
Se però a questo punto mi chiedi se l’unico spazio preposto alla vera discussione filosofica sia quello che dispone a) di un interesse comune e genuino dei partecipanti al problema nella sua formulazione filosofica; b) della disponibilità a ricostruire ogni volta il contesto storico-ermeneutico che inquadra le proposizioni e c) di tempi liberi e larghi come quelli della lezione scolastico-universitaria o del seminario-laboratorio, ti dico che non penso sia così. Né che possa e debba essere così. Altrimenti non avrebbe senso non solo la presenza del filosofo nel dibattito pubblico, ma neppure l’idea di contesti divulgativi come i Festival di Filosofia o il nostro ciclo di incontri “Conversatorio al Conservatorio”, in cui il filosofo di professione si mette in gioco di fronte a un pubblico agguerrito di non addetti ai lavori. Sta lì per due ore solo su un palco, che a differenza di cattedre e pulpiti non offre più alcuna protezione, a presentare una tesi in modo per quanto possibile chiaro e ad aspettarsi domande il cui grado di chiarezza (e dunque di possibilità di risposta sensata) inevitabilmente dipenderà da quello dell’esposizione.
Fazzese
La buona divulgazione infatti esiste e agli italiani piace, basti pensare agli ascolti record dei programmi di Piero e Alberto Angela, ma anche alla presenza di programmi dedicati alla divulgazione storica e scientifica su un po’ tutte le reti più o meno generaliste. Possiamo inoltre sottolineare come esista anche una divulgazione televisiva filosofica: dal 2012 è andato in onda sui canali Rai Zettel, ed è andato avanti per ben quattro stagioni, condotto da Maurizio Ferraris e altri esperti scelti a seconda del tema della puntata. Nel 2016 è ricomparso con un nuovo titolo, Zettel-Fare filosofia, e in una nuova veste; il programma ha infatti assunto la forma di un vero e proprio laboratorio, condotto da Felice Cimatti che discuteva per mezz’ora con studenti e professori universitari su un tema filosofico, per un totale di 25 incontri. Le puntate sono tutte disponibili sul sito della Rai e lo consiglio a chiunque voglia anche solo provare l’esperienza di guardare un programma televisivo senza sentire la necessità di abbassare velocemente il volume perché qualcuno ha iniziato a urlare. Zettel va ancora in onda nella nuova edizione Debate, ogni domenica alle 18.30 sempre su Rai Scuola, stavolta sotto forma di dibattito tra Ferraris e Cimatti che discutono su un tema specifico (democrazia, sfruttamento animale, i social network, ecc.). Al termine della puntata, il programma coinvolge nel dibattito anche due classi di scuola.
È vero, si tratta di esperimenti e non di una pratica consolidata. Il primo Zettel andava in onda a tarda notte, mentre le altre due edizioni vanno in onda a orari più accessibili ma su Rai Scuola, che naturalmente non vanta la platea di una delle prime tre reti generaliste Rai. Credo però che questi esempi possano farci ben sperare sull’esistenza delle basi per una divulgazione filosofica seria e allo stesso tempo fresca, chiara e accessibile a tutti; una felice via di mezzo tra i polverosi classici studiati ancora nelle aule e nelle biblioteche universitarie e il macchiettismo di certi filosofi da salotto televisivo.
Le Moli
Certo, esempi come quelli di Zettel sono positivi ma non risolvono la questione dei margini di intervento del filosofo in contesti non suoi, come appunto i talk-show o le canee mediatiche di vario genere. O persino nelle pubbliche adunanze, nelle assemblee più furibonde, nelle manifestazioni di protesta o financo nelle risse (mi è capitato). Ci può essere ancora un modo filosofico di intervenire, per così dire, “per strada” in questo senso? O in dibattiti di questo tipo restiamo di fronte alla disarmante alternativa di a) smettere i panni del filosofo e picchiare duro come gli altri o b) arroccarci in un muto, sardonico e alla fin fine controproducente disprezzo?
Fazzese
Il problema di scegliere un’alternativa tra quelle che lei pone ci permette di chiamare in causa l’articolo di Polito sul Corriere della sera del 13/01/19. Il giornalista reagisce alla scelta dei filosofi Masullo, Tessitore e De Giovanni come testimonial per una campagna di educazione civica rivolta alle scuole con lo scopo di promuovere l’Unione Europea e le sue finalità. Polito sostiene provocatoriamente (o forse no) che la visione secondo cui l’Europa abbia a che fare solo con le idee sia la causa della sua crisi (e pensare che da quello che dichiarano trasversalmente i fronti politici sembrava che il problema fossero i “numerini”, i vincoli economici, la moneta unica…). Polito continua affermando come in realtà chiunque meglio di un filosofo potrebbe spiegare meglio ciò che l’Europa ha fatto di buono per noi cittadini, e in particolare per quelli di Napoli e del sud.
Il punto di vista di Polito è tutto sommato comprensibile: diciamo che non è il primo a sottolineare come l’eccessivo ossequio privo di qualsiasi riserva alla cultura umanistica in generale, e in particolare a quella filosofica, possa essere anche una delle cause della scarsa cultura scientifica e del lento progresso tecnologico che caratterizzano in parte l’Italia.
Possiamo però partire dal suo discorso, dichiarandoci anche parzialmente d’accordo, per arrivare tuttavia a conclusioni differenti, se non proprio opposte. È vero, la comunità non ha bisogno di rivolgersi ai filosofi per sapere, nel caso specifico, cosa l’Unione Europea ha fatto di buono e non è tenuta a farlo; può benissimo rivolgersi a tutte le altre figure nominate da Polito, cioè botanici, ingegneri, economisti, medici e così via. Sono i filosofi che hanno però il dovere, forse anche perché devono ricordarsi di essere gli unici in grado di farlo, di far capire alle persone e in particolare ai giovani studenti perché è importante lottare a fianco dei botanici contro la xylella e ascoltare gli scienziati che ne parlavano da anni; o perché bisogna ascoltare il medico che ci spiega l’importanza dell’igiene alimentare o – per fare un altro esempio – delle vaccinazioni per vivere di più e meglio, ignorando la politicante di turno che sui social racconta di quando ai suoi tempi ci si passava il morbillo tra cugini per immunizzarsi.
Mi chiedo, per usare gli stessi termini di Polito: chi può formare la classe dirigente capace di proporre opzioni etiche e politiche in grado di produrre benessere e crescita economica e civile, e allo stesso tempo impedire alle persone di incattivirsi al punto di consegnarsi per l’appunto ai demagoghi? È possibile formare questa classe dirigente senza una cultura, un orizzonte di pensiero che potremmo definire anche – non per forza esclusivamente – filosofico? Come possiamo insegnare alle persone a riflettere su ciò che è bene per loro e per la loro terra, distinguendo ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, ciò che è utile da ciò che è nocivo, ciò che è razionale da ciò che è irrazionale?
Questo mi riporta alle due alternative che lei ha posto: forse i filosofi non hanno bisogno né di scendere in piazza e picchiare come gli altri né di arroccarsi in un muto disprezzo. Non so se si tratta di una via di mezzo, ma sicuramente di un atteggiamento umile e ambizioso allo stesso tempo, con cui i filosofi tornano a dialogare con scienziati, economisti, medici, all’interno di un tessuto sociale sempre più complesso e in perenne trasformazione. Una comunità che forse non ha il bisogno urgente di un ciclo di lezioni sulla Critica della ragion pura o sui dialoghi platonici, ma sicuramente della stessa rigorosa razionalità che li ha ispirati.
Le Moli
Anch’io arrivo alla stessa conclusione. E secondo me in questo senso una Nuova Allenza tra filosofia e altri saperi è non solo possibile ma doverosa, nel quadro di una cultura filosofica globale in cui le branche della conoscenza sono sempre più interconnesse. E non dimentichiamoci che, al di là dei dati sperimentali, molto spesso scienziati di ogni orientamento ricorrono ai framework filosofici quando devono rendere rappresentabili le loro teorie o cercano spunti per elaborarne di nuove. Per far questo tutti dobbiamo essere proiettati oltre i confini tecnico-specialistici delle nostre discipline e disposti all’ascolto. Quello che facciamo noi nei Festival è proprio trasformare i più diversi spazi urbani – suggestivi o degradati non importa – nei luoghi di un simile ascolto. Aprirle letteralmente, le piazze.
Riguardo all’articolo di Polito non mi pronuncerei sul giudizio dato sui filosofi napoletani, di cui conosco le opere, ma non abbastanza la forza storica di incidenza sul tessuto culturale locale. Anche se dubito sia stata così effimera come lui afferma. Porrei l’attenzione invece sulla tesi generale, che è un perfetto esempio di quanto abbiamo detto finora. Nel ridurre 2500 anni di filosofia globale – certamente non solo occidentale o europea – alle idee platoniche, alla metafisica o alla separazione tra sensibile e intelligibile, Polito dimostra di stare parlando di qualcosa che non conosce bene e di avanzare una tesi radicale senza essersi documentato abbastanza. Il che per un giornalista non è che sia il massimo della vita. Sulla questione poi del lasciare i temi dell’Europa agli economisti ci andrei davvero piano. Non dimentichiamo che l’Europa nasce sulla base di un mito fondazionale profondissimo (quello di Europa, appunto) e che, soprattutto, emerge come costrutto teorico dalle conseguenze della II Guerra Mondiale e dalla volontà di ricostruire una comunità lacerata ripensando il senso stesso del confine, della frontiera e del territorio. In questo senso l’idea di lasciare valutazioni e decisioni ad esempio sui flussi migratori intra- ed extraeuropei, o sui rischi del riproporsi di spinte nazionalistiche violente, esclusivamente agli economisti (il che in buona parte vuol dire: ai teorici del capitalismo liberale, statalista o semplicemente selvaggio) mi sembra più pericoloso. Molto più pericoloso del pensare di ascoltare, ogni tanto, un filosofo che prova a dire qualcosa sull’argomento-Europa, ossia che cerca di ragionare criticamente, per esempio, sulle contraddizioni storiche alla base della sua costituzione, sul suo ruolo problematico nella formazione del mondo post-coloniale, nel conflitto mediorientale, ecc. Il vero pericolo, in realtà, mi sembra il fatto che una tesi come quella di Polito possa avere accesso ad una platea mediatica così vasta e condizionare i tanti meno attrezzati che cercano faticosamente di formarsi un’opinione. In questo senso non mi sembra così diversa dalle frasi urlate di un talk show, che però copriranno sempre qualunque autentica parola ci si sforzi di inserire. Questo è triste. Perché a chi viene educato e mantenuto nel rumore risulterà sempre più difficile imparare a riconoscere musica e parole. E questo sì avrebbe potuto dirlo Platone.
Link all’articolo: https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/19_gennaio_13/adottate-chiunque-ma-non-filosofo-0fda2982-1709-11e9-b1b4-4e95b2102835.shtml