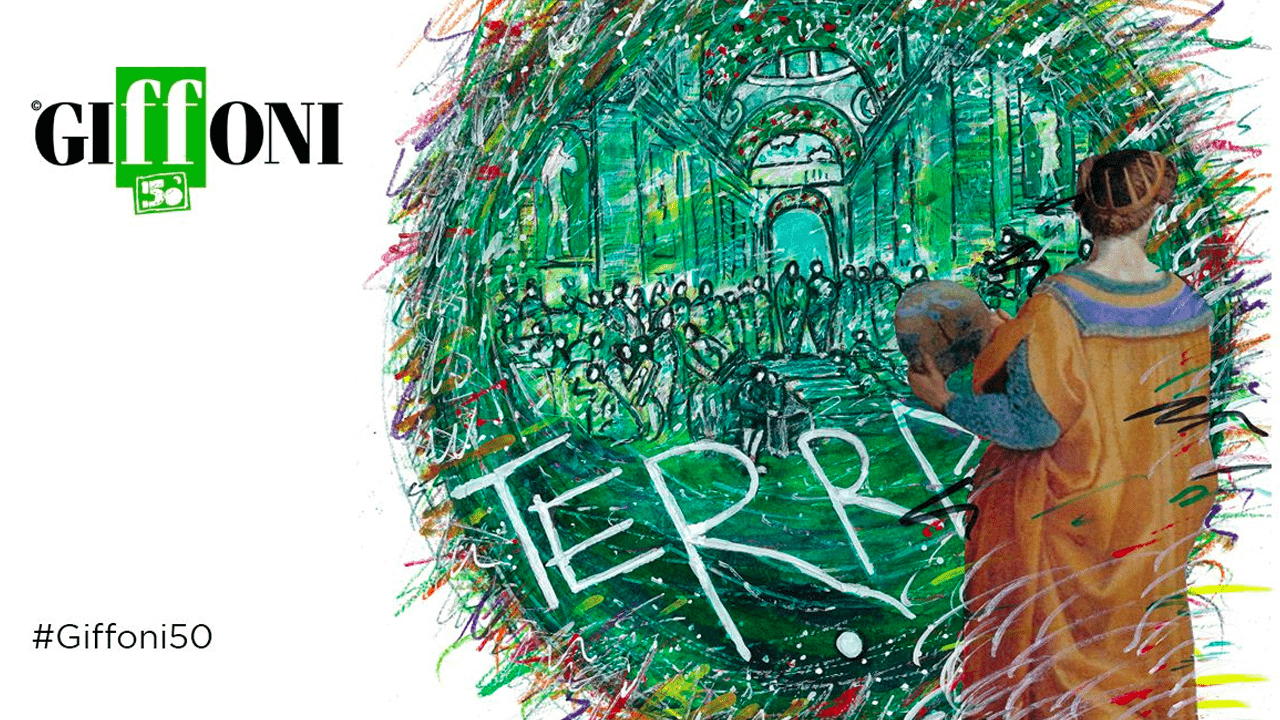Kim Ki-duk, il serial painter del nuovo millennio
L’11 dicembre 2020 muore a 59 anni Kim Ki-duk, in seguito a complicanze da Covid-19. Nel cinema del grande regista sudcoreano, autore di film pluripremiati nei grandi festival internazionali, si ritrovano tutti i tratti distintivi del nuovo cinema orientale. Costruito su un intenso lirismo delle crudeltà umane del nostro tempo.
Kim Ki-duk, i “Wild animals” del fiume Han
Nella città di Seul, tra i tanti ponti che attraversano il fiume Han, il principale corso fluviale della capitale coreana, ve ne è uno dove la gente decide di recarsi quando ha raggiunto la tormentata decisione di porre fine alla propria vita. Sotto l’arcata di quel ponte vive “Coccodrillo” (il suo vero nome è Yong-pae, ma è con quel curioso soprannome che tutti lo conoscono) che, per racimolare un po’ di grana, aspetta d’impossessarsi dei cadaveri dei malcapitati oramai annegati per spogliarli dei loro averi e ricattare i parenti alla ricerca di un corpo sul quale poter piangere.
L’inizio della storia di Crocodile (1996), il film d’esordio di Kim Ki-duk, potrebbe essere preso a manifesto del mondo che il New Korean Cinema ha voluto tratteggiare in quest’ultimo ventennio. È la realtà dei Wild animals (non a caso il titolo della seconda opera di Kim), gli “animali selvaggi” che per sopravvivere devono cacciare altri animali, immersi in quella “giungla metropolitana” in cui si cerca perennemente di non trasformarsi da cacciatori a prede. Sopravvivere diventa insomma vivere per se stessi, cercando dentro di sé l’energia vitale, lo spunto che consenta di andare avanti in qualsiasi situazione. Il nuovo cinema coreano è anche questo, una straordinaria galleria di personaggi “vitali”.
Ma la vitalità spesso si mescola con la violenza. Quello di Kim è un cinema crudo e crudele in cui la violenza è parte integrante del motore che muove i personaggi, in particolar modo quando si parla del rapporto con l’altro sesso. L’insistenza su certi temi, la rappresentazione di una donna spesso umiliata nel corpo e nello spirito hanno attirato non poche ire da parte della critica femminista. Non a caso Kim Ki-duk è stato costantemente bersagliato da pesanti accuse di palese misoginia.
Yong-pae/Coccodrillo salva Hyun-jung che si è gettata nelle acque del fiume Han ma, una volta trascinata sulla riva tenta di violentarla, vantandone il diritto di proprietà per averla condotta in salvo. Con un altro tentato stupro si conclude il primo timido contatto tra Hyun-shik e Hee-jin protagonisti del film L’isola (2000). Non meno significativo è l’inizio di Bad Guy in cui Han-ki, silenzioso animale selvaggio in giro tra la folla, vede Sun-hwa, una ragazzina seduta su una panchina in attesa di incontrare il suo fidanzato e decide di baciarla con tanta violenza che lo stesso fidanzato della ragazza non riesce a farlo staccare da lei neppure dopo averlo colpito più volte alla schiena con un pesante contenitore metallico per la raccolta della spazzatura.
La realtà tratteggiata è quella di Seul, del fiume Han e dei suoi ponti, di una società che crea anonimi, che manda alla deriva l’uomo coreano piuttosto che farlo sentire parte di qualcosa. I wild animals sono anche questo e, in tale contesto, l’amore appare sotto forma di atto animalesco, una presa di possesso: si tratta ancora una volta di cacciare, questa volta sentimenti. Parlare di sentimenti significa parlare di amore, e l’amore qui, in quanto atto primordiale e animalesco, si mostra inevitabilmente come desiderio, impulso al piacere personale ed egoistico. In molto del cinema coreano moderno l’amore può mostrarsi solo sotto forma di sesso, per di più la forma più istintiva e violenta del sesso, lo stupro.
Kim Ki-duk, il linguaggio della ferita
Ma la “vitalità” dei wild animals è soprattutto quella dei loro corpi. Nel cinema di Kim Ki-duk il corpo diventa linguaggio attraverso la sua alterazione (l’ossessione per la ferita presente in molti suoi film). Mentre in ambito sessuale, il rapporto fisico viene costruito attraverso una visione prettamente masochistica.
L’isola (The isle, 2000) racconta la storia di una relazione sadomaso tra una donna che affitta ai pescatori delle case galleggianti sul lago (vendendosi inoltre a loro) e un fuggitivo braccato dalla polizia. Il film rappresenta il momento più assoluto nella cinematografia di Kim Ki-duk nella rappresentazione del corpo (e nella sua lacerazione) come forma di espressione pura per ogni individuo. Il sadomasochismo trova la propria dimensione visiva nel metafora della pesca in cui i due amanti useranno i loro corpi come pesci da prendere all’amo, ma anche da ridurre a sushi e da ributtare in acqua.
L’implosione a livello visivo è scioccante come solo il cinema di Kim Ki-duk sa fare: i due amanti-pesci legati l’uno all’altro dalla stessa lenza, finiranno per lacerare il loro corpo proprio con questa (ingoiando un mazzetto d’ami lui e inserendoli nella vagina lei) quando uno dei due cercherà di spezzare il filo che li lega.
Una messa in scena attraverso il corpo e che mette il corpo in primo piano, che gli fa saturare lo spazio della inquadratura rendendolo ossessivamente presente, configurandolo di fatto come l’unica modalità linguistica possibile. La carne e la sessualità come i soli elementi comuni tra tanti mutismi che sono tracce di altrettante incomunicabilità. L’isola non è un film sul sadomasochismo come malattia o sofferenza ma come pratica per comunicare. Una volta che i codici linguistici sociali sono perduti, al linguaggio si sostituisce il corpo.
Kim Ki-duk, essere nessuno
Se la parola perde il suo valore comunicativo e il corpo esiste attraverso la sua lacerazione, la deriva finale per gli animali selvaggi di una Seul che rende anonime le persone, che diventa inevitabilmente il “non essere nessuno”. È il caso di Tae-suk, protagonista di Ferro 3 – La casa vuota (2004) che vive la sua vita abitando le case lasciate vuote degli altri, cercando di appropriarsi per quel breve tempo di permanenza di una sorta di esistenza concreta.
Non stupisce che paradossalmente, in una di queste abitazioni, Tae-suk diventato letteralmente un fantasma, riesca a trovare un legame profondo con un Sun-hwa, altra creatura “non vista”, anch’essa fantasma in casa propria, invisibile ed impotente di fronte al marito violento. Insieme occupano gli spazi lasciati dall’indifferenza altrui. Scrive il critico cinematografico Andrea Bellavita:
“In questo senso Ferro 3 è insieme un film sulla solitudine e sulla alienazione di una società che non vede, non si accorge, nemmeno quando l’intruso, l’altro è così vicino, nella propria casa […]. L’ultima immagine del film è un’inquadratura dei loro piedi sulla bilancia e il peso è zero: è il peso della morte o quello della libertà?”
Kim Ki-duk come “pittore seriale”
È paradossale che sia stato proprio Kim Ki-duk oggi a rappresentare il New Korean Cinema e molto del cinema orientale nel mondo. Personaggio sempre molto controverso in patria, si è sempre attirato l’odio da parte di molti per il suo cinema senza compromessi. Inoltre, tra tutti i registi della nuova ondata è quello che occupa una posizione più isolata, non intrattiene nessun tipo di rapporto con altri registi coreani se non, come lui stesso afferma, “qualche saluto quando ci si incontra ai festival”. Lui stesso rifiuta qualsiasi tipo di paragone con altri suoi colleghi, se non quel Im Kwon Taek che tra tutti è, guarda caso, l’autore che gli somiglia di meno. E per rendere ancora più difficoltoso accostarsi al suo cinema rifiuta persino qualsiasi tipo di paragone tra i suoi stessi film definendosi “come l’acqua… semplicemente fluisco. Non ci sono sistemi o ideologie”.
Non esiste quindi un progetto autoriale nel cinema di Kim, tuttavia è rintracciabile un tessuto di ricorrenze e ritorni, tanto che il critico Adrien Gombeaud parla di un cinema “spiraliforme”:
“Queste ripetizioni non sono solo un ritorno perpetuo, un cerchio, ma uno slancio: un elemento richiama l’altro, lo aspira nella spirale. Si capisce perché Kim Ki-duk non può che inanellare i film senza interruzione, per non spezzare il ciclo dinamico che fonda la natura stessa del suo cinema”.
La pittura è stata la sua attività ancor prima di iniziare a far cinema: un pittore che dipinge innumerevoli quadri, e che non riesce mai a fermarsi, preso appunto dalla sua ossessione della costruzione dell’inquadratura nel senso più pittorico del termine.
“Serial painter” come sottolinea la scrittrice Anaid Demir: “seriale” perché costretto a continuare all’infinito ma anche “serial” nella accezione disturbante che il suo cinema riesce a provocare negli spettatori. Un cinema dipinto con gli affreschi Zen sporcati di lacerante umanità di Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera (2003), film che lo ha fatto conoscere all’Occidente. Oppure con le pennellate di sangue fisico che diventa ferita interiore da cauterizzare a tutti i costi come Yeo-jin, protagonista de La Samaritana (2004), che rintraccia tutti gli uomini con cui la sua amica prostituta nonché socia in affari, aveva fatto sesso a pagamento, per unirsi carnalmente a loro e restituire loro anche i soldi macchiati del sangue dell’amica che si è gettata dalla finestra.
Quadri che alcuni considerano addirittura ripugnanti (pensiamo ad esempio ai cani bastonati a morte in Address unknown) costruiti su una violenza mostrata così com’è, senza una bel confezionamento a nostro uso e consumo, senza preoccuparsi di farcela accettare ma neppure senza preoccuparsi di farcela in qualche modo capire. A proposito della violenza nell’opera di Kim Ki-duk, il giornalista Vittorio Renzi sottolinea come: “Il cinema di Kim Ki-duk appare in prima istanza brutale, gridato, in cui lo sguardo dello spettatore viene schiaffeggiato e violentato dalla realtà e diventa perciò uno sguardo riluttante, sulla difensiva”.
Eppure capace di mostrare come sprofondando nelle acque inquinate del fiume Han, i corpi alla deriva di Yong-pae/Coccodrillo e la sua vittima/amante Hyun-jung possano trovare quell’equilibrio esistenziale che diventa anche mirabile equilibrio stilistico-espressivo.
Testi citati e opere di riferimento
Anaid Demir, Kim Ki-duk serial painter, in AA.VV., Kim Ki-duk, Dis Voir, Parigi, 2006
V.Renzi, Kim Ki-duk, Dino Audino Editore, Roma, 2005
A.Bellavita, Kim Ki-duk, Il Castoro, Milano, 2006
A.Morsiani, L’isola, in Cineforum, n.399, ottobre 2001
Adrien Gombeaud, Dand les spirales de Kim Ki-duk, in Positif, n.530, aprile 2005
J.Bowyer (a cura di), The cinema of Japan & Korea, London Wallflower Press, London, 2004
A.Gombeaud, Séoul cinéma : les origines du nouveau cinéma coréen, L’Harmattan, Paris, 2006
Kim Ki-hyun, Yau Escher (a cura di), Asia/pacific cinemas: a spectral surface, Duke University Press, Durham, 2001
Hyangjin Lee, Il cinema coreano contemporaneo: identità, cultura e politica, O barra O Edizioni, Milano, 2006