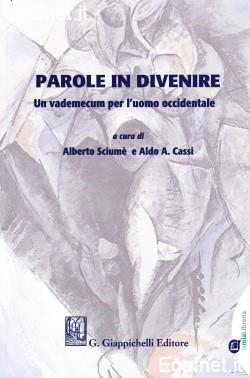La storia smarrita. Su The History Manifesto
Review of: David Armitage-Jo Guldi, Manifesto per la storia. Il ruolo del passato nel mondo d’oggi, Trad.it. di D. Scaffei, Donzelli ed., Roma 2016, pagg.262.
Era da un po’ di tempo che un libro sulla conoscenza storica, per meglio dire sull’uso pubblico del passato, sull’utilità della storia e, in definitiva, sul suo ruolo nella società, non sollevava tante discussioni, tante prese di posizione, attacchi e posizionamenti. Il libro in questione è un pamphlet e già dal titolo – The History Manifesto – evidenzia il suo intento politico di rilancio della storia. Un intento che alla fine della lettura si comprende riguardare soprattutto la funzione della storia nella società odierna. Gli autori, David Armitage e Jo Guldi, sono due storici: il primo è Lloyd Blankfein Professor alla Harvard University di Cambridge (Massachussets), la seconda è Hans Rothfels Professor di Storia alla Brown University di Providence (Rhode Island). Due addetti ai lavori, dunque, che si interrogano sullo stato e sullo statuto dell’ordine discorsivo che praticano professionalmente. Ciò, considerata la non eccessiva presenza di contributi metodologici in giro e, comunque, la ritrosia degli storici ad interrogare e a problematizzare le condizioni d’esercizio della propria disciplina, fa del volume un’occasione comunque riuscita che ha il merito di affrontare quella crisi che, secondo gli autori, rende da anni la storiografia socialmente irrilevante1 (p.12)2. Una crisi su cui convergono i pareri di molti storici e che fa dire a Lynn Hunt, ex presidente della American Historical Association, con molta franchezza, «che il campo della storiografia è in crisi, e non si tratta semplicemente di una crisi dovuta ai bilanci universitari» (p. 12). E, per spostarci in Italia, a Fulvio Cammarano, che «oggi quasi nessuno considera più lo studio della storia un elemento chiave per analizzare e comprendere il presente. Lo storico è visto come un cantastorie […] quando si affrontano questioni attuali ci si rivolge altrove: allo scienziato sociale […] che usa un linguaggio formalizzato e pretende di enunciare leggi di portata generale su come funziona il mondo»3.
Il pamphlet di Armitage e Guldi ha insomma avuto il coraggio di prendere di petto «una crisi di cui la comunità degli storici sembra a fatica voler prendere atto» (p. VII)4. Se sull’oggetto della denuncia – la crisi della storia all’interno della società- ci possiamo ritrovare, ben diverso è la questione sul piano della diagnostica delle cause e su quello delle soluzioni proposte per superare lo stato di smarrimento. La stessa comunità degli storici, dopo la pubblicazione avvenuta a Ottobre del 2014, ha mostrato grande interesse per il pamphlet5, pur evidenziando una serie di critiche che non hanno risparmiato né la lettura della crisi offerta dagli autori, né la via d’uscita proposta per superare l’impasse. Ed è proprio nella presenza di una serie di proposte, attraverso cui oltrepassare la crisi, che si palesa il carattere evidentemente politico e militante del testo di Armitage e Guldi, che è nato a seguito di una serie di incontri svoltisi tra «Departmnent of History di Harvard University, la Yale Law School, l’History Department di Brown University e la Reid Hall della Columbia University a Parigi» (p. VII). La natura dialogica del testi che stanno sullo sfondo de Il Manifesto è evidente nell’andamento narrativo e in una certa schematicità che pesa, in diversi passaggi, sull’esposizione analitica di alcune categorie – come quella di microstoria – che sembrano essere trattate con eccessiva disinvoltura, proprio come può accadere in una conversazione tra colleghi che condividono un comune orizzonte di riferimento.
Proprio l’uso disinvolto della categoria di microstoria ci permette di affrontare l’obiettivo polemico principale del pamphlet: lo short-termism, «il dominio della prospettiva a breve termine» (p. 5). Secondo i due autori, all’incirca dalla metà degli anni Settanta, l’attenzione degli storici per l’orizzonte breve ha letteralmente contaminato la prassi storiografica, tanto che «questa malattia […] oggi è penetrata così a fondo nelle nostre istituzioni che è diventata un’abitudine – assai seguita ma raramente giustificata -, della quale ci si lamenta molto ma che spesso non viene diagnosticata» (p.5). L’attenzione sempre più marcata per gli orizzonti limitati ha generato, secondo i due autori, «un nuovo tipo di storia, che concentrava la propria attenzione sulla “microstoria” di individui eccezionali, di eventi apparentemente inspiegabili o di significative congiunture» (p.21). Questa definizione non può non apparire quantomeno generica al lettore italiano che ha conosciuto e letto gli studi di Carlo Ginzburg e Giovanni Levi6 e, infatti, Armitage e Guldi non hanno come obiettivo principale del loro attacco la microstoria italiana – a cui viene riconosciuto il merito di avere ben presente «la fiducia nelle potenzialità trasformatrici dell’azione individuale» (p. 88) – ma la sua declinazione in ambito anglosassone, in cui «il Passato breve generò una storiografia condizionata da scale temporali sempre più ridotte e da un uso sempre più intensivo degli archivi» (p. 89). E proprio l’identificazione dello storico con il frequentatore e il decifratore degli archivi7 è uno degli elementi che secondo gli autori evidenzia la svolta a favore «di un’ottica concentrata su un singolo evento» (p.88). Da allora «più un particolare complesso di documenti si presentava oscuro e difficile da comprendere, meglio era […]» poiché «la sua utilizzazione dimostrava la perizia del ricercatore nel trattare le fonti e il suo impegno nell’immergersi nella ricerca sul campo» (p.89). La professionalizzazione, l’attenzione, le competenze necessarie per maneggiare il materiale d’archivio, resero la figura dello storico sempre più legata alle periodizzazioni limitate, alle tematiche specifiche, agli ambiti ristretti, tanto che «le generazioni successive [a partire dagli anni Settanta] avrebbero adottato gli orizzonti temporali del Passato breve, considerandoli ormai qualcosa di scontato» (p. 89). Da qui un processo sempre più marcato di identificazione dello storico con quella figura specialista dello short-termism che opera negli archivi e si interessa soprattutto di ambiti e tematiche ristrette. Tutto ciò, secondo gli autori, ha generato un profondo discredito verso tutte quelle narrazioni di ampio respiro che si prefiggono di interpretare la realtà e quindi di contribuire «al modo con cui il presente intende il proprio potenziale. Ed è quindi un intervento sul futuro del mondo» (p.18). Come si evince da quanto appena detto, secondo Armitage e Guldi, lo short-termism «non costituisce mai di per sé un problema, fino a quando […] non diventa dominante in un periodo di crisi» (p. 25). Infatti, perdendo la sua capacità di fornire «ai cittadini le coordinate per poter comprendere il presente e indirizzare le loro azioni verso il futuro» (p. 19) in un certo senso la storia avrebbe smarrito la sua funzione sociale. Tutto ciò ha senso postulando che compito della storia sia quello di informare per formare la comunità, cosa che secondo gli autori de Il Manifesto avveniva prima del 1968 (p.76), quando l’attenzione era rivolta alla lunga durata. Quest’ultima, nella lettura di Armitage e Guldi, rappresenta l’incarnazione di una possibilità, quella di «sintetizzare la conoscenza storica ad autori non accreditati» (p. 16), garantendo così «l’antico scopo della storia di ergersi a guida della vita pubblica» (p.16). In altre parole l’arretramento della longue durée, e la sua sostituzione con lo short termism, comportò per gli storici la perdita di tutta l’influenza pubblica esercitata tradizionalmente sulla politica, a vantaggio degli scienziati sociali «e in modo particolarmente evidente degli economisti» (p.16). In questo discorso la crisi della lunga durata è la crisi della storia nella dimensione pubblica, la sua riduzione ad ambito professionale autoreferenziale privo di riconoscimento sociale.
La stessa sufficienza adottata in relazione all’uso della microstoria può essere riscontrata nell’uso della braudeliana categoria di longue durée – che gli autori precisano essere una categoria non del tutto inedita «già nell’Ottocento, in Francia» (p.33) –. Infatti, questa categoria, solo al prezzo di una indebita generalizzazione può essere estesa alla prassi storiografica vigente perlopiù prima del 1968, quando la presunta rilevanza politica degli storici era maggiore. E se ciò non può essere dimostrato l’intero discorso de Il Manifesto si depotenzia. Bisogna inoltre precisare che la longue durée concettualizzata da Braudel presenta una specificità epistemologica, attinente alla pluralità dei tempi storici, che ne rappresenta la ragion d’essere e che non può essere sottostimata ai fini di un discorso che tende a sovrapporre lunga durata e funzione pubblica. Non riconoscere le ragioni di emergenza della nozione braudeliana impedisce di mettere a fuoco quello che secondo noi è uno dei problemi della crisi della storia e che riguarda non tanto la svolta dal lungo al breve periodo, ma una più generale difficoltà di pensare le condizioni di possibilità della scrittura storiografica. Il problema della perdita di rilevanza pubblica della storia non va ricercata tanto nella riduzione degli orizzonti temporali, sempre legati al tipo di domande che lo storico si pone, ma alle difficoltà di fronteggiare adeguatamente fenomeni come il negazionismo, l’abuso pubblico e politico della storia, l’ascesa della memoria nella definizione del rapporto tra le comunità e il passato. A questi temi – a cui se ne possono aggiungere altri – la comunità degli storici sembra non essere stata in grado di offrire risposte convincenti, in grado di persuadere la comunità, con il risultato di una progressiva marginalizzazione a vantaggio delle scienze sociali – come riconosciuto da Armitage e Guldi –, ma soprattutto di certo giornalismo in grado di sollecitare l’attenzione dei lettori con narrazioni ad effetto tanto potenti quanto spesso poco fondate. Il problema è che accanto a giornalisti che guadagnano visibilità pubblica e politica improvvisandosi storici, ci sono i professionisti dell’accademia che producono narrazioni autoreferenziali che, raramente, raggiungono il grande pubblico. In ballo c’è sicuramente il problema della difficoltà degli storici ad adattarsi alle diverse condizioni che attualmente danno visibilità sociale al discorso storico, ma ciò rientra in una più generale e problematica crisi della nozione di verità, quindi anche di quella storica. Infatti, la storia non può più far valere la pretesa ingenua di rintracciare la verità del passato disponendola nella forma di una «narrazione di un tempo lineare, “omogeneo e vuoto”»8, ma a ciò non è seguita un’adeguata ridefinizione di cosa significhi scrivere la storia e offrirla alla comunità. Alla luce di tutto questo, la lunga durata sostenuta da Armitage e Guldi, lungi dall’essere una soluzione per il rilancio della storia, sembra essere soltanto un simulacro che evita di fare fino in fondo i conti con le ragioni più profonde di questa crisi. Una crisi epocale che è parte di un più generale sommovimento epistemologico che ha nella critica alla verità come adeguazione un punto di svolta. Se dunque la storia è finita ai margini del discorso pubblico è anche perché, a differenze di discipline come l’economia, che hanno nella verità basata su dati quantitativi il loro riconoscimento sociale, non è stata ancora in grado di ripensare le proprie condizioni d’esercizio e di elaborare un’adeguata nozione di verità che sappia tenere insieme dimensione evenemenziale, molteplicità temporale e retorica, in nome di quella prassi che non può essere ridotta alla semplice dislocazione dei fatti in un arco di tempo più o meno ampio.
Insomma, se è indubbia la marginalizzazione della storia nel dibattito pubblico, come affermato ne Il Manifesto, meno certa è la soluzione proposta nel pamphlet che punta ad una riaffermazione delle grandi narrazioni in vista di un ritorno ad una presunta funzione civilizzatrice che, proprio la problematicità epistemologica di una lettura essenzialista e magari decontestualizzata delle fonti, rende improponibile. Questo non significa negare valore alla longue durée di cui, anzi, si auspica un ritorno, magari secondo quella prospettiva e secondo quelle ragion d’essere che la resero attuale nel discorso braudeliano. Operare cercando di rappresentare e problematizzare i molteplici e possibili vettori temporali è un intento auspicabile di cui si sente bisogno, in particolare laddove si vogliono mostrare le condizioni di emergenza di un fenomeno, la genealogia di un’idea o le condizioni di possibilità di un problema sociale, tutti ambiti che possono essere indagati al meglio attraverso le lenti di lunga durata. In tal senso – come riferito anche da Armitage e Guldi – le possibilità offerte dai big data o da software topic-modelling che consentono di padroneggiare e stare dietro ad un gran numero di dati possono offrire strumenti per molti versi inediti agli storici che, però, non si traducono automaticamente in vie d’uscita dalla crisi proprio perché la questione non è innanzitutto una faccenda di orizzonti temporali. Il problema non si risolve infatti, come vuole Il Manifesto, piegando la storia sulla morale, dettando ricette volte a indicare ai governanti come esercitare il potere o influenzando i loro consiglieri (p. 19). Una storia magistra vitae è per molti, troppi, versi, un paradosso e un anacronismo, poiché muove dall’implicita posizione secondo cui c’è un passato oggettivo da ricostruire e su cui fare leva per «impartire la lezione al presente»9. Compito degli storici, invece, dovrebbe essere quello di elaborare narrazioni critiche sul passato in grado di portare alla luce la singolarità irripetibile degli avvenimenti, la contingenza radicale degli intrecci che determinano i fenomeni che si sono succeduti. E nel fare ciò cercare di mostrare alla comunità quanto il passato sia un ambito da costruire e ricostruire e mai un dato acquisito una volta per tutte, neanche sotto la spinta urgente dei testimoni e dei loro ricordi. Scrivere cioè una storia critica, vale a dire una retorica argomentativa che punta alla costruzione del passato e alla produzione del senso attraverso il quale viene compreso. Un lavoro questo che deve essere messo a disposizione della collettività, ma non per dettare una ennesima ricetta per futuro, quanto per mostrare la natura problematica e mai risolta di un passato che, con i termini di Reinhart Koselleck, possiamo intendere come uno spazio d’ibridazione tra un “campo d’esperienza” (Erfahrungsfeld) e un “orizzonte d’attesa” (Erwartungshorizont).