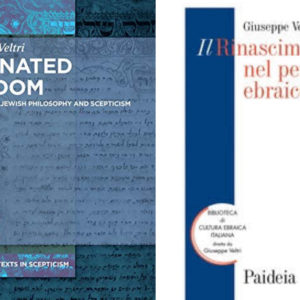L’ebreo scettico, il Rinascimento europeo, la saggezza alienata: la via del dubbio passa per Amburgo, di Bernardini Paolo Luca
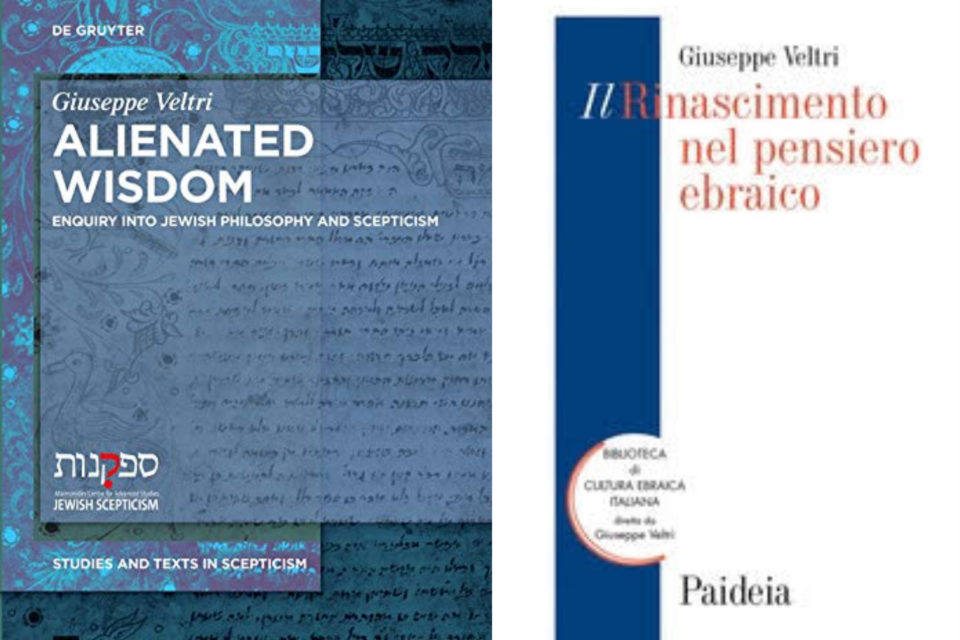
Premessa
Giuseppe Veltri (1958-) da decenni porta avanti un’originale ricerca sul dubbio e lo scetticismo nell’ambito dell’ebraismo (oltre a numerose altre, sempre feconde di risultati). In questo mio scritto, che racchiude e amplia due articoli-recensioni di recente pubblicati, prendo in esame altrettanti tra i principali lavori recenti di Veltri, ordinario di Ebraistica presso l’Università di Amburgo e direttore nonché fondatore, dal 2015, del Maimonides Center for Advanced Study; lavori che riguardano tematiche ampliamente affini, ma che presentano un discorso prospettico molto diverso, come del resto mondo differente è l’ambito cronologico toccato rispettivamente nell’uno, e nell’altro lavoro. Ma mentre l’uno – tenendo ben presente il discorso sullo scetticismo, ovviamente – non pone il discorso scettico al centro della narrazione, concentrandosi piuttosto sull’ebraismo nel Rinascimento italiano europeo (“rinascimento” esteso fino al tardo Seicento), il secondo invece tocca la storia delle origini dello scetticismo ebraico a partire dal mondo classico fino al tardo Ottocento, in un affascinante percorso millenario, ove però il momento rinascimentale, come cercherò di mostrare qui, giuoca un ruolo di primo piano, fulcro, o quasi, dell’intera costruzione storico-filosofica, e teologica[1]. Si tratta dunque – anche se indagare sulle reali intenzioni del loro autore – di due testi profondamente, e necessariamente complementari, come in fondo cerco di dimostrare, ancorché indirettamente, in questo mio contributo.
Il Rinascimento, gli ebrei, lo scetticismo
Il primo volume che prendo in esame sembra essere quello il cui ambito cronologico è maggiormente circoscritto, mentre di molto maggior ampiezza è quello tematico, almeno in apparenza[2]. Prima tuttavia di affrontarne nello specifico i contenuti, una breve discussione teorico-metodologica mi sembra opportuna.
Nella prospettiva infatti di storia globale che in qualche modo, nel bene e nel male, domina il paradigma storiografico internazionale, occorre chiedersi se non sappia di “provinciale” perfino il porsi in una dimensione esclusivamente “europea”, nel momento in cui si affronti qualsiasi “tradizionale” tema storiografico, che è europeo per consenso comune (se non per oggettività storica). E questo anche quando si parla di un fenomeno, il Rinascimento, che in qualche modo, fin da Jules Michelet (1855), ovvero fin dal momento in cui il concetto venne coniato (a metà Ottocento, ma i precedenti non mancano), ha condotto gli storici – forse perché il conio a ben vedere non fu così felice, né peraltro scientificamente disinteressato – in labirinti e “sforzi di superamento” (di “inquadramento”) per certi aspetti non necessari. Non necessari, per l’appunto, se di “Rinascimento”, con buona pace di Michelet, Burckhardt ed infiniti seguaci loro, mai si fosse parlato, in omaggio ad una prudenza da sempre violata dai creatori di “categorie” storiografiche che pretendono di riguardare intieri periodi storici, costringendo poi tutti gli storici che con tali periodi si cimentano ad inquadrare nella categoria l’oggetto di cui trattano, proprio perché la categoria esiste e sembra non poter essere ignorata. Con paradossi evidenti: il premiato libro di Edward Muir, ad esempio, Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli During the Renaissance, del 1998, parla evidentemente di episodi di storia criminale che nulla avevano a che fare con quel fenomeno rappresentato da pochissime élite intellettuali che è, se qualcosa è, il Rinascimento, per l’appunto; ma lo stesso si potrebbe applicare ad un volume – qui non citato da Veltri, che cita altro del medesimo autore, Moses A. Shulvass (1909-1988) – che ebbe una grande risonanza al tempo che uscì, in ebraico prima e in inglese poi: Jews in the World of the Renaissance (ed. inglese, Brill, 1973, originale in ebraico 1955), ove il discorso si applica proprio agli ebrei, la cui vita solita, le cui istituzioni, le cui intelligenze, erano più spesso all’interno di una tradizione medievale e biblica, piuttosto che partecipare, se non per identità cronologica, a quel movimento elitario e differenziato, anche cronologicamente, da nazione a nazione, che fu il Rinascimento (se qualcosa esso fu, come si è detto, ed assumendo che almeno in parte, euristicamente, la categoria abbia un significato).
In quali direzioni si sono mossi gli storici, per uscire in qualche modo dal labirinto terminologico-concettuale, ovvero dalla “categoria”, appunto, stessa, dai loro illustri predecessori forse incautamente creata? In una, innanzi tutto, geografica: più che da Michelet (che in fondo scriveva nel contesto di una “Storia di Francia”, nel 1855, rifacendosi per l’Italia al Quinet uscito nel 1849), da Burckhardt, a partire dal fondamentale lavoro del 1860 e da quello del 1867, il Rinascimento venne identificato come fenomeno “italiano”: per quanto alla fine il suo simbolo, Leonardo – che appare anche in ritratto nell’edizione inglese del Burckhardt, edizione epocale, del 1878 – ebbe fondamentali legami con la Francia, ove morì in odore di santità (laica). Ci volle un lungo cammino per identificare il Rinascimento, in alcuni suoi tratti peculiari, come fenomeno europeo, e questo avvenne oltre un secolo dopo Michelet e Burckhardt. Tale “svolta”, peraltro lungamente preparata da diversi storici, fu celebrata con John Hale – di cui nel 2022 ricorre il centenario della nascita. Il quale pubblicò nel 1995, già malato – si sarebbe spento quattro anni dopo – il suo capolavoro, The Civilization of Europe in the Renaissance. Dall’Italia – anzi da alcune corti italiane – ecco che la dimensione si fa europea (paneuropea: Hale tratta ampiamente anche di Europa orientale, e non poteva essere altrimenti, si pensi, per portare un solo esempio, all’Ungheria di Mattia Corvino). E con argomenti convincenti. Naturale che poi questo non bastasse, e sempre più insistenti sono le pubblicazioni che si riferiscono alla categoria di “Global Renaissance”, a partire da un articolo seminale di storici del calibro di Peter Burke, Luke Clossey, e Felipe Fernández-Armesto, “The Global Renaissance”, che hanno riproposto la categoria sul Journal of World History nel 2017 (tutto da leggere il fascicolo).
Alla questione dell’ampliamento geografico si è aggiunta – da molto tempo – quella dell’ampliamento cronologico. Quando inizia e quando finisce il Rinascimento? E naturalmente anche in questo caso ci si è mossi verso una progressiva estensione dei confini, tanto che alla fine non si sa bene quando il Rinascimento inizi (da tempo in America almeno negli insegnamenti universitari vi si comprende Dante e Petrarca), forse addirittura dopo l’anno 1000 (!) e certamente con la “rinascita” del XII-XIII secolo (con il diritto canonico, con le università, con lo sviluppo dei mercati, come ci ha insegnato da un secolo Roberto S. Lopez), e neanche quando finisca. Alla fine, le periodizzazioni sono solo funzionali alla divisione del lavoro a livello accademico. O per suscitare infinite discussioni sulla loro validità e soprattutto, come ho detto, la loro estensione.
Sapendo di essere alquanto provocatorio, mi domando (di nuovo) se la categoria stessa abbia davvero giovato – come del resto ogni categorizzazione troppo pregnante, ivi compresa quella di “Illuminismo”, ancor più soffocante – alla ricerca storiografica, ovvero alla comprensione del passato.
La mia risposta è negativa.
Forse l’unica “rottura” che giustificherebbe l’individuazione di un’epoca nuova nella storia non tanto dell’umanità, ma del sapere, è la rottura tra sapere secolare e sapere religioso, la fine dell’unità del sapere medievale: ma l’immensa ricerca medievistica pone sempre più in dubbio tale (“scolastico” e “Scolastico”, da manuale e aristotelico) paradigma. Peraltro, in pieno illuminismo, e illuminismo ebraico, un Moses Mendelssohn manteneva sapere sacro e sapere profano separati, perfino linguisticamente, sdoppiandosi letteralmente, in una sorta di schizofrenica duplicità di orizzonti e dimensioni, di pubblico e intenzioni, di metodo oltre che ovviamente di lingua. E ove non sapremmo dire davvero se la dimensione esoterica sia quella ebraica, o viceversa, sia quella tedesca, nel filosofo berlinese. Ma forse varrebbe la pena di chiedersi se l’elemento estremamente offensivo presente nelle categorie (ideologicamente condizionate da un laicismo alla fine grossolano) di Rinascimento e Illuminismo (rinasce quel che è morto? E quel che è morto è davvero tale? – e rispettivamente – viene illuminato chi è nelle tenebre, e ma costui, o costei, è nelle tenebre davvero?) forse potrebbe scomparire quando alle ipotesi di rotture radicali nel corso del sapere (nel suo complesso) venissero contrapposte ipotesi di continuità, euristicamente, credo, molto più fertili.
Dobbiamo ora ad uno dei maggiori ebraisti viventi, Giuseppe Veltri, fondatore e direttore a Amburgo di uno dei principali centri internazionali di ricerca sull’ebraismo e il pensiero filosofico al mondo, il Maimonides Centre for Advanced Studies, attivo dal 2015, un libro davvero illuminante su Rinascimento ed Ebraismo, ove alla fine – anche se indirettamente – chi lo legga con attenzione è spinto a porsi le domande, radicali, che ho posto io all’inizio di questo saggio. Il Rinascimento nel pensiero ebraico (Paideia, 2020, pp. 226), sintetizza decenni di ricerche di ebraistica e storia delle idee, si avvale del largo novero di studi che sia in Italia sia nel resto del mondo sono stati condotti sui pensatori e scrittori ebrei in Europa in età rinascimentale (quando la si possa circoscrivere, ed ognuno lo fa in maniera diversa, quando si prenda la briga di farlo), e ci conduce in territori aspri e non sempre noti, soprattutto ovviamente per ragioni linguistiche, giungendo a darci una vasta rassegna su pensatori, poeti, cabalisti e altri protagonisti, a volte ignoti nello stesso mondo ebraico, del Rinascimento, o quantomeno della cultura e civiltà ebraica tra Cinque e Seicento (utilizzando tutta l’immensa letteratura prodotta ad oltre mezzo secolo da uno Shulvass, ad esempio, degli ebrei italiani peraltro grandissimo conoscitore, per certi aspetti ancora, come ben si sa, utilissimo). Se si pensa che in Burckhardt non vi sono che un paio di cenni agli studi “orientali” di Giannozzo Manetti e Pico della Mirandola, e di ebraismo non si parla proprio, possiamo pensare che nel corso di oltre centocinquant’anni molto sia fatto per inserire nel contesto del pensiero e della letterature europee del tempo un numero altissimo di scrittori ebrei, sia che scrivessero in ebraico (e quindi per un pubblico ben definito, e per scopi ben definiti) sia che scrivessero in altre lingue, talvolta perfino la lingua per eccellenza del Rinascimento, il latino (anche se per odio nei confronti di ciò che rappresentava un grande scrittore ebraico dei tempi, Mosè Zacuto, pare si sia recato in luoghi desolati al solo scopo di…dimenticarla). Veltri ci conduce in un mirabile percorso in cui scrittori ebrei si misurano, in varie lingue, con le conoscenze e le scienze del tempo, entrando sia pure discretamente, quanto la loro condizione sociale consentiva (e quanto lo consentiva anche la loro innata e doverosa prudenza), nei vivissimi dibattiti che caratterizzano la modernità. Come Leonardo, Veltri utilizza sia il cannocchiale, sia il microscopio, per andare ad esplorare oltre gli italici confini gli esperimenti con gli automi di rabbino Löw di Praga, col suo Golem erede di automi bizantini e anticipatore di automi settecenteschi (Vaucanson) per continuare in un Seicento forse non troppo “rinascimentale” ma ancor più denso di novità (filosofiche, speculative) rispetto al Quattro e Cinquecento, incontrando i complessi orditi di pensiero e verso di una poetessa del ghetto di Venezia, Sara Copio Sullam. Ma illuminanti anche le pagine sul Dante letto, sempre nel ghetto di Venezia, da Simone Luzzatto (e siamo sempre nel Seicento – secolo che non tutti gli storici sono inclini a vedere come “rinascimentale”, a testimonianza dunque della fallacia della categoria), sullo scetticismo, metodologico piuttosto che radicale, che fa il suo ingresso nel pensiero ebraico, e in tutto il pensiero europeo, con la traduzione e riscoperta di Sesto Empirico (tra l’altro), su Leone Modena e le sue teorie linguistiche; sul platonismo di Leone Ebreo (e straordinari sono i suoi versi sul “tempo”, un vero e proprio “trionfo” nel solco già petrarchesco, del trionfo di tempo, morte, caducità…) e Veltri ci regala una splendida traduzione di parte della Telunah ‘al ha-zman (Lamento sul tempo) del 1503, opera solo parzialmente neo-platonica, al contrario dei Dialoghi d’amore, e scritta non in italiano, ma (come si vede dal titolo, ovviamente) in ebraico.
Questa ricchezza tematica, l’apertura verso fonti coeve e classiche, l’infinita erudizione degli autori (e autrici) che vivevano nei ghetti italiani, o nei quartieri ebraici prima che il primo ghetto (quello di Venezia) venisse eretto nel 1516, mostra come le mura del ghetto non fossero così impermeabili, o in generale, la “separazione” tra ebrei e cristiani, almeno a livello di élite intellettuali, non fosse così netta, ai tempi. Le nuove idee circolavano, insieme ai denari, dentro e fuori le mura del ghetto, ma spesso lo facevano anche gli esseri umani. Esistono autori appartenenti al mondo ebraico qui considerato che sulla base della loro “sapienza” dogmaticamente depositata nel Libro sia davvero speculativamente innovatori? La domanda ovviamente è retorica, ma si comprende bene qual rottura nei confronti del dogma e della tradizione avvenga con un ebreo, Spinoza: che, aldilà di ogni retaggio della tradizione, su cui si è infinitamente discusso, abbraccia il razionalismo cartesiano, e dunque la vera, unica rottura nella storia della filosofia, che avviene non in età rinascimentale: ove piuttosto la continuità vede un suo trionfo, nell’esaltazione di Dio e insieme dell’individuo in quanto sua creatura che proprio l’umanesimo sollecita, implica e afferma, magari proprio quel Manetti prima ricordato, peraltro esaltatore (ma con un bersaglio preciso, Innocenzo III) dell’individuo anche nella sua corporeità, nella sua sensibilità, in tutto il suo essere. Ma se una delle cifre della nuova cultura rinascimentale è il “carpe diem”, il “chi vuol essere lieto sia” (in scandalosa assenza di certezza del “diman”), si vede bene l’immane campo di tensioni che vengono suscitate con la teologia morale ebraico-cristiana. E dunque forse nel segno di queste – laceranti – tensioni, va inteso anche il Rinascimento ebraico, come era chiaro a Cecil Roth, un maestro e pioniere in questi studi, quando, un secolo dopo Burckhardt, nel 1959, dava alle stampa The Jews in the Renaissance, alla base di tutte queste ricerche. Su questo libro tornerò in chiusura di questa prima sezione.
Percorrendo le affascinanti pagine di Veltri, forse il solo momento in cui si affronta una “rottura” speculativa (alla fine non radicale), è quando si incontra Azaria de’ Rossi (1512ca-1578). Questo ebreo mantovano, vissuto nel Cinquecento, dunque in una fase forse “calante”, per alcuni storici, del fermento culturale rinascimentale, si pone questioni fondamentali proprio di “metodo” – nel senso radicale e fondamentale in cui, dando però ben altre risposte, se le porranno Bacon e Cartesio più tardi, dando vita ad empirismo e razionalismo rispettivamente, e costituendo la prima vera rottura nel percorso filosofico occidentale – non nega la tradizione dogmatica dell’ebraismo (e come avrebbe potuto davvero farlo?), ma di tale tradizione sposa la parte “narrativa”, haggadica, e contrappone spesso l’evidenza sensibile, più episodicamente che sistematicamente, per esempio, alla narrazione rabbinica. Questo nell’opera sua maggiore, Me’or Enayim, “La luce degli occhi”, anche se però il rispetto della tradizione prevale. Come scrive Veltri (p. 99): “La novità di Azaria consisteva nel proporre al ‘lettore illuminato’ le fonti e il materiale documentario per la formazione di un proprio giudizio critico, che riguarda però solo gli aspetti marginali, non il nucleo della tradizione, che è costituito – secondo Azaria – dalla Halakhah.” Ovvero dalla “legge ebraica” nelle sue fonti e interpretazioni. Anche se solo su “aspetti secondari”, il peso che Azaria dà al “giudizio autonomo dell’individuo” è di estrema importanza (anche perché poi questi “aspetti secondari”, a ben guardarli, così “secondari” proprio non sono). Così, Azaria si colloca pienamente nel nucleo tematico, ma soprattutto “problematico” del Rinascimento, nei suoi momenti speculativamente più fertili: ovvero la contesta tra antichità e presenti, la famosa “querelle” che prima che si incisti e sviluppi su motivi estetici (depotenziandosi enormemente) includeva motivi etici, teologici, speculativi, di importanza estrema. Così il libro di Veltri ci dona una sintesi mirabile di decenni di riscoperta e rilettura degli autori ebrei del Rinascimento, che vede protagoniste ormai diverse generazioni, fino a Roberto Bonfil e David Rudermann, Giulio Busi, Joanna Weinberg, Bernard Cooperman, e più di recente Guido Bartolucci, Fabrizio Lelli, Asher Salah, per citarne solo alcuni tra un novero fortunatamente in continua crescita (e che conta anche giovanissimi quali Martina Mampieri).
Se si accusassero gli autori ebrei di cui tratta Veltri di essere ancora troppo legati ad una tradizione di sapere sacro che assai spesso, inevitabilmente, contrasta con quello secolare, ebbene forse tale accusa sarebbe da rivolgere anche a molti altri protagonisti del Rinascimento, di religione cristiana. Forse, tali dinamiche sono presenti anche in un altro momento di “Rinascimento” anteriore a quello di cui parliamo, il mirabile periodo di convivenza e scambio intellettuale tra ebrei, musulmani e cattolici nella Spagna pre-espulsione, ovvero prima del 31 marzo 1492. Un tema storiograficamente non meno controverso rispetto a quello affrontato da Veltri; ma si pensi alla tesi della straordinaria fioritura culturale nell’Al-Andalus, e altrove, nei secoli di convivenza (più o meno) pacifica tra tre fedi. Oggetto del libro molto acclamato e discusso, A Jewish Renaissance in Fifteenth-Century Spain di Mark D. Meyerson (2004), che ha come oggetto la città di Morvedre nel regno di Valencia tra 1391 e 1492, e la sua fiorente comunità ebraica (anche dal punto di vista culturale e intellettuale) prima dell’espulsione (i riferimenti naturalmente alla coeva situazione italiana sono numerosi). In un certo senso, il concetto di “Renaissance” si precisa, nel libro di Meyerson, per una ragione ben definita: nel 1391 vi era stato un terribile, violento attacco agli ebrei a Morvedre, che aveva messo in pericolo l’esistenza della comunità stessa. Che, per l’appunto, nel secolo successivo “rinasce”. Un uso legittimo, mi pare, del conio “rinascimento”.
In conclusione, uscito nel cinquantesimo dalla morte di Cecil Roth (1970), il libro di Veltri ci invita a rileggere il classico di Roth, The Jews in the Renaissance (ove peraltro si va molto poco fuori dai confini italiani, come del resto nel libro di Veltri) (mentre altri classici, come lo Shulvass della monografia…) Quando Gerald Strauss lo recensì su Commentary (Settembre 1960), ne evidenziò il carattere innovativo, ma ne pose anche bene in luce gli indubbi limiti. Parlò anche di una possibile periodizzazione, legata all’apertura o meno dei papi verso gli ebrei, ovviamente. Se Alessandro VI, Leone X, e certamente Paolo III, ebbero alla fine sentimenti e posizioni giudeofile, cosa che agevolò anche quel che Roth nel libro chiama “reciprocal process” ovvero l’interazione tra ebrei e gentili nel (pieno) Rinascimento, con Giulio III e Paolo IV, a partire da metà Cinquecento, tale processo si interruppe. Definitivamente? Il modo con cui Veltri si avventura nel Seicento pieno mostra come almeno parte della tesi/ipotesi “continuista” sia ora accettato. Anche se non è tanto la frattura del rogo del Talmud o della Cum nimis absurdum a squilibrare e interrompere il “reciprocal process”, quanto forse la necessità, speculativa, che si avvertiva sempre di più, di una vera “filosofia nuova”, libera da ogni legame dogmatico, ovvero teologica, che si affermerà solo, drammaticamente, nel secolo successivo nell’Europa continentale, e alla fine del Cinquecento in quella insulare (con Bacon). Strauss tuttavia vide bene i limiti del libro di Roth. Se è vero che intellettuali ebrei, allegramente vasi dalla nuova euforia per il sapere, addirittura crearono paraetimologie per termini in voga nel Rinascimento, “accademia” venne fatto singolarmente, brillantemente derivate dall’ebraico eked e adam (“assemblea” e “uomo”), e vi furono addirittura donne, come la marrana Gracia Mendes, che si fecero “mecenati” gestendo allo stesso tempo società di affari (proprio come i Medici!), è anche vero che gli ebrei si fecero forse troppo “assimilare” dalla nuova filosofia gentile, almeno fino ad un certo punto, alla fine molto esteriore. Quando venne bruciato il Talmud, ironizzando sulla cosa, alcuni ebrei dissero che ora, bruciate le loro leggi, avrebbero potuto vivere “secondo il Decameron”. Il che ci dice bene due cose: la prima è che il senso dell’ironia è ben presente, e che in realtà nessuno di loro voleva veramente vivere come i (libertini) personaggi del Boccaccio. La seconda, è che conoscevano Boccaccio! Cosa non scontata. Come non scontato è che conoscessero Dante, e perfino lo imitassero, con risultati sorprendenti (come nel caso del Zacuto de L’inferno allestito, poemetto secentesco ora tradotto per la prima volta in italiana da Michela Andreatta, pubblicato nel 2018 da Bompiani). Come per indica bene Gerald Strauss, vi furono certamente momenti molto felici, ma geograficamente e cronologicamente limitati, in cui vi fu quasi una “coherence of Hebrew and Italian culture”, e qui Strauss cita Mantova. Se si trattò come dice Strauss di una “sustained and largely successful act of assimilation” l’assimilazione prevede una rinuncia almeno parziale alla cultura (e non solo a quella!) di origine. E dunque non solo non si può parlare di “sintesi”, ma occorre parlare di una gerarchia di saperi, dove naturalmente, con tutte le dovute eccezioni, Atene prevale su Gerusalemme.
D’altra parte la questione non è solo legata al Rinascimento. Un’unità del sapere secolare e di quello religioso è aspirazione da sempre di personalità di “rottura” nel seno di diverse tradizioni religiose, ma soprattutto in quelle monoteistiche. In questo 2021 si ricordano i cento anni dalla pubblicazione – per portare l’esempio che ho più chiaro in mente al momento – de Der Stern der Erlösung di Franz Rosenzweig, estremo tentativo, in un contesto storico e speculativo, quello del 1921, che potrebbe essere considerato all’opposto diretto di quello rinascimentale, di formulazione di una filosofia della storia che coniugasse il secolare col religioso (cosa che peraltro alla fine non riesce). Ebbene il motto iniziale, Salmo 45, 5, “Avanza maestoso sul carro, per la causa della verità”, potrebbe essere ben letto nello spirito rinascimentale (il Salmo continua comunque includendo dopo la “verità”, la “clemenza” e la “giustizia”, legando l’aspetto (parzialmente) speculativo della “veritas” ebraica (che è poi soprattutto morale, “sincerità”, “fedeltà”) (infatti la traduzione tedesca che danno Buber e lo stesso Rosenzweig è “Treue”), a nozioni esplicitamente morali. Ma il Salmo potrebbe ben essere anche letto all’interno di un sistema affatto dogmatico, in cui la verità è la sola verità scritturale nella retta interpretazione (cosa che peraltro fu sempre fatta).
In ogni caso Veltri ci porta, riflettendo su tante figure, alcune note, altre meno, del tempo, ad interrogarci di nuovo sulle questioni di Roth. Ponendo, al contrario di Roth, quasi al centro della narrativa l’elemento scettico, come elemento innovativo. E qui sicuramente la discussione acquista un livello diverso, facendoci riconsiderare tutto l’apporto scettico, e l’elemento scettico (nelle sue varie declinazioni), nel contesto di un lungo Rinascimento che certamente giunge a metà del Seicento. Ma approfondire questa tematica non è certo possibile nei limiti che ci siamo qui ed ora ovviamente dati.
Significativo che anche in questo caso – come in altri – Mantova giuochi un ruolo fondamentale, in quanto patria del più progressivo ed ardito dei pensatori e scrittori presi in esame, Azariah de’ Rossi. Che già in epoca di incipienti minacce per gli ebrei, nel 1933, uno studioso singolare, che dovrebbe essere messo in giusta luce per le sue molteplici ma spesso oscure attività, Jacob Teicher, in un volume dei rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, licenziato mentre in Germania si avviavano, nel maggio 1933, i primi roghi di libri, poneva il De Rossi, sulla scorta di quanto fatto da Giovanni Gentile per Giordano Bruno, tra coloro che sostenevano una (moderata) prevalenza dei moderni sugli antichi, o quantomeno parità e/o complementarità di piani, discutendo del principio della “veritas filia temporis” nell’opera derossiana, del 1574, dunque di dieci anni precedente rispetto al ben più audace lavoro bruniano, La cena delle ceneri, del 1584, attacco un poco irriguardoso al mondo accademico oxoniense, ed in parte a quell’Inghilterra ove pure era stato abbastanza ben accolto, esule in perpetua fuga da se stesso, dall’Inquisizione.
Il gioco del dubbio, e il suo fulcro rinascimentale
Difficile circoscrivere – per passare ora al secondo libro di cui intendiamo parlare qui ed ora – in un solo ambito tematico e disciplinare anche un libro come Alienated Wisdom[3]. In linea di principio, non si dovrebbe trattare come un libro di storia, neanche di storia intellettuale o culturale, dal momento che il suo disegno, vastissimo, lo inserisce all’interno della teologia e della filosofia ebraiche, dal punto di vista storico-filosofico. Né peraltro giova alla sua collocazione l’ampio spettro cronologico toccato; che dalle gloriose antichità classiche, bibliche e latine, ci porta fino all’Ottocento della germanica “Wissenschaft des Judentums”, fino dunque a Leopold Zunz. Ben se ne avvede un veterano della filosofia ebraica, Warren Zev Harvey, emerito di filosofia presso l’Università di Gerusalemme, che amabilmente il libro ha prefato, indicandone il percorso straordinario, del tutto inedito: per ricostruire, tra l’altro, il ruolo della filosofia scettica nei movimenti del pensiero classico, alessandrino, medievale e rinascimentale, in un tentativo estremamente ambizioso: la decostruzione e ri-costruzione di un “canone” di sviluppo filosofico dove lo scetticismo e l’ebraismo si congiungono in un solo percorso, dirompente ma anche progressivo. Ricostruire un “canone” significa inserire nuovi autori, autori che magari sono filosofi, ma le cui opere filosofiche sono state ignorate del tutto ai tempi loro e fino ai nostri (Simone Luzzatto, ebreo veneziano, col suo Socrate di metà Seicento, caduto letteralmente nel nulla al momento della sua pubblicazione e rimasto in secolare oblio fino alla riscoperta da parte di Veltri), oppure inserirvi una poetessa ebrea che non solo non è filosofa in senso stretto, almeno agli occhi dei contemporanei, che ma di nuovo si trova ai margini del pensiero filosofico “mainstream” del suo tempo, come la (ben poco nota) Sara Copio Sullam (ai margini peraltro anche nei contesti accademico-letterari dei tempi suoi) (e che ritroviamo anche nel libro di cui abbiamo parlato prima). O ancora, far entrare in percorso strettamente speculativo un filologo ed ebraista (nonché ebreo) come Leopold Zunz, che in pieno Ottocento si trovava in un contesto filosofico (tecnicamente parlando) estremamente ricco, ma di cui professionalmente non faceva parte.
Veltri tuttavia, coraggiosamente anche in questo libro, oppone ai canoni consolidati, agli autori ben noti, una linea genealogica scettico-ebraica di tutto rispetto, in cui si assiste, tramite lo strumento scettico, al continuo amalgamarsi e respingersi di posizioni e tradizioni. E dove lo scetticismo, da corrente filosofica duplice, ma ben individuata nel contesto di altre, diviene catalizzatore unico di nuove idee e posizioni, distruttore di pregiudizi, prodromo al dialogo. Tutto questo nel contesto di una letteratura scientifica vastissima, da Jeremy Popkin a Gianni Paganini; e da una prospettiva ebraistica solo parzialmente presente nelle opere degli studiosi dello scetticismo ora citati, e in altri.
Sarebbe invero compito al di fuori delle mie possibilità entrare nei reconditi spazi speculativi di un volume della vastità di codesto. Basti, tuttavia, parlare al ruolo centrale in cui la “libera” filosofia del Rinascimento italiano, dal principio del Cinquecento fino alla metà del Seicento, giuoca in questa nuova prospettiva di pensiero. Il dubbio si insinua e sviluppa nel momento in cui vi è libertà di pensiero; la libertà di pensiero nel momento in cui vi è libertà politica. Il dogmatismo si sorregge sempre su di un’autorità extra-filosofica. Ed ecco dunque un episodio per me meraviglioso, eloquente, unico, cui Veltri dedica un capitolo illuminante, “Il sapere arcano in una libreria”.
Siamo nella Mantova dello splendore della corte gonzaghesca, nel 1548 o 1549. Una corte che però in quegli anni si trova nelle mani di un fanciullo, Francesco III, che morirà nel 1550 di polmonite, dopo essere caduto accidentalmente nel lago (in quella Venezia padana e fluviale che è Mantova) e poco dopo aver sposato Caterina d’Asburgo. Sua coetanea, entrambi sedici anni. Gli ebrei fioriscono. E addirittura hanno una vita sociale fuori delle mura del ghetto. L’episodio vede impegnati Amato Lusitano, medico e filosofo ebreo portoghese, un amico senza nome, e l’ebreo mantovano Azariah de’ Rossi, grande studioso di cose anche profane, storiografo ed esegeta. Si incontrano in una libreria di Mantova. Di cosa discutono? Di un’opera scritta trent’anni prima da Pietro (Colonna) Galatino, contro l’empietà degli ebrei e a favore di Johannes Reuchlin. Azariah de’ Rossi si inserisce nella conversazione, difende Reuchlin ed i gesuiti, che a suo dire lo difenderebbero a loro volta nella circostanza di accuse mosse contro di lui.
Siamo però in un vero e proprio teatro dell’assurdo, che ben mostra le capacità di spiazzare, sorprendere, simulare e dissimulare che sono proprie del pieno Rinascimento, italiano ed europeo. Un giuoco di maschere e infingimenti che sembra provenire da una commedia, ove al paralogismo aristotelico si affianca un’invenzione continua. Vediamo quali.
Innanzi tutto, quando Galatino scrive la propria opera, nel 1518, i gesuiti non esistevano proprio: la Compagnia ebbe una prima fondazione nel 1534, e poi quella definitiva nel 1540, con l’approvazione del nuovo ordine da parte di Paolo III. Che cosa voleva dire dunque de’ Rossi? Intendeva in qualche modo ingraziarsi un ordine che già si intuiva che si sarebbe espanso enormemente, per arrivare a Mantova qualche decennio dopo? Galatino era un francescano, e colui che viene qui “erroneamente” indicato come difensore di Reuchlin, Jacob van Hoogstraten, era a propria volta un domenicano, ed i domenicani ebbero un ruolo fondamentale nell’Inquisizione romana, istituita proprio nel 1541 dallo stesso Paolo III che aveva autorizzata la Compagnia di Gesù un anno prima. Ora questo “errore” temporale sembra indicare che gli ebrei, e il libero pensiero, avevano forse più da avvicinarsi a gesuiti e francescani, piuttosto che ai domenicani stessi, dei secondi, e poi anche e soprattutto dei primi, fierissimi avversari. Le traversie subite da Reuchlin – non però nel 1518, ma in altri momenti della sua vita, come giustamente fa notare Veltri – appartenevano ancora ad una dimensione antecedente la Riforma. Reuchlin ne vede solo gli esordi, muore nel 1522. Anche se è nota la discussione di storici come Heinrich Graetz e Francis Yates riguardo al ruolo fondamentale che Reuchlin ebbe nel dar inizio alla Riforma stessa, dati i suoi rapporti (ancora poco chiari) con Lutero. Ma i tasselli misteriosi e affascinanti di questa “libera discussione” in una libreria ricca di novità, una scena così moderna, quasi settecentesca piuttosto che cinquecentesca, sono a ben guardare diversi altri. Il medico portoghese Amato Lusitano avrebbe dovuto trovarsi a Ferrara in quegli anni, e non a Mantova, a sezionar cadaveri insieme al celebre e spregiudicato anatomista cristiano Giambattista Canano. A Ferrara la comunità ebraica era fiorente. Possiamo pensare che si sia recato occasionalmente a Mantova a trovare amici e comprar libri? Può darsi. Singolare anche che il libro di Pietro Galatino di cui si discute venisse stampato da uno dei maggiori tipografi ebrei del Cinquecento, quel Geronimo Soncino nel 1518 operante ad Ortona. Non si trattava di un libro che parlava di “perfidia” degli ebrei (anche se i motivi giudeofili alla fine, a nostro avviso almeno, prevalgono su quelli giudeofobi) che ostinatamente non vogliono riconoscere l’avvento di Cristo e della nuova religione, negando perfino quanto presente nei loro stessi testi sacri, anticipatori, per Galatino, del verbo cristiano? E se come vogliono gli studiosi si fosse in presenza di due “Soncino”, e Gershon e Girolamo fossero due persone diverse, entrambi però tipografi, magari il secondo convertito al Cristianesimo? Chi ha davvero stampato l’opera? Non solo, ma il libro di Galatino è un perfetto esempio di argomentare socratico, un dialogo a tre, sul tema del valore appunto da attribuire ai testi sacri ebraici nel contesto della dottrina cristiana. Solo lo “Inquisitor Fidei” Hochstraten sostiene la negatività e dannazione di tutti i libri sacri ebraici. Mentre gli altri due chiaramente sostengono la loro utilità, non in sé, ma in quanto (e nella misura in cui sono) pieni di argomenti che comproverebbero la validità del Nuovo Testamento, come compimento dell’Antico. Che il fittizio o reale incontro nella libreria di Mantova fosse una messa in scena del dialogo di Galatino, quasi teatrale, e il terzo interlocutore, che rimane misterioso, sia proprio lo “spirito inquisitoriale” divenuto convitato di pietra? Sia proprio Hochstraten? In fondo siamo nella finzione, Hochstraten era morto nel 1527, con sulla coscienza il poco edificante episodio del primo rogo di Protestanti perpetrato dai Cattolici, quello Johann Esch e Heinrich Voes, avvenuto nel 1523, un anno dopo la morte di Reuchlin stesso, quest’ultimo in pace.
La storia neanche finisce qui – eppure su questo singolo episodio come narrato finora ci si potrebbe scrivere un libro. La vicenda misteriosa e intrigata, ed intrigante, continua. Eccome.
Ad inizi Seicento l’immensa popolarità del testo di Galatino suscita qualche dubbio – eccoci ancora nella regione sacra del dubbio, dello scetticismo – nel mondo erudito europeo, nella “repubblica delle lettere” secentesca. Come ci racconta Carlo Colombero, nella voce del DBI dedicata a Galatino e ormai risalente al 1982:
“L’opera ottenne uno straordinario successo presso gli ambienti della Curia romana. Tuttavia, e forse fu questa la causa principale del declinare della fama dell’autore, dopo la sua morte egli fu accusato di plagio. Tra il 1603 e il 1604 Giuseppe Scaligero, nella corrispondenza con Isacco Casaubon, affermò che il Galatino aveva troppo largamente attinto dal Pugio fidei, composto nel 1272 dal domenicano spagnolo Raimondo Martinez; secondo Antonio Possevino egli avrebbe invece ricalcato la Victoria adversus impios Hebraeos del certosino genovese Selvaggio Porchetti (morto nel 1315), il quale però, a sua volta, come egli stesso ammette, si ispira a Martinez. Fu in parte confermata l’ipotesi di Giuseppe Scaligero quando, nel 1651, fu stampata l’opera di Martinez e fu possibile effettuare un confronto tra i due scritti.”
Insomma, un plagio, non solo, ma un ritorno di argomentazioni tardo-medievali. Di tempi in cui la Riforma era ben lontana, e dunque un testo che non si poteva riferire direttamente a quello che stava accadendo al momento della pubblicazione. A parte che molto ci sarebbe da discutere sulla stessa nozione di “plagio” ai tempi, e probabilmente con differenze sensibili nel significato e nella portata della nozione da Cinque a Seicento, e da Seicento a Settecento, chiaramente il libro del Galatino aveva in qualche modo dei vizi che solo il tempo – e l’invidia (della sua fama, peraltro postuma) – “veritas filia temporis” (!), ha potuto far emergere.
Peraltro (e qui il mistero si infittisce ulteriormente, caso mai ce ne fosse bisogno) a Mantova in quegli anni non risulta presente neanche lo stesso ebreo mantovano Azariah de’ Rossi. Che era forse a Ferrara, forse ad Ancona nel 1548-1549.
Che, in un gioco di simulazioni veramente sofisticato, la scena sia svolta a Ferrara e sia stata “letterariamente” trasposta a Mantova? Per qual ragione mai? Siamo in un anno importante per gli ebrei, che si sentono sempre più al centro di una vita intellettuale italiana che solo l’avvento di Paolo IV nel 1555 interromperà brutalmente, forse definitivamente. Nel 1548 – mentre i nostri tre interlocutori si intrattengono amabilmente in una libreria mantovana, secondo la leggenda – Cosimo I de’ Medici fa il primo, timido tentativo di rendere Livorno metropoli aperta al commercio internazionale, ed attirarvi mercanti di ogni nazione. La cosa non riesce. Avverrà solo colla “Livornina” di Ferdinando I, nel 1593. Non solo, ma la stampa ebraica celebra un suo notevolissimo successo, con la stampa, proprio tra 1548 e 1549, da parte di Carlo Querini o Querino, a Venezia, delle Mišnayot curate da ‛Ovadyah ben Abraham Yare di Bertinoro, con la collaborazione di Meir Parenzo (gli studi di Chiara Camarda ci hanno recentemente illuminato su tutto questo). Mentre nel 1548 si concludeva, e sempre a Venezia, per i tipi notissimi di Daniel Bomberg, la pubblicazione del Talmud babilonese, col volume contenente il trattato “Zevaḥim”, il trattato dunque sui sacrifici animali, finora escluso dalle edizioni precedenti. Trattato molto complesso, e carico di significati anche per il mondo cristiano, si pensi solo al significato dell’agnus Dei. Bomberg peraltro non era più a Venezia, morirà nel 1549 nella natia Anversa. Perché vi aveva fatto ritorno?
Come ha mostrato bene la Camarda (e questo potrebbe spiegare molte cose), sono anni in cui si comincia a mettere argini censori, perfino nella stessa libera Venezia, alla produzione libraria, con controlli sempre più stretti sulla produzione, e sullo stesso possesso di libri “pericolosi” o “proibiti”. Il ruolo dei Savi all’Eresia venne esteso proprio a partire dal 1547. Un decreto del 18 luglio 1548 prevedeva sanzioni per chi in possesso di libri “proibiti” (secondo l’Indice, pubblicato a Venezia per la prima volta in versione definitiva nel 1549 ma già circolante prima, dopo quello olandese del 1529 e prima di quello parigino del 1551) ai Tre Savi. Una misura che spinse (ad esempio) l’importante libraio-editore Tommaso Giunti a chiedere lumi al Consiglio dei Dieci. La questione toccava soprattutto la produzione protestante. Ma come ben noto nel calderone finirono anche i testi ebraici. Giovanni della Casa, arcivescovo, venne inviato proprio nel 1548 a Venezia ad aiutare nell’opera di purga, ma non trovò abbastanza cristiani in grado di aiutarlo nella difficile opera di comprensione dei testi ebraici. E dunque si concentrò su quelli cristiani, in latino o altre lingue a lui conosciute. A partire dal 1554, mentre le cose stavano andando verso il peggio, venne istituito un comitato di auto-censura da parte del rabbinato veneziano.
Si comprende bene dunque qual significato assuma un semplice incontro in una libreria mantovana in un contesto del genere. Veltri mirabilmente ci conduce nel significato della disputa, con ebrei liberamente ma cautamente capaci di utilizzare fonti cristiane, ed ebraisti cristiani a proprio agio in quelle ebraiche. E nel secolo che va da questo incontro forse mai avvenuto e denso di significati reconditi, e la pubblicazione del Socrate da parte di Simone Luzzatto, nel 1651, si compie il destino del pensiero scettico nella misura in cui entra nel circuito delle idee, mirabile, del Rinascimento italiano, e non solo italiano. Giustamente, Veltri nota come non troppo spesso i grandi Maestri come Burckhardt, fino a Garin, abbiamo sopravvalutato la “ragione” rinascimentale, ed abbiamo spostato l’orologio della storia troppo in avanti, trasformando il Rinascimento in Illuminismo. Ma nel discorso di Veltri, che inizia nel mondo classico e finisce nell’Ottocento, il Rinascimento è chiave di volta.
Il titolo del suo libro riprende, consapevolmente, il capolavoro del 1975 di Arnaldo Momigliano: Alien Wisdom. Ove si studiava il rapporto della civiltà greca con la romana, celtica, ebraica e persiana. Veltri invece studio uno snodo concettuale, il procedere scettico, nel suo “alienarsi” in differenti tradizioni, che poi sono una e la stessa, alla base della civiltà occidentale.
Sia lode al dubbio, diceva Bertold Brecht.
Mai come in questi giorni vediamo affrontarsi scuole di pensiero, ove il dubbio giuoca un ruolo fondamentale, ma non in accademie: in gran parte delle piazze del mondo. Singolarmente, il mondo medico – ora al centro della scena – lo era anche in quel 1548, o 1549: Lusitano è innanzi tutto medico, e il metodo scettico ha consentito enormi progressi in medicina, a partire dal Rinascimento. Un medico ebreo americano, Harry Friedenwall (1864-1950), nativo di Baltimora, acceso sionista, discendente da una famiglia di medici importanti, è colui che nel lontano 1944 ci narra la vicenda dell’incontro nella libreria mantovana, in un libro non filosofico, ma su “The Jews and Medicine”.
Qualcosa che, probabilmente mai avvenuto, è davvero meraviglioso per tutto quel che implica. Il dubbio non è materia di conversazione in una libreria. Il dubbio non è solo questione accademica. Muove le masse. La Riforma nasce dal germe del dubbio, innestato a livello popolare. Il Papa è dipinto – letteralmente – come Anticristo, nelle prime rozze e ora rarissime stampe popolari circolanti in tutta Europa per la gran massa degli analfabeti. E le masse sostengono i principi protestanti. Se lo credono. Se non lo credono, rimangono nel seno di Roma. Dal Rinascimento si diparte, nella direzione del passato, e in quella del futuro, il nodo speculativo che anima non solo la modernità, ma la filosofia stessa.
Due libri dunque, in conclusione, da leggersi l’uno insieme all’altro, come sintesi di un mirabile ed unico percorso di studioso, che va avanti da quaranta anni almeno, che darà senz’altro ancora, lo speriamo, una quantità notevolissima di frutti.
Bernardini Paolo Luca
Note a piè di pagina:
[1] La stesura del presente articolo è stata resa possibile dallo Hamburg Institute for Advanced Study, di cui sono Fellow nell’anno accademico 2021-2022, e che qui ringrazio, nelle persone di tutto il suo staff e tutto il suo comitato scientifico ed esecutivo, per avermi accolto e sostenere la mia ricerca, dedicata al concetto di “Veritas filia temporis” e le sue varie declinazioni tra Rinascimento ed Illuminismo. Il primo scritto compreso qui è stato pubblicato il 25 novembre 2021 su Giornale di Storia, rivista online diretta da Marina Caffiero (che ringrazio per aver concesso la pubblicazione del medesimo, leggermente modificato, qui) (paragrafo 2). Il titolo era: “Il Rinascimento e l’Ebraismo: tra il Ghetto e l’Europa”. Il secondo scritto compreso qui, al paragrafo 3, è stato pubblicato sul blog di storia de “Il Corriere della Sera”, La Nostra Storia, a cura di Dino Messina, che qui ringrazio, col titolo “Il gioco del dubbio. Ebrei, Rinascimento, scetticismo”.
[2] G. Veltri, Il Rinascimento nel pensiero ebraico, Brescia, Paideia, 2020.
[3] G. Veltri, Alienated Wisdom. Enquiry into Jewish Philosophy and Scepticism, Berlin, De Gruyter, 2018, pp. 424.