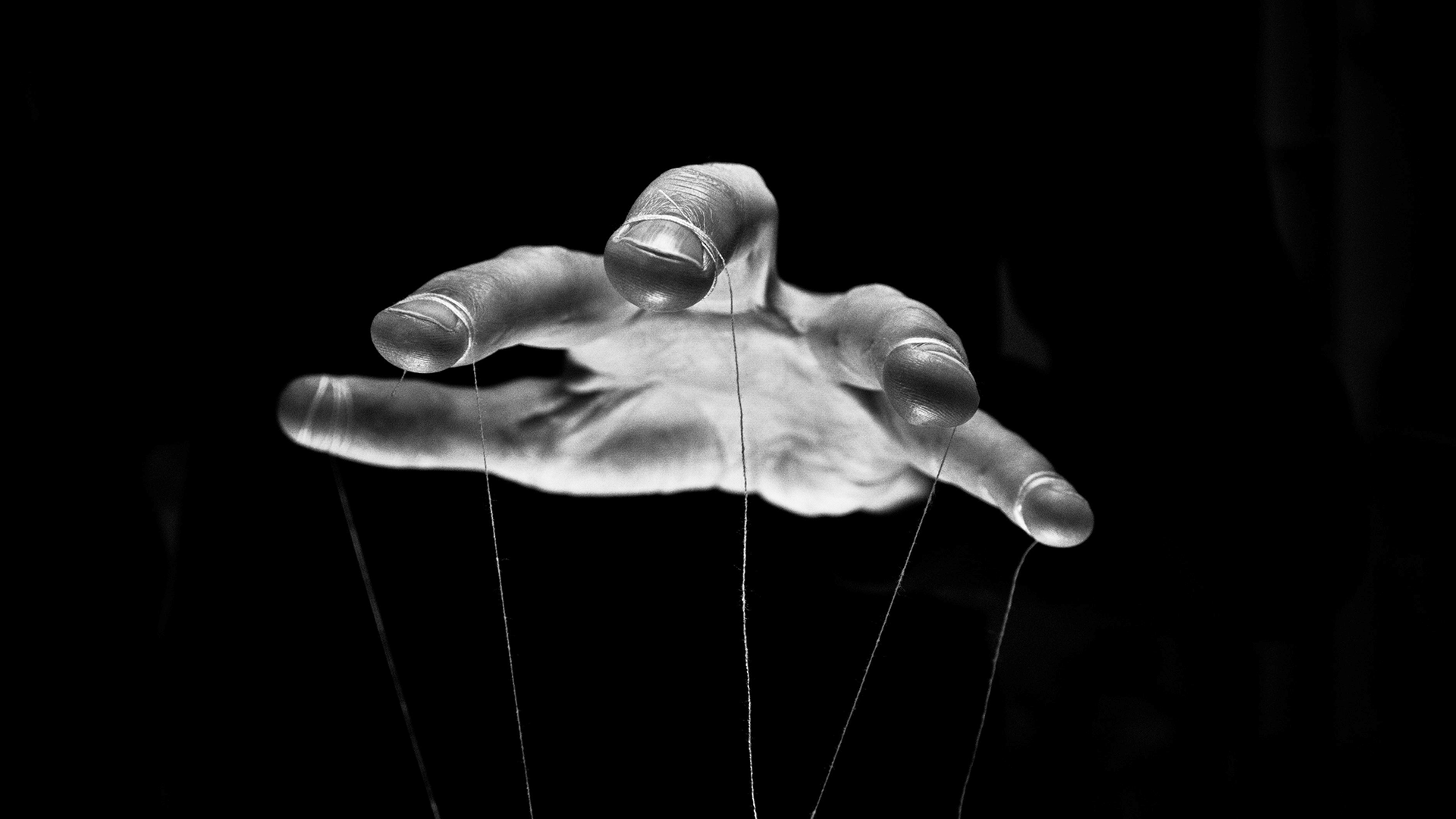“La scienza di nuovo incantata. L’olismo nella cultura tedesca da Guglielmo II a Hitler” di Anne Harrington – La recensione
L’approfondito studio di Anne Harrington [La scienza di nuovo incantata, Fioriti editore, Roma 2018], nonostante affronti un tema decisamente caratterizzato, propone una serie di considerazioni di ordine storico-culturale così rilevanti, da assumere un’importanza cruciale rispetto ad alcune tematiche al centro della drammatica svolta culturale contemporanea, in particolare quella relativa al rapporto tra il sapere scientifico e il più ampio orizzonte di competenza delle discipline storico-sociali. Un’affermazione che potrebbe sorprendere, dal momento che la fatica della Harrington si concentra non solo su un tema estremamente specifico, ma anche su un ben preciso contesto geografico-nazionale. Eppure le analisi della studiosa sono in grado di suggerire valutazioni che vanno bel oltre quanto contenuto nelle pagine del suo lavoro, anche se a volte tali effetti di lunga durata sembrano sfuggire persino alla consapevolezza dell’Autrice.
 Il sottotitolo dell’opera, l’olismo nella cultura tedesca da Guglielmo II a Hitler, definisce dal punto di vista dello specifico disciplinare il proprio oggetto. E’ difficile in realtà proporre una definizione univoca di «olismo», dal momento che al suo interno si elaborarono teorie spesso tra loro in conflitto, ma è possibile coglierne almeno alcuni significativi aspetti comuni: si trattò del tentativo di opporsi al dispiegarsi dei presupposti teorici del meccanicismo nella ricerca scientifica, le cui conseguenze conducevano allo sterile costituirsi di ambiti di ricerca sempre più specialistici e fra loro isolati. L’esigenza dell’olismo era quella di concepire una metodologia di ricerca che faceva capo alla categoria di “totalità”, per opporsi allo sviluppo frazionato e disincantato che sembrava caratterizzare in modo irreversibile l’orizzonte della ricerca fisico-biologica. Il fine era quello di fondare una scienza capace di rendere nuovamente conto di una visione unitaria della natura.
Il sottotitolo dell’opera, l’olismo nella cultura tedesca da Guglielmo II a Hitler, definisce dal punto di vista dello specifico disciplinare il proprio oggetto. E’ difficile in realtà proporre una definizione univoca di «olismo», dal momento che al suo interno si elaborarono teorie spesso tra loro in conflitto, ma è possibile coglierne almeno alcuni significativi aspetti comuni: si trattò del tentativo di opporsi al dispiegarsi dei presupposti teorici del meccanicismo nella ricerca scientifica, le cui conseguenze conducevano allo sterile costituirsi di ambiti di ricerca sempre più specialistici e fra loro isolati. L’esigenza dell’olismo era quella di concepire una metodologia di ricerca che faceva capo alla categoria di “totalità”, per opporsi allo sviluppo frazionato e disincantato che sembrava caratterizzare in modo irreversibile l’orizzonte della ricerca fisico-biologica. Il fine era quello di fondare una scienza capace di rendere nuovamente conto di una visione unitaria della natura.
Nelle varie personalità dell’olismo, al di là delle attività di ricerca e di applicazione sperimentali, tende ad emergere un giudizio di valore che vede nella decadenza del mondo contemporaneo, caratterizzato dal dominio della tecnica e della macchina, un’involuzione tesa in particolare a mortificare gli elementi più esclusivi della cultura tedesca. Più che un’analisi oggettiva dei dati fisico-naturali, il meccanicismo rappresenterebbe un punto di vista riduttivo su quegli stessi fenomeni dovuto a un mutamento di carattere antropologico affermatosi nella modernità. In base a questo nuovo paradigma gli scienziati sarebbero interessati unicamente al valore pragmatico della ricerca; in coerenza con una nuova e diffusa mentalità, per cui un’esistenza positivamente realizzata veniva a coincidere con la possibilità di accedere a un’abbondanza di beni materiali, e non nell’identificazione culturale-spirituale con la propria comunità. Un esito considerato sciagurato soprattutto per la Germania. Non è un caso – come accenneremo – che in tutti gli scienziati che aderirono alla corrente dell’olismo la disfatta tedesca nella prima guerra mondiale rappresentò un trauma irrecuperabile, che sembrava confermare quel destino di inevitabile declino dello spirito tedesco, in parte anche causa della umiliante sconfitta. In realtà l’olismo guardò con preoccupazione ai destini della società tedesca già a partire dall’unificazione della Germania sotto Bismark, certo esaltandosi per alcuni temi nazionalistici, ma valutando con preoccupazione – come fece in quegli anni anche Nietzsche, insieme a Wagner un punto di riferimento irrinunciabile per gli scienziati olisti – una modernizzazione della società destinata a mettere in discussione gli aspetti più significativi della cultura germanica.
L’olismo rappresentava non tanto una valida corrente scientifica fisico-biologica alternativa a quella di orientamento meccanicistico, quanto un modello di scienza tipicamente tedesco. In particolare, un ritorno alla scienza della natura di Goethe, una possibilità di rimettere in discussione la “presunta” vittoria della fisica newtoniana, a partire dalla teoria goethiana dei colori. Un contrapporre la tradizione scientifica tedesca a quella inglese, che sembrava ormai dilagare; a rappresentare la quale, in senso polemico per gli olisti, non c’era solo Newton, ma anche Charles Darwin, pure responsabile di una lettura anti teleologica destinata a respingere la categoria di totalità dalla riflessione della scienza.
 Come si nota, una contestualizzazione talmente caratterizzata che spiega come lo studio della Harrington possa risultare significativo non solo per chi è interessato alla storia della scienza, ma anche a chi voglia approfondire sul piano storico-culturale un periodo particolarmente drammatico della storia tedesca ed europea, in particolare le ragioni del vasto consenso intellettuale verso il regime nazionalsocialista. Anzi, se volessimo ancora più nettamente circoscrivere l’argomento dello studio in oggetto, esso si radica in quella tradizione di ricerca determinata a stabilire l’eventuale esistenza di un sonderweg tedesco. In effetti, i pilastri culturali su cui poggia l’olismo non sembrano comprensibili se non all’interno della particolare situazione della Germania di allora. Non a caso, nell’Introduzione, si fa riferimento alla celebre conferenza di Max Weber, Die Wissenschaft als Beruf, tenuta all’Università di Monaco nel 1918. Weber sembrava confermare tutte le preoccupazioni che abbiamo appena riferito, anche se egli non cercava affatto di contrapporvisi, in quanto le interpretava –sia pure con un tono di rassegnato disincanto- quale esito inevitabile dello sviluppo scientifico moderno, destinato a travolgere anche la cultura tedesca. La scienza avrebbe introdotto il “disincanto” nel mondo, ne avrebbe «scardinato tutti i principi trascendenti», lo avrebbe spogliato «di tutto il mistero spirituale, del “significato etico […] trasformandolo in un mero meccanismo casuale».
Come si nota, una contestualizzazione talmente caratterizzata che spiega come lo studio della Harrington possa risultare significativo non solo per chi è interessato alla storia della scienza, ma anche a chi voglia approfondire sul piano storico-culturale un periodo particolarmente drammatico della storia tedesca ed europea, in particolare le ragioni del vasto consenso intellettuale verso il regime nazionalsocialista. Anzi, se volessimo ancora più nettamente circoscrivere l’argomento dello studio in oggetto, esso si radica in quella tradizione di ricerca determinata a stabilire l’eventuale esistenza di un sonderweg tedesco. In effetti, i pilastri culturali su cui poggia l’olismo non sembrano comprensibili se non all’interno della particolare situazione della Germania di allora. Non a caso, nell’Introduzione, si fa riferimento alla celebre conferenza di Max Weber, Die Wissenschaft als Beruf, tenuta all’Università di Monaco nel 1918. Weber sembrava confermare tutte le preoccupazioni che abbiamo appena riferito, anche se egli non cercava affatto di contrapporvisi, in quanto le interpretava –sia pure con un tono di rassegnato disincanto- quale esito inevitabile dello sviluppo scientifico moderno, destinato a travolgere anche la cultura tedesca. La scienza avrebbe introdotto il “disincanto” nel mondo, ne avrebbe «scardinato tutti i principi trascendenti», lo avrebbe spogliato «di tutto il mistero spirituale, del “significato etico […] trasformandolo in un mero meccanismo casuale».
Molti in Germania non vollero rassegnarsi a questa prospettiva; diverse figure intellettuali insorsero e cercarono una via d’uscita tedesca rispetto alla scienza meccanicistica, rifiutando il dominio della macchina, introducendo criteri di spiegazione alternativi; in alcuni casi attraverso una metodologia che faceva comunque capo a una verifica sperimentale, ma in molti altri ritenendo giustificato introdurre elementi irrazionalistici con i quali proporre, in nome del valore della “totalità”, un’immagine diversa della natura, quale depositaria non solo di leggi fisiche ma anche di valori.
Se questi sono i presupposti, e se si fa riferimento al sottotitolo del libro, i conti sembrano effettivamente tornare; l’olismo costituirebbe un orizzonte culturale fecondo per l’imporsi progressivo dell’irrazionalismo, sostenitore di quella ricerca in qualche modo anacronistica di una scienza compiutamente “tedesca” che avrebbe favorito la presa del potere del nazismo, con la cui visione del mondo, della natura, della storia e della comunità la scienza olistica sembra condividere diversi elementi. E il valore del lavoro della Harrington si giustificherebbe proprio in virtù di questo indispensabile approfondimento di alcuni elementi fondativi la cultura del nazismo, senza conoscere i quali diventa impossibile anche ai nostri giorni comprendere il diffondersi presso larghi strati dell’opinione pubblica di tali ideologie regressive. Criterio interpretativo che viene indubbiamente rafforzato dalla lettura dei primi tre capitoli del libro.
Da questo punto di vista, l’impostazione de La scienza di nuovo incantata potrebbe ricordare il noto progetto di György Lukacs che fa capo a La distruzione della ragione, non a caso citato nella importante introduzione all’edizione italiana, a opera di Luigi Corsi, curatore dell’opera, il quale ha voluto –e si tratta di una scelta molto preziosa- confrontare tutte le traduzioni dal tedesco all’inglese dell’autrice e fornire al lettore in nota i testi originali degli autori via via indagati, così da rendere conto anche delle diverse difficoltà interpretative incontrate dalla Harrington. Un lavoro che indaga un campo di studi non molto conosciuto e poco coltivato in Italia, e già solo per questo benemerito. Risulta interessante notare come alcuni degli autori citati in questo studio, che pubblicarono opere allora note e discusse e che ebbero importanti frequentazioni intellettuali, sia scientifiche sia filosofiche, non siano presi in considerazione nel pure imponente lavoro enciclopedico sull’irrazionalismo proposto dal filosofo ungherese. E già per questo, la lettura de La scienza di nuovo incantata colma una lacuna e fa indispensabile opera di conoscenza. La Harrington inoltre ha ben presenti alcuni evidenti limiti dell’opera di Lukacs –al di là del fatto che se ne possa considerare valido l’impianto teorico generale- e vuole evitare qualsiasi lettura deterministica.

Anne Harrington
Lo studio della Harrington ha però un ulteriore obiettivo, che ne accresce decisamente il valore e l’importanza; mettere in discussione proprio quella apparente naturale continuità tra olismo e nazismo, contraddetta in realtà da moltissimi dati teorici e storici, che lo studio in oggetto riassume in modo puntuale e minuzioso, ma anche molto coinvolgente. Come abbiamo anticipato, la lettura dei primi tre capitoli potrebbe in modo pacifico far propendere per la tesi della continuità. Il primo, di carattere generale, sembra non solo corroborare l’idea di uno specifico sonderweg tedesco, ma presentare una dinamica storica che sempre più conduceva ad associare la crisi della breve esperienza democratica della Germania, quella di Weimar, all’idea di fallimento dello stesso meccanicismo, inteso quindi come un tradimento della cultura tedesca. Tutto ciò sulla base di un percorso intellettuale paradigmatico: superare il limite d’interpretazione delle teorie scientifiche, per far sconfinare i dati naturalistici nei criteri di giudizio storico-culturali, quasi sempre in una prospettiva di lettura reazionaria. E con significativi riferimenti al mito wagneriano o alle pagine di Nietzsche, intese comunque come espressione di un conservatorismo e riscatto tedesco.
Il secondo capitolo è dedicato alla figura di Jacob Johann von Uexküll, il primo rilevante esponente dell’olismo, attivo ad Amburgo, di cui diresse l’Istituto di ricerca per diversi anni, e poi a Napoli, presso la stazione biologica, dove compì i suoi studi più importanti. Di Uexküll, come di ciascuna delle personalità considerate dalla Harrington, viene riferita in modo accurato la storia culturale. Esponente del nazionalismo baltico (era lettone, di famiglia nobile), dagli accesi sentimenti anti russi, Uexkühll guardava con sospetto qualsiasi processo di organizzazione politica di carattere pluralistico. E tale convinzione politica viene posta in relazione con il principale concetto scientifico da lui teorizzato, quello di di Bauplan, principio allo stesso tempo biologico, politico e spirituale. A esso Uexküll era giunto attraverso un modello di ricerca, relativo alla vita e al comportamento, di netta impostazione anti meccanicistica, basata sull’idea che l’organismo e l’ambiente formerebbero un unico sistema integrato. Una convinzione sì scientifica, ma che coincideva con una vera e propria Weltanschaung, tanto da ricevere gli elogi di personalità dei più diversi ambiti, da Konrad Lorenz a Martin Heiddegger. Non è questa la sede, ovviamente, per precisare in modo analitico i fondamenti di tale visione; basti qui citare l’uso disinvolto operato nei confronti del pensiero kantiano, rispetto al quale Uexküll aggiunge una ulteriore categoria, quella di «individualità».
Una decisa declinazione in senso politico del Bauplan si verifica in particolare dopo la Prima Guerra mondiale; scioccato dall’intervento britannico contro la Germania, nonché dalle vicende russe e dall’umiliante pace imposta alla Germania dopo la guerra, Uexküll cercherà di recuperare l’autentico spirito culturale tedesco, spaventato dalla regressione culturale –a suo dire- dovuta alla cultura di massa dell’epoca weimeriana. Il passo successivo sarà quello di considerare lo Stato alla stregua di un organismo e concepirlo di conseguenza come un’individualità forte, capace di impedire alle masse l’accesso al potere. Da questo punto di vista qualsiasi fenomeno a fondamento del pluralismo democratico, dal capitalismo alla libertà di stampa al giornalismo, sono intesi quali avversari, identificati con agenti parassitari che colpiscono il corpo forte dello Stato sempre più immedesimato con il Volk che lo abita, a suo volta concepito attraverso un’opera di distinzione antropologica all’interno della specie e delle razze. Nonostante ciò, e nonostante una venatura sempre più mistico-panteistica degli anni successivi, i rapporti di Uexküll con il regime nazista saranno sempre impostati sull’ambiguità e mai sulla piena adesione. Sia per una ragione scientifica (riteneva che gli sforzi di ricerca in biologia dovessero vertere soprattutto sull’ambiente piuttosto che sulla razza), sia perché non aderì mai in modo organico all’antisemitismo (anche se le sue dichiarazioni verso gli ebrei sono tra loro molto contrastanti, a seconda che venissero pronunciate in contesti privati o pubblici). Rimane rilevante ricordare la sua partecipazione a una serata organizzata nella casa di Elizabeth Forster Nietzsche, congiuntamente ad altri esponenti del regime.
Il terzo capitolo è dedicato a Costantin von Monakow, le cui teorie presero progressivamente una piega sempre più mistico-irrazionale, ma che in realtà suscitarono interesse presso i più disparati ambienti intellettuali e scientifici. Da una parte ritroviamo nella sua personalità alcune caratteristiche comuni con il personaggio precedente, quali il disprezzo per il modernismo, per la secolarizzazione, la tecnologia e, in politica, per la rivoluzione; oltre a una sincera ammirazione per l’opera wagneriana. Anche lui subì uno shock culturale a seguito dell’esito della Prima guerra mondiale, che contribuì ad accentuare in senso sempre più ideologico la sua ricerca. Monakow fu il rappresentante di una neurologia non meccanicistica, che presenta in un primo tempo diverse analogie con la teoria freudiana (Freud stesso mostrò attenzione per le ricerche di Monakow) e successivamente con quella di Jung. L’analisi neurologica doveva legarsi alla storia individuale del singolo organismo e veniva applicata in base a una dinamica temporale cui non risulta estranea l’influenza di Bergson. Sempre in linea con la teoria del filosofo francese, Monakow sosteneva l’esistenza di una forza creativa extra individuale, da lui chiamata «impulso hormico». Numerosi nel suo lavoro i riferimenti ai grandi nomi della filosofia tedesca, per lo più in una chiave sincretistica; e anche in lui prevale l’antipatia per il pluralismo politico, per l’egualitarismo di stato, colpevole di quella «decadenza amorale dell’umanità», alla base del disastro della Prima Guerra mondiale.
E’ nei capitoli 4 e 5, però, che la narrazione subisce una svolta inaspettata, e il quadro generale comincia a farsi decisamente più problematico. I capitoli sono dedicati rispettivamente ai due principali teorici della Gestalt, Michael Wertheimer e Kurt Goldstein, tra i quali si è verificata anche una polemica per presunti plagi reciproci. La loro importanza è indubbia, fosse solo perché la teoria della Gestalt rappresenta l’esito più duraturo e più celebre di tutta l’attività dell’olismo tedesco. Le vicende biografiche di entrambi gli scienziati, di origini ebraiche ed entrambi costretti a rifugiarsi negli Stati Uniti con l’avvento al potere del regime nazista, dimostrano l’impossibilità di qualsiasi lettura sia riduzionista sia determinista dell’olismo. Certo, le due personalità rappresentano un esempio di intellettuali ebreo-tedeschi profondamente radicati nella cultura nazionalista della Germania, sostenitori inoltre di una modalità prettamente tedesca di avvicinarsi allo studio della natura, in particolare all’ambito sia biologico sia psicologico, che si ponesse in antitesi con l’arida concezione meccanicistica. Se Wertheimer e Goldstein certo non potevano immaginare il drammatico esito dell’esperienza weimeriana, che li avrebbe colpiti anche personalmente, pure avrebbero potuto cogliere le ambiguità di una teoria scientifica che fatalmente finiva per declinarsi anche sul piano razziale, con punte evidenti di antisemitismo. Non a caso, sempre nel capitolo 4, la Harrington propone una lunga analisi sulle ragioni che portarono Houston Stewart Chamberlain, genero di Wagner, uno dei massimi esponenti del razzismo biologico cui il regime nazista esplicitamente si ispirò, a condividere i principi dell’olismo. La scelta dell’autrice si spiega facilmente: se da una parte gli studi di Wertheimer e Goldstein permettono di evitare letture troppo facili riguardo le implicazioni ideologiche dell’olismo, d’altra parte la studiosa non può che mostrare il proprio stupore nel constatare l’utilizzo da parte loro di un’espressione, come quella di Gestalt, emersa in un contesto di pensiero decisamente reazionario e intollerante. Il concetto di Gestalt, in effetti, altro non era che un diverso modo di pensare la totalità, concepita non tanto in opposizione alla “macchina”, bensì al caos. La Gestalt rappresentava la forma che dava un senso al finalismo implicito della natura, teorizzato da Goethe, e che si opponeva alla casualità che invece sembrava caratterizzarla in base allo sviluppo delle scienze fisiche nel XIX secolo, e in particolare con la teoria dell’entropia. Gli accademici tedeschi, o almeno una parte di loro, si sentì investita dal dovere di contrapporsi a questa possibile visione apocalittica. Ovviamente, sulla base della mentalità diffusa allora, bastò poco a compiere quell’illegittimo salto epistemologico che portava a collegare il caos fisico al caos politico, in base a una logica secondo la quale la «legge dei fisici dell’entropia avrebbe iniziato ad apparire sospetta nella veste di “sovversione ed egualitarismo comunista-giudaico». Furono queste le premesse del lavoro di Chamberlain. Da un’impostazione decisamente anti darwiniana, colpevole di individuare le modifiche evolutive della specie in criteri sostanzialmente casuali, egli recuperava la teoria goethiana della Gestalt, intesa come la finalità immanente agli organismo viventi, destinata a concretizzarsi nelle razze e nelle specie. Da qui ne derivava una prospettiva eugenetica che avrebbe dovuto risolvere il caos razziale, ripristinando la finalità implicita in ogni specie.
Wertheimer utilizzò questo concetto ai fini, totalmente opposti a quelli di Chamberlain, di un programma culturale liberale e giudaico. Il suo punto di partenza è il tema weberiano del “disincanto”, per negarne però l’esito fatalistico e sostanzialmente rassegnato. La teoria della Gestalt sarebbe capace, a suo dire, di ricomprendere in una visione unitaria la fisica con la coscienza, fino a teorizzare un’unità tra musica, coscienza e fisica, che troverebbe in Beethoven il suo massimo riferimento. Per quanto discutibili, le intenzioni di Wertheimer andavano in una direzione decisamente progressista, sino a suscitare l’interesse sia di Herbert Marcuse sia di Max Horkheimer. Tanto che Wertheimer finirà per collaborare, esiliato negli Stati Uniti, al progetto di studio francofortese sulla personalità autoritaria. Questa evidente declinazione di sinistra non era sfuggita ai teorici più reazionari dell’olismo, e in particolare alla corrente di ricerca psicologica che faceva capo alla Scuola di Lipsia, di cui Felix Krueger era la personalità più importante. Fatalmente, le ipotesi sulle tipologie umane e sulla struttura studiate a Lipsia finivano con il convergere con un razzismo nazionalista, sino a elaborare un concetto di «supertipo» che declinava in forma totalmente reazionaria il superuomo nietzschiano.
Risulta forse ancora più interessante la personalità di Kurt Goldstein, ebreo agnostico, per tradizioni familiari orientato verso aspirazioni politiche di tipo socialista. Il suo tentativo scientifico era quello di conciliare una visione totalizzante delle scienze, conservando però la procedura rigorosa delle stesse. Egli cercò di liberare il teleologismo kantiano dalla gabbia della soggettività, per riuscire a trovarne delle tracce grazie a suoi studi sperimentali. Già negli anni precedenti la Prima Guerra mondiale aveva contestato –e ciò va a suo merito- le ricerche di carattere razzista; non che le trovasse inutili, ma riteneva che la problematica relativa all’«igiene della razza» dovesse concentrarsi non tanto sul tema della riproduzione, bensì su quello dell’adattamento dell’uomo allo stress imposto dalla modernità, nei confronti della quale anche Goldstein conservava un giudizio negativo.
Le sue più significative esperienze scientifiche risalgono al periodo in cui fu direttore di un ospedale militare, dedicato al sostegno terapeutico dei soldati che avevano subito traumi di guerra. Goldstein ritenne di avere individuato delle strategie compensative inconsapevoli messe in atto dal cervello danneggiato, che aveva perduto la capacità di pensare il mondo olisticamente. Veniva dunque messa in atto una nuova strategia per pensare la totalità, come mostravano i dati sulle relazioni figura-sfondo, impossibili secondo Goldstein da cogliere attraverso le categorie d’indagine tradizionali. Goldstein ne ricavò un’idea olistica di guarigione che si contrapponeva alla visione meccanicistica dell’organismo, capace secondo la sua visione di localizzare i sintomi, senza individuarne la funzione. Anche il suo lavoro interessò autori prestigiosi, a partire da quello del cugino Ernst Cassirer, il cui concetto di “forma simbolica” influenzò molto Goldstein. Ma risulta evidente anche la vicinanza con la teoria di Husserl e di Marleu-Ponty, notata dalla moglie di Erich Fromm, Frida Reichmann. Goldstein tenne anche seminari insieme al teologo Paul Tillich, che si ispirò alle sue teorie.
Con Goldstein, dunque, si realizzò un tentativo di sganciare la teoria olistica dalle derive irrazionali, per cercare di accordarla con un metodo riconosciuto dall’intera comunità scientifica. Arrestato e torturato all’avvento del regime nazista, Goldstein riuscì a essere liberato e poi a fuggire negli Stati Uniti grazie all’interessamento di Matthias Goering, fratello del gerarca del regime, eccentrico e che provava interesse per le teorie di Goldstein. Negli Stati Uniti, a differenza di Wertheimer, non si ambientò mai completamente. Mentre il primo negli USA pubblicò alcuni scritti di argomento politico, incentrati sulla superiorità del modello democratico, secondo argomentazioni che facevano riferimento a una rinnovata nozione di “verità”, Goldstein non condivideva l’ottimismo verso la natura umana, che sarebbe destinato a esprimersi al meglio in una società democratica; a suo dire infatti, in una situazione di catastrofe, il cosiddetto “uomo medio”, quello che in un regime democratico avrebbe dovuto essere maggiormente consapevole della positività del proprio sistema di vita, sarebbe stato in grado di cogliere i principi fondanti della democrazia. Le sue osservazioni sull’uomo medio -che riportiamo- risultano particolarmente interessanti, e ricordano lo sprezzante giudizio dato sullo stesso tema da Pier Paolo Pasolini, attraverso lo straordinario personaggio interpretato da Orson Welles ne La Ricotta: «il restringimento e la rigidità del loro mondo […], il loro rigido aggrapparsi a ideali e modi di vita del passato, la loro inacessibilità a nuove forme di idee, l’uniformità di comportamento, il loro essere orgogliosi di tutte le cose possedute […], la completa mancanza di comprensione di tutto ciò che è estraneo, la lotta contro le altre persone e le opinioni altrui, ingaggiata con una crudeltà e una passione fanatica […]».
Al di là dell’indubbio interesse di questa esaustiva analisi, è lecito chiedersi se sia possibile trarre una conclusione di carattere generale da questa lunga disamina, sia rispetto all’analisi specifica del periodo storico affrontato, sia in relazione a quel complesso problema dei rapporti scienza-cultura-politica, cui abbiamo fatto cenno all’inizio. Dopo un’analisi minuziosa l’Autrice, a conclusione della sua fatica, sembra in difficoltà nel proporre una propria valutazione riassuntiva. Da una parte rimane suo grande merito avere preso le distanze da qualsiasi impostazione deterministica, dall’altra questa scelta la conduce forse a non stringere sulle conclusioni. Ciò che la Harrington, nelle ultime pagine del libro, presenta come la tesi principale del proprio studio, ovvero avere mostrato come il discrimine tra scienza e pseudo scienza non sia nel presunto utilizzare, da parte della prima, «un freddo linguaggio trascendente di necessaria verità», sembra un po’ riduttivo, a conclusione di un’analisi così accurata. Più rilevante ci sembra l’osservazione, sicuramente di maggior peso teoretico e che poteva essere meglio valorizzata, relativa alla «forza e all’importanza del linguaggio», quando questo, in modo particolare attraverso l’uso della metafora, amplia l’autorità e la portata della scienza in generale: «l’adozione di un linguaggio normativo e di una metafora culturalmente evocativa può essere una modalità chiave attraverso cui la scienza, nella sua pratica, sovverte una distinzione che poi, nella sua retorica e nelle sue autorappresentazioni, difende ufficialmente e vigorosamente: una distinzione, talvolta descritta come “fatto” versus “valore”, tra il mondo della necessità naturale, da un lato, e il mondo delle scelte sociali e dei significati culturali, dall’altro».
Sembra in effetti che l’Autrice, nel timore di avanzare valutazioni complessive improprie, abbia esagerato nel ritrarre il proprio pensiero rispetto a conclusioni che potevano invece essere meglio esplicitate, i cui contenuti appaiono però fra le righe, senza conoscere tuttavia lo sviluppo che probabilmente avrebbero meritato. Nel tentativo di offrire un quadro di quanto sia rimasto dell’olismo successivamente alla Seconda Guerra mondiale, la Harrington propone alcuni riferimenti storici –dal movimento hippy degli anni Sessanta, alla contestazione ecologista al post moderno- troppo sbrigativi non tanto per risultare convincenti, quanto per dare origine a un quadro sistematico capace di giustificare tali relazioni.
Concordiamo sicuramente con l’atteggiamento trattenuto dell’Autrice nell’evitare di fornire uno schema manicheo, e quindi deterministico, sulle valenze ideologiche dell’olismo, e porre quindi la questione sul piano epistemologico, più essenziale e convincente. Da questo punto di vista le riflessioni del libro possono essere proiettate con grande efficacia euristica sui tempi presenti. Come rimarca la Harrington, non si tratta –allora e oggi- di stabilire una differenza tra “scienza giusta”, che corrisponde al proprio concetto, e “pseudo scienza”. Sicuramente le teorie olistiche presentano dei tratti di irrazionalismo evidenti, ma sarebbe altrettanto sbagliato non riconoscere loro, in certi casi, il giusto valore scientifico, nonché l’autorevolezza di alcune personalità di tale corrente. Più interessante è, a nostro parere, trasferire la discussione sul problema delle relazioni possibili (piuttosto che sul tema della demarcazione) tra ricerca scientifica e ambiti di ricerca relativi alle discipline storico-sociali. Se infatti un messaggio di estrema chiarezza emerge in modo netto dalla lettura de La scienza di nuovo incantata, è proprio quello della insostenibilità epistemologica, e delle pericolose conseguenze che ne derivano sul piano politico-sociale, di qualsiasi riduzione delle scienze sociali ai criteri d’indagine (che siano meccanicistici o fondati su una relazione analogica) delle scienze esatte. Nel momento in cui una interpretazione scientifica della natura cede alla pulsione imperialistica di estendere la propria metodologia di ricerca verso ambiti ad essa estranei (nei confronti dei quali è possibile sì realizzare un’appropriazione riduzionistica, ma solo attraverso una semplificazione insostenibile delle problematiche storiche e sociali) viene a realizzarsi un’azione culturale –ne siano o meno consapevoli i suoi attori- di tipo autoritario; di conseguenza, i principi che regolano ogni comunità per la soluzione dei conflitti tendono a non essere più individuati secondo le logiche della dialettica democratica, dove si dà per presupposto il possibile prevalere di qualsiasi posizione in gioco, sulla base di un compromesso di ragione. Ma non si tratta solo di limitare e di circoscrivere questo impeto di conquista del sapere scientifico, che ritiene di poter ridurre ai propri criteri la complessità sociale, bensì di valutare invece anche la necessità di una direzione opposta. Ovvero, nel momento in cui ci si trova di fronte a tematiche così decisive e, nello stesso tempo, tanto drammatiche e inquietanti, come quella relativa agli intellettuali che non si accorgevano di camminare su un pericoloso crinale, che li condusse a formulare giustificazioni teoriche per movimenti reazionari e criminali, non si può rinunciare all’approccio specifico delle diverse scienze sociali e, tanto meno, a una lettura storica e filosofica che si impone, proprio a partire dalla irriducibilità dei propri metodi, per problematizzare la pretesa assolutistica dei dati quantitativi e statistici. È il caso per esempio del tema (affrontato forse troppo fugacemente dalla Harrington) relativo alla capacità del regime nazista di cooptare –e fare in qualche modo partecipare al proprio disegno omicida- una gran numero di persone, la cui coscienza morale era comunque consapevole del carattere criminale delle azioni del regime cui pure si accettava di obbedire. Si tratta di un tema al centro di un importante studio di Alberto Burgio e Marina Lalatta Costerbosa (Orgoglio e genocidio, Derive e Approdi, Roma 2016), in cui sono esaminati i contributi di carattere metodologico provenienti dalle diverse scienze sociali – dal diritto, alla psicologia, alla sociologia e all’etica -, per individuare in conclusione l’irrinunciabilità di un’analisi specificatamente storica e filosofica, allo scopo proprio di valorizzare al massimo grado i contributi specifici delle altre aree disciplinari. Non per vantare una superiorità della filosofia e della storia rispetto agli altri ambiti di ricerca–una pretesa che oggi suonerebbe assurdamente anacronistica-, ma per dimostrare come, di fronte a certe tematiche, nessuna riduzione a dati quantitativi (nel caso dell’olismo diremmo invece: nessuna riduzione artificiale dei fenomeni all’interno di una totalità presupposta e non dimostrata) può risolvere un problema che vede la concorrenza di molteplici fattori, anche soggettivi, non prevedibili, e che necessità di una scavo interpretativo ben più profondo. La storia e la filosofia, intese non come discipline ingenuamente universalistiche, hanno la capacità di fondare una prospettiva intellettuale originale, in grado di far dialogare alla pari, in modo democratico, pluralistico, le più diverse aree disciplinari, comprese loro stesse, senza fondare false priorità.
Una deriva, quella del riduzionismo delle scienze sociali, storiche e filosofiche a puri apparati serventi delle scienze naturali ed esatte, particolarmente avvertita oggi in alcuni settori, come quelli dell’istruzione e della formazione. Dove la pretesa di poter determinare attraverso pratiche uniformi i processi di acquisizione cognitiva degli alunni –e dunque su questi impostare le unità didattiche, in base a criteri formalizzanti- diventa in realtà il pretesto per intervenire in modo arbitrario ma calcolato sui processi di soggettivazione, al fine di produrre personalità integrate, prive però della capacità critica di comprendere le caratteristiche del sistema mondo in cui sono inserite, del quale sfugge loro la genesi storica; venendo meno in loro la capacità di immaginarne una possibile trasformazione.
È interessante notare come tale nuovo pensiero pedagogico tenda a ridimensionare l’idea che il rapporto educativo si configuri come relazione dialettica, che produce processi e progetti di costruzione del sapere continuamente da riconfigurare, a seconda di come procede nel tempo il rapporto tra maestro e allievo; e proponga in alternativa l’idea di poter pianificare, in un’ottica evidentemente deterministica, i comportamenti attesi dal destinatario dell’educazione. Una modalità di concepire la relazione educativa distante dal modello dialogico democratico, che si riduce a pura operatività tecnocratica; giustificata però in nome di presupposti scientifici ormai irrinunciabili che ne fonderebbero l’apparato teorico. Il risultato auspicato da tale “didattica innovativa”, da raggiungere attraverso un criterio di valutazione rigorosamente quantitativo, sarebbe la costruzione di una soggettività totalmente integrata in un sistema chiuso –al giorno d’oggi identificato con l’apparato produttivo e con le spietate leggi del mercato del lavoro. Un’idea di naturalizzazione della psiche non molto diversa dalle pretese che la Harrington ha mostrato affermarsi proprio nelle fasi più discutibili della ricerca olistica.
Non ci sembra affatto casuale, dopo la lettura de La scienza di nuovo incantata, che i teorici del pedagogismo utilizzino in modo ostinato –per descrivere l’originalità del loro approccio educativo- l’espressione «olistico». Intesa non nel suo possibile significato emancipativo, ovvero come la consapevolezza critica acquisita dei principi che regolano il contesto sistemico di cui si fa parte, per poterne eventualmente proporre la trasformazione; bensì come indicazione di un’unità psicologica in base alla quale il contenuto studiato si integra completamente al vissuto di chi lo fa proprio, senza che si conservi quello sguardo esterno e oggettivante proprio di qualsiasi sapere critico, che si attiva in primo luogo dalla coscienza che esistano punti di vista anche radicalmente diversi dai propri. In questo modo il soggetto risulterà perfettamente integrato (olisticamente) nell’apparato che pretende da lui solamente specifiche prestazioni, pregiudicando inevitabilmente la sua libertà di riflessione.