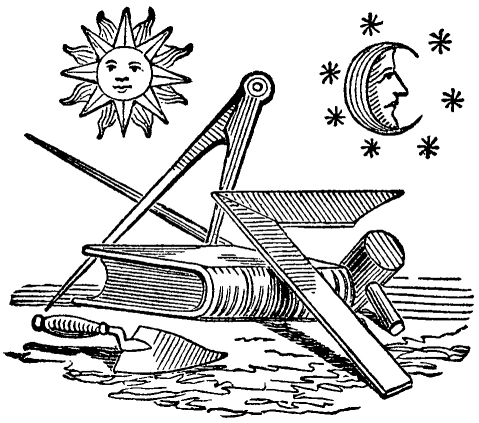Recintare lo spazio. Su Histoire politique du barbelé di Olivier Razac
Review of: Olivier Razac, Storia politica del filo spinato. Genealogia di un dispositivo di potere, Ombre Corte, Verona 2017, pagg.157, 14 euro
E’ possibile scrivere una storia politica di un oggetto così ordinario come il filo spinato? E’ questa la sfida che si è posto Olivier Razac, Maître de conférences in filosofia presso l’Universita di Grenoble e autore di diverse opere tra cui L’écran et le zoo. Spectacle et domestication, des expositions coloniales à Loft Story [Denoel, 2002]; La grande santé [Climats/Flammarion, 2006]; Avec Foucault, après Foucault. Disséquer la société de contrôle [L’Harmattan, 2008]. Una sfida vinta dall’autore con il libro appena tradotto da Ombre Corte, pubblicato originariamente nel 2000 e rielaborato nel 2009 (a questa edizione si riferisce la traduzione italiana). Il suo intento è una ricostruzione del valore e degli usi politici di questo oggetto che, da subito, è stato utilizzato ben al di là dell’ambito per cui è stato realizzato. Inventato originariamente nel 1874 da un agricoltore americano, Joseph Glidden, per recintare le distese di terra dislocate nelle Grandi Pianure, il filo spinato è diventato immediatamente uno strumento politico di primaria importanza. Il suo “successo” è indubbiamente legato alla versatilità e alla facilità di impiego, «si tratta, infatti, di due fili di ferro ritorto e tagliato obliquamente alle due estremità» (p.23). Inizialmente Glidden stringe una serie di spine sull’unica distesa di filo ma, ben presto, si rende conto di come le spine si allentino e scivolino. «E’ allora che ha l’idea geniale di rinforzare il suo dispositivo, attorcigliando un secondo filo attorno al primo e alle sue spine. In questo modo le spine risultano bloccate e l’insieme molto più resistente» (p. 23).
In meno di un secolo e mezzo, il filo spinato è stato utilizzato per recintare la terra degli indiani d’America, per imprigionare intere popolazioni durante la guerra d’indipendenza di Cuba (1895-1898) o la seconda guerra boeri in Sudafrica (1899-1902); è diventato tristemente celebre come perimetro delimitativo delle trincee della prima guerra mondiale, ma anche come archetipo della violenza insensata delle guerre industriali, attraverso il tragico utilizzo fatto dai nazisti che lo hanno disteso per recintare i campi di concentramento e di sterminio. Un’invenzione semplice, dal largo e attuale uso – case, giardini, fabbriche, caserme –, che ha conosciuto uno sviluppo e un destino tragico, capace di segnare l’immaginario collettivo, basti pensare ai corpi appesi dei tanti fuggiaschi che sulle spine di qualche filo hanno conosciuto la morte. Eppure l’iniziale destinazione d’uso di questo oggetto qualunque è legato alle dinamiche dell’espansione verso Ovest dei pionieri americani, al bisogno di controllare gli spazi immensi in cui le mandrie si disperdono e più facilmente sono «esposte ai pericoli del viaggio e ai rigori del clima» (p.24). La sua funzione determina «la possibilità per i coloni di insediarsi e coltivare la prateria» (p.25). In breve il filo spinato si afferma grazie alla «sua leggerezza come articolo da trasporto e da costruzione, alla sua applicabilità» (p.25) e versatilità. Non soltanto dissuade gli animali dal forzare le recinzione, ma ben presto consente la stessa espansione dei coloni a danno dei nativi costretti dalle successive frontiere a «integrarsi, divenendo cittadini degli Stati Uniti» (p.27). Forse in questo passaggio c’è la svolta verso una storia sempre più mercata di esclusioni, di marginalizzazioni, di rifiuti.
Da questo momento in avanti il filo spinato diviene a tutti gli effetti un oggetto in grado come pochi altri di rappresentare i processi di allontanamento e di estromissione attraverso cui ogni società costruisce le proprie dinamiche identitarie. Per questo assume il valore di «paradigma» nel senso descritto da Giorgio Agamben, vale a dire di «oggetto singolare che, valendo per tutti gli altri della stessa classe, definisce l’intelligibilità dell’insieme di cui fa parte e che, nello stesso tempo, costituisce»1. Cosa vuol dire? Che il filo spinato è al contempo un attrezzo agricolo che può essere utilizzato per recintare campi, pascoli, stadi, prigioni e, insieme, il modello che rappresenta la prassi dell’esclusione, della segregazione e del controllo dello spazio. Ma, come sostiene Razac, «non si tratta, […], di fare del filo spinato il solo o il “migliore” dei simboli dei campi e dell’oppressione. Il campo non può essere ridotto al filo spinato; al contrario, è il filo spinato che è diventato “concentrazionario”. […] Non è più “là dove ci sono fili spinati, c’è la brutalità del potere”, ma “si riconoscerà un’applicazione brutale del potere in presenza di fili spinati o di dispositivi equivalenti” (p.55). Ciò fa del filo spinato un operatore biopolitico eccezionale in grado di sancire il confine tra chi deve essere integrato e chi deve essere escluso. Questa soglia, come ha tristemente insegnato il Novecento, è sempre sul punto di degenerare in tanatopolitica, sancendo il discrimine tra chi può vivere e chi deve essere lasciato morire.
Pensare al filo spinato significa dunque non soltanto avere a che fare con un oggetto in grado di svolgere – più o meno bene – alcune funzioni, ma significa anche, come sottolinea Razac, entrare in un doppio registro rappresentativo che sovradetermina la cosa e evoca la storia tragica del Novecento, dei campi di sterminio, di quelle comunità recintate che, un po’ dovunque, continuano ad essere ghettizzate, anche all’interno degli stati di diritto. In tal senso la storia del filo spinato è ancora attuale e si sovrappone a quella dei muri eretti in tutto il globo. Come sostiene Wendy Brown, docente di Political Science a Berkeley, che dell’argomento si è occupata in Stati murati, sovranità in declino, «ciò che siamo arrivati a definire mondo globalizzato alimenta tensioni fondamentali tra aperture e barricate, fusioni e partizioni, cancellazioni e reiscrizioni»2. E negli spazi creati dalle barriere si cerca di istituire nuovi confini e inedite frontiere entro cui esercitare forme di micro-sovranità locale, esercizi di discrimine nei confronti di attori transnazionali non statuali, come i migranti o i gruppi identificati come “terroristi”. Il filo spinato, quindi, come i tanti muri che vanno moltiplicandosi per il globo, dividendo e ponendo confini all’interno degli stati-nazione, configura la propria presenza al di fuori del sistema vestfaliano, senza per questo rinnegarlo. Stabilire divisioni all’interno dei confini nazionali, infatti, pone in essere un cortocircuito tra dimensioni diverse, statuali e transnazionali, che rende ancor più problematica la classica divisione tra interno o esterno, tra politico e impolitico, tra chi osserva e chi è osservato. Come sostiene l’Autore: «questo meccanismo di ripartizione funziona del resto in modo reversibile, nel senso di una esclusione (che è anche inclusione) verso gli spazi degradati, se questi non sono abbandonati, o nel senso di una inclusione (che è anche esclusione) negli spazi valorizzati» (p. 151).
In conclusione, nelle tre parti, più epilogo, in cui si snoda il percorso teorico di Razac, il lettore ha la possibilità di seguire l’evoluzione dell’uso del filo spinato, da strumento utile per controllare il pascolo dei bovini a dispositivo utile per sottoporre gli uomini a un regime di vigilanza sempre più efficace. Se questo percorso si snoda inizialmente dal conflitto ispanico-americano del 1898 alla guerra russo-giapponese del 1904-1905, nell’epilogo Razac lo chiude con una breve analisi del “controllo elettronico mobile” (PSEM), un dispositivo di sorveglianza per soggetti sottoposti a speciali misure di controllo. Istituito in Francia, con una legge del 2005, consente di «sapere sempre dove si trova la persona, e anche verso dove si dirige» (p.155), attraverso l’invio del segnale a un centro di controllo che supervisiona la situazione in tempo reale. Razac, con questo epilogo, chiude una storia che ha nella virtualizzazione del dispositivo il punto di arrivo di una delimitazione – e individuazione – nello spazio “quasi perfetta”: sorvegliare e controllare 24 ore su 24 il soggetto virtualmente chiuso in uno spazio coincidente con la propria esistenza. Bisogna chiedersi a questo punto: alla luce di ciò quali spazi di libertà restano al soggetto? Ed è su questo interrogativo che Razac sembra lasciare il lettore alle proprie riflessioni, nello spirito di una “storia del presente” che foucaultianamente apre alla problematizzazione verso il futuro.
.