Uno statista leggendario, il mondo che cambia e uno scacchiere diplomatico in fermento
Francesco Crispi e l’Italia coloniale nell’ultimo libro di Luciano Monzali
Il rapporto fra Francesco Crispi e il colonialismo italiano è il tema del nuovo saggio di Luciano Monzali, ordinario di Storia delle relazioni intenzionali all’Università di Bari, affermato e prolifico di studi sulla storia della politica estera italiana.
Il tema è stato precedentemente affrontato da studiosi quali Mondaini, Ciasca, Conti Rossini, Giglio, Zaghi, Mori, Del Boca, Labanca, Taddia, Grassi Orsini, Podestà, Francioni, Natili, e a livello internazionale da Hess, Duggan, Miège, Milza, Caulk, Jonas. Monzali innova l’argomento con uno studio approfondito delle fonti documentarie edite, come quelle italiane (la serie “L’Italia in Africa”) nonché francesi e tedesche. Da queste ricerche nasce il volume Guerra e diplomazia in Africa orientale. Francesco Crispi, l’Italia liberale e la questione etiopica, Biblioteca di Nuova Rivista Storica, Società Editrice Dante Alighieri (Roma, 2020).
L’autore propone un’accurata ricostruzione della genesi del colonialismo italiano, a partire dall’acquisizione della baia di Assab. Nella seconda metà dell’Ottocento la classe dirigente liberale cercò di porsi sulla scia delle grandi potenze coloniali, assecondando esigenze nazionali e ansie internazionali tipiche dell’era dell’imperialismo. Come precisa Monzali:
“Stato fragile al proprio interno, indebolito da profonde divisioni regionali, dipendente economicamente dall’estero, l’Italia liberale vide nella partecipazione al processo di spartizione imperialistica dell’Africa e dell’Asia un modo di tutelare i propri interessi vitali sul piano economico e strategico di fronte a potenze europee assai più forti e dinamiche”.
Sul piano della politica interna l’autore evidenzia come il primo colonialismo si saldasse all’industrializzazione del Paese, alla necessità di fornire materie e sbocchi alla marina mercantile e all’industria siderurgica, mentre si avviava quel processo di vasta emigrazione che a sua volta avrebbe conferito al tradivo colonialismo italiano significati socio-demografici. Sorgeva nel Paese il cosiddetto Partito coloniale, politicamente trasversale e eterogeneo, “in sostanza una lobby imperialista”. Attento studioso di storia diplomatica, Monzali chiarisce bene come l’avvio del colonialismo italiano avvenga nell’alveo di una politica estera fragile, tutta incentrata sul gioco diplomatico e volta a sottrarre il regno alla condizione di isolamento internazionale. Per questo furono da subito coltivati i rapporti con tutte le principali potenze europee e neppure la ricerca di alleanza poteva risultare esaustiva dell’interesse nazionale.
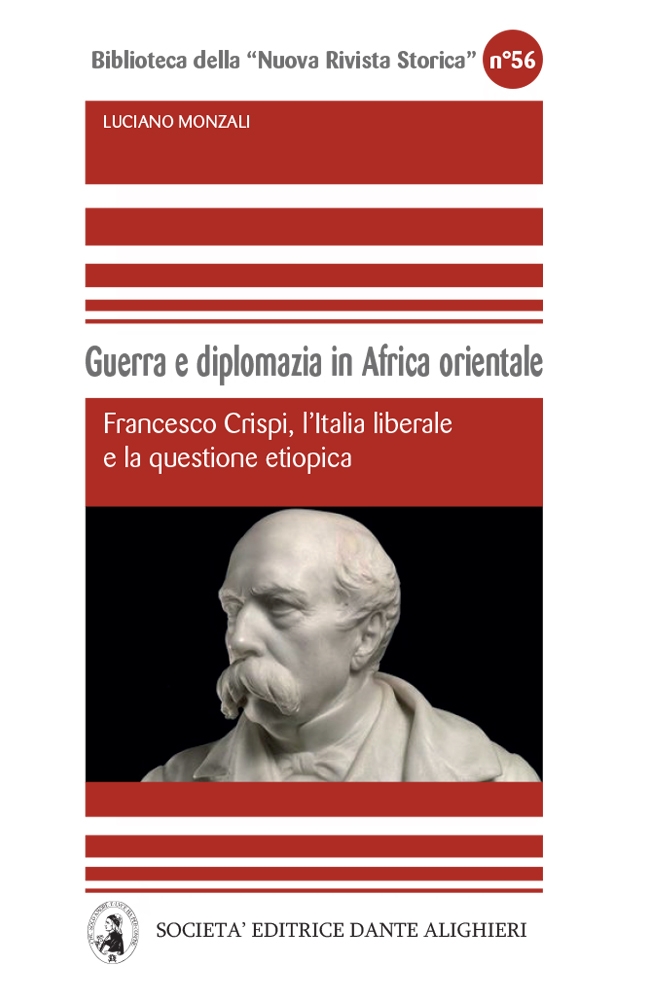 Gli sviluppi mediterranei del periodo indussero la classe dirigente liberale ad ampliare ben presto l’ampiezza della politica estera, fra crisi balcaniche e questione tunisina. Proprio la perdita della Tunisia, ad opera della Francia, impose una svolta politica profonda con l’avvento del governo Depretis e l’ingresso nella Triplice Alleanza. Il nuovo ministro degli Esteri Mancini precisò che l’avvicinamento agli imperi centrali non doveva essere inteso come un atto di ostilità contro la Gran Bretagna, indispensabile per la tutela del nascente interesse coloniale italiano. Se la politica estera del regno fu difficoltosa, tipica di un Paese emergente che cercava di inserirsi fra le potenze europee in condizioni di inferiorità, quella coloniale fu addirittura rischiosa, foriera di potenziali conflitti e gravemente carente di risorse finanziarie e militari. In pratica, osserva lo storico, si fece leva sulla sola diplomazia.
Gli sviluppi mediterranei del periodo indussero la classe dirigente liberale ad ampliare ben presto l’ampiezza della politica estera, fra crisi balcaniche e questione tunisina. Proprio la perdita della Tunisia, ad opera della Francia, impose una svolta politica profonda con l’avvento del governo Depretis e l’ingresso nella Triplice Alleanza. Il nuovo ministro degli Esteri Mancini precisò che l’avvicinamento agli imperi centrali non doveva essere inteso come un atto di ostilità contro la Gran Bretagna, indispensabile per la tutela del nascente interesse coloniale italiano. Se la politica estera del regno fu difficoltosa, tipica di un Paese emergente che cercava di inserirsi fra le potenze europee in condizioni di inferiorità, quella coloniale fu addirittura rischiosa, foriera di potenziali conflitti e gravemente carente di risorse finanziarie e militari. In pratica, osserva lo storico, si fece leva sulla sola diplomazia.
È in questo contesto generale che uomini e leader come Depretis, Mancini e Crispi vengono correttamente accomunati nel medesimo filone politico: quello dei patrioti già protagonisti del Risorgimento e della fondazione del regno unitario, determinati a guidare il Paese nel fiume impetuoso dell’imperialismo. Essi non tradirono l’originario spirito libertario, né quel principio di nazionalità che continuò a informare la politica estera italiana. Piuttosto presero atto dei tempi e delle esigenze del Paese, al quale sarebbe stata preclusa qualsiasi autentica prospettiva di consolidamento interno e di modernizzazione se si fosse estraniato dalla competizione globale. Tutti attribuivano interesse prioritario al Mediterraneo affinché l’Italia non restasse accerchiata nel suo stesso ambito geopolitico.
Ben presto emerse – sia per ragioni di debolezza che per il carattere aspro della contesa interna al bacino, a seguito dell’apertura del canale di Suez e dopo l’occupazione francese della Tunisia – che le chiavi del Mediterraneo, per dirla con Mancini, potevano essere trovate nel Corno d’Africa.
Il discorso di politica estera era piuttosto complesso: occorreva mettere assieme i partner della Triplice Alleanza con la Gran Bretagna, in una fase in cui l’antagonismo anglo-tedesco andava facendosi globale, ma senza irritare eccessivamente la Francia o inimicarsi del tutto la Russia. Per preservare questa delicatissima trama diplomatica nel 1882 Depretis lasciò cadere la proposta britannica di intervento congiunto in Egitto. Inoltre il sentiero della politica coloniale italiana si presentava assai stretto e impervio, come dimostrò il primo incidente militare, occorso a Dogali nel 1887. Travolto dalla disfatta, Depretis dovette formare un nuovo governo imbarcando anche gli antagonisti Zanardelli e Crispi, il quale pochi mesi dopo fu chiamato ad assumere la guida dell’esecutivo e della Consulta.
La figura del politico siciliano, già garibaldino e mazziniano, è stata studiata fra gli altri da Duggan (2000), Romano (1986) e Saija (2019), i quali hanno evidenziato come da tempo egli incalzasse i governi chiedendo un’interpretazione più attiva della Triplice Alleanza e una politica estera più assertiva, in particolare nel Mediterraneo. La politica estera di Depretis e Mancini, rei di aver lasciato cadere l’allettante invito britannico in Egitto, era stata “borghese ed imbelle”, mentre la Francia, dopo la presa di Tunisi, si profilava come “minaccia mortale per l’Italia”. Il rilancio internazionale del regno doveva passare per un rafforzamento dei rapporti italo-tedeschi, personalmente coltivati dal politico siciliano con l’amicizia per Bismarck. Sul piano coloniale egli intese ribadire la centralità mediterranea, considerando Massaua come un inutile spreco di risorse. In realtà Crispi si tenne all’interno del solco tracciato dai predecessori: pur rinnovando i ranghi della diplomazia non potè totalmente rimuovere l’influenza di personalità quali Tigra, Lanza e Corti, oltre che della stessa corona. Massaua fu pertanto mantenuta per ragioni di prestigio.
Si pose così il problema di trovare una pacifica convivenza, dopo Dogali, con gli abissini capeggiati dal bellicoso negus neghesti Giovanni IV. Lo scioano Menelik si propose quale mediatore. Fu su questo terreno che l’Italia cercò la difficoltosa sintesi fra gli equilibri internazionali e l’interesse per l’Abissinia, che poteva essere coltivato solo ottenendo il benestare delle maggiori potenze. La diplomazia entrò in scena dopo la scomparsa di Giovanni IV e l’emergere della candidatura di Menelik, che l’Italia decise di sostenere investendo sul consolidamento dell’Abissinia, anziché sul suo sfaldamento. Grande fautore della politica scioana dell’Italia fu il conte Antonelli, promotore dell’accordo di Uccialli, negoziato con Menelik. In questo caso lo strumento diplomatico avrebbe dovuto predisporre il “lento e progressivo assorbimento economico e politico” dell’Abissinia da parte dell’Italia.
Tuttavia fu proprio Crispi a forzare l’interpretazione dell’accordo, presentato alle maggiori potenze come il riconoscimento del protettorato italiano sulla regione in base al controverso art. XVII. Ipotesi apertamente respinta dalla Russia, criticata dalla Francia ed energicamente avversata dallo stesso Menelik sulla base, altrettanto dubbia, delle divergenti versioni italiana e amarica del testo dell’accordo. L’avvio della penetrazione segnò la sconfitta del partito dei tigrini, coloro che si opponevano a un’espansione della sfera di influenza italiana e segnalavano i rischi di una forzatura. Il deterioramento dei rapporti italo-abissini e il venir meno dell’appoggio internazionale all’azione dell’Italia erano pertanto già in corso quando, nel 1891, Crispi si dimise.
A capo del nuovo governo, Di Rudinì optò per una politica di raccoglimento che permise di ottenere momentanei frutti diplomatici come l’accordo del 1891 con gli inglesi, che portò al riconoscimento di un’influenza italiana sull’Abissinia, mentre Menelik si rivolgeva direttamente a re Umberto per chiedere l’annullamento dell’art. XVII.
“Invecchiato e amareggiato” per essere stato scavalcato da Giolitti nella considerazione di re Umberto, Crispi tornò alla guida del governo nel 1893 in un frangente particolarmente critico, segnato dai Fasci siciliani e dalla crisi finanziaria. Sul piano internazionale la tensione con la Francia raggiunse l’apice a seguito dell’eccidio dei lavoratori italiani ad Aigues Mortes. La guida della politica estera venne affidata al Blanc, fervente triplicista e francofobo. Per il Corno d’Africa in tali condizioni si imponeva la linea del raccoglimento, affidata in particolare ad Antonelli, nominato sottosegretario agli Esteri. Tuttavia, a partire dal 1892, fu il nuovo governatore dell’Eritrea Oreste Baratieri – altro uomo del Risorgimento e parlamentare della Sinistra – ad assumere la conduzione sul campo della crisi.
Ambizioso e superficiale, egli contraddisse apertamente la via della prudenza e con una politica di lenta penetrazione indusse Menelik a denunciare il trattato di Uccialli. In aperto contrasto con Antonelli e Blanc, Baratieri si rivolse direttamente a Crispi per sostenere le ragioni di una politica espansionista potendo contare sull’appoggio del ministro della Guerra, Mocenni. Giocando sulle divisioni e sull’impulsività del capo del governo, “molto abilmente Baratieri riuscì a bloccare la strategia di raccoglimento di Antonelli, impopolare fra i militari in Italia e in Africa”. Da parte sua Menelik si trovò sempre influenzato dalla corte che chiedeva la guerra confidando nell’appoggio francese. Forse la critica più acuta alla politica di penetrazione venne dall’ambasciatore Tornielli, il quale osservò come il presupposto dell’espansionismo italiano in Africa orientale, il benestare anglo-tedesco, fosse inconsistente a causa del crescente antagonismo fra le due potenze. Per questa critica Tornielli fu rimosso dall’ambasciata di Londra e inviato a Parigi.
Come rileva Duggan, Crispi legò il proprio prestigio personale a quello militare di Baratieri e non trovò opposizioni insormontabili all’interno del governo, neppure nel ministro del Tesoro Sonnino, preoccupato del costo di certe imprese ma non ostile di principio all’espansionismo. L’occupazione estesa sino ad Adua ebbe l’effetto di rendere coese le fazioni abissine, solitamente contrapposte, consentendo a Menelik di allestire un esercito considerevole. “Ormai il Tigré è aperto all’Italia, sarà indulgenza nostra se non vorremo occuparlo”, osservava con spavaldo Crispi proprio mentre il governatore cominciava a farsi incerto. Nel dicembre 1895 la perdita dell’unità del maggiore Toselli, massacrata all’Amba Alagi, indusse a un doloroso ripensamento e anche Mocenni dimostrò di non aver più fiducia in Baratieri.
Nonostante le perplessità sempre più diffuse, occorre rilevare come i politici italiani ritenessero in larga parte ormai acquisito e irrinunciabile il Tigrai, mentre Menelik avrebbe offerto la pace in cambio della rinuncia a questa regione e alla pretesa di protettorato. Si è ipotizzato che Baratieri si sia risolto all’ultimo fatale passo sapendo che dall’Italia era già partito il suo sostituto, Baldissera. Di certo lo influenzò il telegramma del 25 febbraio con il quale Crispi definiva “tisi militare”, non guerra, la crisi in corso con gli abissini. Pochi giorni dopo si consumò la storica disfatta di Adua, che pose termine alla carriera politica dello statista siciliano. L’erede di Baratieri, Baldissera, si trovò a difendere l’Eritrea in condizioni di emergenza, potendo contare sulla fedeltà dei locali e sulla moderazione di Menelik, desideroso della pace. Seguirono lunghi e penosi negoziati, i cui unici punti fermi furono l’abrogazione del trattato di Uccialli e la definitiva rinuncia italiana al protettorato.
Mentre Tornielli riannodava i fili dei rapporti con la Francia, il 26 ottobre Nerazzini e Menelik raggiungevano l’accordo di pace sulla base dell’indipendenza abissina e dell’impegno a affrontare la questione confinaria. Un altro accordo portò alla liberazione dei prigionieri italiani dietro pagamento di un cospicui contributo, in realtà un indennizzo di guerra celato, per nascondere la realtà della sconfitta. Pur umiliata, l’Italia non dovette cedere altre terre, e l’arroccamento in Eritrea, come rileva Monzali, nel lungo termine contribuì a plasmare i caratteri identitari dei locali, rispetto a quelli abissini. Il partito di coloro che vollero mantenere quel lembo di terra in Africa orientale prevalse, condizionando la futura politica estera italiana e della regione africana.

Luciano Monzali – Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Politiche
Luciano Monzali ricostruisce con grande accuratezza un percorso storico che non è solo di politica coloniale e di diplomazia, ma una più articolata pagina della storia del Regno d’Italia. Da essa è possibile cogliere l’evoluzione politica delle forze risorgimentali che cercarono di rendere il Paese partecipe dei grandi disegni globali della seconda metà dell’Ottocento. Monzali ben evidenzia come al primo colonialismo italiano difettassero conoscenze sul campo, esperienza, risorse militari ed economiche, ma anche una visione politica coerente e stabile. Alle continue oscillazioni fra espansionismo e raccoglimento si aggiunsero quelle fra i fautori del partito scioano e di quello tigrino, fra politici e militari.
Molte furono le leggerezze e le contraddizioni, a partire dall’incapacità di pensare in termini sistemici la valenza geopolitica del Corno d’Africa. Si favorì il consolidamento politico-militare di un regno che si voleva assoggettare, come colse Kitchner, che di affari coloniali aveva una certa pratica; quando più era opportuna la pace la si respinse provocando una guerra alla quale si era massimamente impreparati, come sarebbe avvenuto anche in pagine più tragiche di storia nazionale. Adua culminò le ambiguità nella catena di comando fra politici e militari, difetto strutturale in un Paese che da Statuto albertino di fronte al sovrano rimpiccioliva i politici e ingigantiva i comandanti militari. Crispi si collocò al centro di questo vortice, fra ambizione e improvvisazione, cercando di far leva soprattutto sulla diplomazia, alla quale finì per chiedere troppo e senza ascoltare il parere dei più esperti. Il disegno di grandezza non sarebbe sfumato dopo Adua, riemergendo molti anni dopo nel Mediterraneo, con un uomo più prudente, Giolitti. Trasformazione politica nazionale e mire coloniali furono due costanti del Regno d’Italia, della Destra come della Sinistra.
Accurato saggio di storia coloniale e diplomatica, costruito con ampiezza di fonti primarie, di grande chiarezza, il volume di Luciano Monzali ha anche il non trascurabile merito di riproporre la questione coloniale italiana nella più corretta prospettiva storiografica, che è quella dei tempi e dei relativi processi politici.













